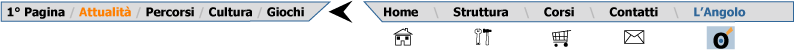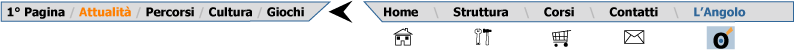|
|
NUOVE
TECNOLOGIE:
"UN C@PPUCCINO PER UN PC"
Il Governo promuove la diffusione del pc tra gli studenti
delle università italiane, lanciando, a partire già
dal prossimo anno accademico, l'operazione "Un c@ppuccino
per un pc". Sulla scia delle precedenti iniziative che
hanno consentito l'acquisto di pc da parte dei più
giovani, delle famiglie a basso reddito e dei dipendenti pubblici,
l'iniziativa appena varata prevede la creazione di un fondo
di garanzia di 2,5 milioni di euro per il 2005, al fine di
facilitare l'accesso al credito bancario da parte degli universitari,
che potranno così acquistare un pc portatile, dotato
di connessione Internet anche wi-fi. In particolare, sarà
concesso agli studenti più meritevoli, in regola con
l'iscrizione ed esentati dal pagamento delle tasse e dei contributi
universitari, un bonus governativo di 200 euro. Il prestito
agevolato, garantito dallo Stato, verrà rimborsato
(mediamente) con un euro al giorno - che è, appunto,
il prezzo di un cappuccino -, entro un arco di tempo che andrà,
in relazione all'entità del prestito, da un minimo
di 18 ad un massimo di 24 mesi.
|
Torna
su
|
Gli
americani sparano ad una cometa e a Mosca si arrabbiano
di Antonino Pingue
Capitano
cose strane in questo nuovo secolo. Fra queste l’ultima
novità è che gli americani si sono messi a sparare
alle comete (anche…). Niente paura: le ragioni dell’attacco
non sono di carattere militare. La cometa non era sospettata
di attività terroristiche, non era insomma una “cometa
canaglia”, né la sua distruzione è da
archiviare in una “guerra preventiva” al prossimo
venturo Natale. Le ragioni sono invece di carattere squisitamente
scientifico. |
 |
Ecco perché, nella notte fra il 3 e il 4 luglio, una
sonda spaziale della Nasa si è avvicinata ed ha colpito
la cometa Templ 1.
La sonda, grande come una lavatrice, ha compiuto tre manovre
nel corso di due ore di missione - da quando cioè è
stata sganciata dal razzo Deep Impact - e si è schiantata
contro la cometa in perfetto orario, inviando immagini del suo
terreno roccioso fino a circa 3,7 secondi prima dell'impatto.
Un'immagine dello schianto scattata alle 7.52 da Deep Impact
mostra una vampata brillante di materiale che proviene dalla
parte posteriore della cometa.
«Abbiamo colpito esattamente dove volevamo farlo»,
ha detto Don Yeomans, uno scienziato del Jet Propulsion Laboratory
Nasa. La spettacolare collisione, avvenuta a 134 milioni dalla
terra, è riuscita a far scaturire uno "spruzzo"
di materia sottostante, materiale che si è formato miliardi
di anni fa durante la creazione del sistema solare e che ora
potrà essere studiato dagli scienziati.
«Ora, credo che abbiamo una comprensione completamente
diversa del nostro sistema solare» ha detto il direttore
del laboratorio, Charles Elachi. «Il nostro successo va
oltre le nostre aspettative».
«L'impatto è stato più grande di quanto
mi attendessi, più grande di quanto ci aspettassimo -
ha detto Yeoman - abbiamo tutti i dati che potevano chiedere
e il team scientifico è in estasi».
Meno in estasi è andata la signora Marina Bai, astrologa
russa, (badate bene, astrologa non astronoma) che ha fatto causa
per danni (300 milioni di dollari) alla Nasa, accusata di aver
modificato il suo oroscopo.
«E' ovvio che l'esplosione muterà alcuni elementi
dell'orbita della cometa, interferendo così con il mio
lavoro e sconvolgendo il mio oroscopo» ha dichiarato l'astrologa
“professionista” nei documenti legali consegnati
con la denuncia.
La portavoce di una Corte di distretto di Mosca ha dichiarato
che sono in corso i preparativi per il caso, ma non ha svelato
la data d'inizio dell'udienza.
I rappresentanti della Nasa a Mosca non erano reperibili per
fare commenti sulla questione. |
Torna
su
|
A
proposito dello spessore morale degli italiani
di Enzo Russo |
 |
Nella
sua rubrica Buongiorno su La Stampa di Torino il 22 giugno
u.s. Massimo Gramellini ha pubblicato il suo blog "Anomalo
nella norma" che la dice lunga sullo spessore morale
degli italiani, secondo il Cardinale Ruini, dimostrato in
occasione del referendum sulla fecondazione assistita. Lo
riporto integralmente per chi non l'avesse letto.
"A Bologna una ragazza viene violentata
al parco e i cittadini si voltano dall’altra parte.
A Napoli la polizia insegue due banditi, uno dei quali arrestato
il 6 giugno ma scarcerato il giorno dopo, e qui in effetti
i cittadini passano all’azione: tirando le pietre agli
agenti. La politica oppone al dissesto morale le sue banalità
automatiche. Il bau-bau da bar dei leghisti che straparlano
di castrazioni ma non riescono neppure a scrivere una legge
che equipari lo stupro all'omicidio volontario. E i sociologismi
della sinistra da salotto che dà sempre la colpa di
tutto alla carenza di lavoro, senza spiegarci perché
il lavoro scarseggia ovunque ma certe cose succedono soltanto
a Napoli. Un intero quartiere prende a sassate lo Stato per
difendere dei criminali comuni e il sindaco Iervolino, anziché
chiedere scusa per come le istituzioni non insegnano l’educazione
civica agli amministrati, riesce solo a dirci che si tratta
di un fatto «anomalo», dato che i rivoltosi non
erano parenti dei banditi. Il loro è stato uno slancio
disinteressato, non come quello del giovane lasciato dalla
ragazza che ieri ha sparato per la strada alla madre e al
fratellino della sua ex.
Fossi
un napoletano perbene, sarei stufo di veder insultata la mia
città e farei qualcosa di visibile per prendere le
distanze da certi compaesani: una marcia come quella dei quarantamila.
Fossi poi una Clementina in vena d’eroismi, lascerei
perdere Kabul e proverei a penetrare nel quartiere di Scampia
con una copia della Costituzione fra le mani".
Ulteriori
approfondimenti sul suo Blog http://enzorusso2020.blog.tiscali.it/
|
Torna
su
|
Dell’esito
del referendum e della morale degli italiani.
di Enzo Russo
Solo
il 25,9% degli aventi diritto ha partecipato al referendum.
Una sconfitta sonora per quelli che lo hanno voluto. Si è
chiesta agli italiani la loro opinione su questioni molto
complesse, difficili e dalle forti implicazioni etiche. Gli
italiani (cattolici e non), a stragrande maggioranza, si sono
rifiutati di darla. |
 |
| Si
è detto che alcuni partiti hanno vinto ed altri hanno
perso e molti hanno ammesso apertamente la sconfitta. Il discorso
tiene fino ad un certo punto. Si trattava infatti di un voto
di coscienza informata, di un voto trasversale e quindi i
partiti c’entrano sino ad un certo punto. Correttamente
alcuni di essi hanno lasciato libertà di coscienza
anche se questo non ha impedito che svolgessero attività
di orientamento. E’ loro compito cercare di aiutare
i loro elettori ad formarsi un opinione consapevole ed informata.
Da questo punto di vista sono risibili le critiche prospettate
nei confronti di alcuni leader che hanno avuto il coraggio
di assumere posizioni anche in contrasto con i loro stessi
partiti.
Ma durante
questa consultazione è avvenuto qualcosa di anomalo.
Si è formato un partito trasversale: quello dell’astensione
apertamente voluto e sostenuto dalla Chiesa Cattolica. Premetto
che questa ha tutti i diritti per intervenire in materia che
ha forti risvolti etici. E’ innegabile tuttavia che
la sua potente macchina organizzativa ha alterato il gioco
democratico. La sua incitazione all’astensione è
stata efficace ma di dubbio valore morale.
Si è
detto che alla sconfitta hanno concorso diversi fattori quali
l’abuso e l’usura dello strumento referendario,
l’opinione circa la sua inutilità perché
in altre occasioni non si è tenuto conto dei risultati,
della stanchezza della gente che trova difficile partecipare,
del distacco della classe dirigente rispetto al Paese reale,
ecc.. In tutte le spiegazioni c’è qualche elemento
di verità ma c’è un altra spiegazione
che, secondo me, ha concorso a determinare in modo non secondario
il risultato. Di essa uomini politici e commentatori non parlano
apertamente per opportunismo o ipocrisia.
Moltissimi
italiani si sono uniti al partito dell’astensione per
ignavia. Non trovo convincente – anche se vorrei tanto
crederci – la spiegazione del Cardinale Ruini secondo
cui avrebbe vinto “la coscienza morale degli italiani”.
Vorrei tanto credere alle parole del Presidente della Conferenza
episcopale ma ho paura che la massiccia decisione degli italiani
non dipenda molto né dalla loro saggezza né
dal loro spessore morale. Anche perché sulle questioni
morali a me pare non appropriata l’astensione. E’
stato citato non a caso Ponzio Pilato che con quel suo gesto
ha avuto un ruolo non secondario nella condanna e crocifissione
di Gesù. L’astensione è una scelta che
mantiene grossi margini di ambiguità anche quando nel
contesto specifico assume un preciso significato (qui di difesa
di una “buona legge” di cui dirò tra poco).
Se uno
pensa allo storico paganesimo degli italiani, al loro scarso
senso civico, alla scarsa sensibilità sui conflitti
di interesse, al perdonismo, al familismo, alla loro millenaria
propensione ad arrangiarsi acquisita anche per necessità
sotto ogni dominazione straniera, alla loro abilità
compromissorie di ogni tipo, francamente pensare che improvvisamente
siano divenuti saggi e dotati di un forte senso morale sembra
poco credibile anche perché nel caso di specie, siamo
davanti a fattispecie molto difficili da dirimere. Al di là
di alcune prospettazioni propagandistiche, entrambe le posizioni
contrapposte sono revocabili in dubbio perché ogni
protocollo medico può essere abusato. Ma la Chiesa
Cattolica storicamente non si lascia cogliere dal dubbio,
tende ad assumere posizioni dottrinarie nette e precise, spesso
dogmatiche, salvo poi a disattenderle nella pratica, salvo
a ravvedersi, magari con qualche secolo di ritardo, quando
si dimostrino insostenibili.
Una seconda
considerazione che vorrei fare riguarda le modalità
di approvazione della legge e le riforme costituzionali in
cantiere. Se ministri e parlamentari della stessa maggioranza,
già all’indomani dell’approvazione della
legge n. 40, si sono ravveduti ed in parte dissociati qualche
problema con il funzionamento dell’attuale meccanismo
maggioritario c’è. Detta legge è stata
approvata a colpi di maggioranza ma poteva essere approvata
con un voto trasversale. Le istanze dell’opposizione
non sono state tenute presenti. La legge è molto delicata
e disciplina fattispecie molto particolari che non interessano
la maggioranza dei cittadini che non hanno problemi di sterilità
o di malattie genetiche. Questo forse giustifica anche il
disinteresse a pronunciarsi. Ma se nella discussione di una
legge la contrapposizione si sposta sul terreno della lotta
tra il bene ed il male, il suo iter diventa necessariamente
travagliato e suscettibile di portare ad esiti non soddisfacenti.
Questo
mi porta a riflettere sul bicameralismo perfetto e alla necessità
di salvaguardarlo – contro le riforme che lo vogliono
eliminare - se esso porta ad una riflessione più attenta
su come disciplinare questioni molto delicate e complesse.
Se ministri e parlamentari della maggioranza si sono dissociati
evidentemente hanno riconosciuto che questo lavoro non è
stato fatto bene e che la legge presentava più di un
problema. Anche da questo punto di vista, non appaiono convincenti
le spiegazioni secondo cui “la classe dirigente ha perso
il polso del Paese”. Sostenere una tesi del genere al
riguardo della legge n. 40 mi sembra proprio una follia. A
me sembra che il legislatore non abbia fatto, a colpi di maggioranza,
un grande e meritorio lavoro ma sostenere che il popolo italiano
sia stato più saggio della sua classe dirigente astenendosi,
francamente, mi sembra troppo.
P.S.:
Dopo aver scritto il pezzo, ho avuto modo di leggere il sondaggio
di Renato Mannheimer sul Corriere della Sera. Titolo: L’astensione?
Il disinteresse ha vinto su tutto. “Dunque, buona parte
dell’astensione rilevata in questo referendum è
motivata non tanto da una scelta politica o religiosa, quanto
dal rifiuto o dalla difficoltà di approfondire troppo
la questione”. Il Cardinale Ruini dovrebbe forse ridimensionare
le sue dichiarazioni sulla saggezza e la morale degli italiani.
|
Torna
su
|
In
dieci battute
(a proposito dell’astensione nel referendum)
di Michele Mocciola
Riceviamo
e pubblichiamo con piacere questa breve riflessione dell'amico
Michele Mocciola iscritto nella nostra mailing-list - anche
alla luce dei risultati referendari
e delle inevitabili polemiche
che seguiranno.
Michele Mocciola è Magistrato di Corte d’Appello
e svolge le funzioni di Giudice presso il Tribunale di Brescia.
|
 |
Il
titolo IV° della Parte prima della Costituzione italiana,
intitolato, Rapporti politici, fissa i principi generali -diritti
e doveri- di partecipazione individuale
-e perciò collettiva- dei cittadini alla vita politica,
riconoscendo il diritto di voto (art. 48), il diritto di costituire
partititi politici (art. 49), il diritto di sollecitare le
Camere a legiferare in determinate materie (art. 50), il diritto
di accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici (art.
51), l’obbligo del servizio di leva (art. 52), l’obbligo
contributivo (art. 53) e, finalmente, il dovere di essere
fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le
leggi (art. 54).
In questo ambito la medesima Costituzione sancisce, con formula
inequivoca, che Il voto è personale ed eguale, libero
e segreto. Il suo esercizio è dovere civico (art. 48
c. 2, seconda parte).
Insomma, questa parte della nostra Costituzione regolamenta
la vita di ciascun cittadino all’interno del sistema
repubblicano e democratico sancendo quei diritti e doveri
fondamentali i quali segnano l’appartenenza di ciascuno
di noi ad un’unica collettività politica.
In seguito, la Costituzione, occupandosi del Parlamento e
della produzione delle leggi e delle regole che a questa produzione
presiedono -Parte seconda, Titolo primo, sezione seconda-
disciplina l’istituto del referendum abrogativo, cioè
di quella consultazione popolare diretta finalizzata all’abrogazione
o meno di una legge (art. 75). A questo proposito la Costituzione
impone due requisiti numerici sia perchè la proposta
del referendum sia valida sia perchè l’esito
sia legittimo.
Il primo è che la richiesta provenga da almeno cinquecentomila
elettori o cinque consigli regionali, il secondo che abbiano
partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto al
voto.
Le predette condizioni sono comprensibili a chiunque.
In un sistema istituzionale nel quale la formazione delle
leggi è demandata al Parlamento -organo di mediazione
tra gli elettori e la legge- una volontà popolare residuale
e incidente direttamente in questo processo di formazione
legislativa, decidendo di abrogare ovvero di conservare una
legge, in tanto può ammettersi in quanto sia espressione
di un numero di elettori che sia realmente maggioritario,
da cui il rilievo anche per coloro che non si recano a votare.
Ammettere, al contrario, la possibilità abrogativa
ad un numero esiguo di elettori avrebbe legittimato una situazione
-invero inconcepibile- in cui pochi soggetti impongono le
proprie regole ai molti di più, laddove, notoriamente,
in Parlamento le regole sono approvate dalla maggioranza dei
parlamentari che a loro volta sono espressione della maggioranza
degli elettori.
Ecco quindi spiegato il motivo del requisito del quorum imposto
dall’art. 75.
E’ poi evidente a tutti che non era possibile individuare
analogo quorum in relazione alle altre forme di consultazione
popolare – leggi: elezioni politiche – dal momento
che non si poteva certo rischiare il vuoto istituzionale consentendo
agli astensionisti di lasciare il Paese privo del suo organo
fondamentale: il Parlamento ( o privo degli altri organi ad
elezione diretta).
In queste ragioni tecniche risiede il senso, assai ragionevole,
dell’art. 75.
Consegue che l’affermazione secondo cui la Costituzione
autorizza e legittima l’astensione nei referendum a
differenza delle altre consultazioni è una mera sciocchezza
giuridica ed è un invito a violare i doveri costituzionali
di ogni cittadino.
Infatti, anche per la consultazione referendaria permane il
menzionato dovere civico sancito da una norma di principio
della Costituzione, principio ineludibile e valevole per ogni
occasione nella quale si è chiamati a votare, e permane
l’obbligo di osservanza della Costituzione, che vale
in primo luogo per coloro che ricoprono incarichi istituzionali.
La previsione di invalidità del referendum serve a
scongiurare i pericoli, teoricamente concepibili e di cui
sopra, ma non può certo autorizzare condotte che la
prima parte della Costituzione considera anti-doverose.
E adesso tutti coloro che hanno invitato ad astenersi vadano
a confessarsi, grazie.
|
Torna
su
|
Anche
gli olandesi dicono no alla Costituzione europea
di Enzo Russo* |
 |
Puntualmente
arriva il secondo no alla Costituzione europea. Era nelle
previsioni e queste si sono avverate. A me dispiace comunque.
Come ha confermato la Commissione europea, le procedure di
ratifica devono andare avanti. Bisogna verificare a fine ottobre
2006 quanti sono i Paesi contrari e quelli favorevoli.
Per gli
olandesi avrebbero giocato motivazioni in parte diverse da
quelle francesi: un doppio no alla globalizazione e all’immigrazione.
Svilupperò alcune considerazioni su questi punti che,
più o meno, riguardano anche gli altri popoli europei
e le relative politiche che l’Unione europea porta avanti.
Partiamo dalla globalizzazione.
E’
paradossale che in Olanda che ha sempre avuto alcune grandi
imprese multinazionali, che ha avuto un grande economista
come Ian Timbergen il quale già negli anni ’70
si occupò delle multinazionali per conto dell’Organizzazione
internazionale del lavoro, si reagisca mostrando una scarsa
comprensione dei termini del problema. Lo Stato nazionale
ottocentesco è troppo grande e lontano per occuparsi
dei problemi giornalieri della gente. E’ troppo piccolo
per potere affrontare da solo i grandi problemi della globalizzazione
dei mercati, della concorrenza dei Paesi in via di sviluppo,
ecc.. E’ destinato a perdere sovranità da un
lato a favore dei livelli sub-centrali di governo, dall’altro,
a favore di entità sovranazionali tendenzialmente universali.
Rispetto
ai problemi della globalizzazione non esiste una risposta
nazionale. E’ illusoria e non funzionerebbe che per
qualche anno. Nel medio termine sarebbe travolta. E’
proprio attraverso l’Unione europea che i Paesi membri
possono affrontare questi problemi nelle sedi internazionali
preposte con azioni coordinate delle Agenzie specializzate
delle Nazioni Unite: l’Organizzazione mondiale del commercio;
la Banca Mondiale; il Fondo monetario Internazionale; l’Organizzazione
Mondiale per l’alimentazione e l’agricoltura,
ecc.. Lo stesso Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
nel quale sarebbe opportuno sedesse un unico rappresentante
dell’Unione europea. Gli olandesi informati conoscono
queste cose meglio di me perché molti di loro hanno
ampia esperienza internazionale.
Il problema
è che, a livello europeo, deve venire una risposta
comune a questi problemi, perché o si cerca di governare
la globalizzazione o si è governati da essa. In questo
ultimo caso, si pone un grosso problema di democrazia, di
rispetto delle preferenze dei cittadini. Ma se prevale la
concorrenza fiscale al ribasso non c’è Paese
anche grande che possa contrastare le spinte dei mercati mondiali.
Gli olandesi negli anni ’80 avevano un sistema di welfare
molto generoso che hanno già rivisto negli anni ’90.
Per un olandese era possibile lavorare per sei mesi e vivere
sui sussidi per altri sei mesi. Il sistema era abusato da
alcuni e, quindi, era inefficiente ed iniquo. E’ stato
rivisto perché non era sostenibile.
Analogamente
gli agricoltori olandesi beneficiano della politica agricola
comune. Questa è stata sempre criticata a partire da
una indagine che già negli anni ’70 svolse un
Commissario della Comunità, l’olandese Mansholt.
Tale politica, nonostante alcune revisioni, impegna tuttora
la parte più rilevante del bilancio della Unione. Assicura
un certo livello di reddito alle agricolture più efficienti
di alcune regioni europee. E’ fortemente protezionista,
danneggia i consumatori interni, impedisce le importazioni
dai Paesi extra-comunitari. La PAC è destinata ad essere
ridimensionata perché inefficiente e non sostenibile
- con o senza la Costituzione europea. Peraltro i Paesi contributori
netti al bilancio comunitario come la Germania, la Francia,
l’Italia sarebbero i maggiori interessati ad addivenire
ad una revisione di questa ed altre politiche per concordare
politiche di sostegno dirette comunque rispettose di regole
comuni. In altre parole, almeno in parte, si potrebbe evitare
il giro vizioso dei contributi al bilancio comunitario, dei
finanziamenti (aiuti) ricevuti e, quindi, del calcolo dei
rimborsi che ammorba la trattativa sugli accordi finanziari
per il periodo 2007-2013 sui quali l’Italia ha già
ripetutamente minacciato di mettere il veto.
Su queste
ed altre delicate questioni purtroppo i governi nazionali
non rifuggono da comportamenti populistici e demagogici, non
di rado soffiando sullo scontento popolare e attribuendone
la colpa all’Europa. Salvo poi meravigliarsi che la
gente comune voti contro l'Europa. Certe politiche poco efficienti
vanno cambiate con o senza la Costituzione europea. L’alternativa
protezionista e isolazionista non esiste. La Costituzione
europea ha adottato il modello della democrazia partecipativa
e l’economia sociale di mercato. Tale modello al momento
è l’unica terza via che si differenzia dal capitalismo
neo-liberista nord-americano e dai modelli populisti, neo-corporativi,
autoritari, non competitivi, inefficienti, corrotti e di sfruttamento
che prevalgono fuori dall’Occidente. Il governo europeo
deve sapere rispondere alle aspettative della gente ma tutti
sappiamo che, allo stato, questo dipende innanzitutto dai
governi dei Paesi membri i quali non possono utilizzare il
primo come capro espiatorio delle loro incapacità.
Qualche
considerazione finale sull’immigrazione e la xenofobia.
Nella Unione europea prevalgono Paesi con la popolazione più
vecchia del mondo. Un afflusso adeguato di immigrati è
una necessità se non si vuole accettare un declino
ineluttabile. Al di là delle necessità economiche,
l’Unione europea ha adottato giustamente un modello
aperto, ispirato ai diritti universali del cittadino, e la
Carta dei diritti fondamentali di Nizza (2000) che tutti i
Paesi hanno approvato. La Costituzione europea non è
lo statuto di un club esclusivo, chiuso ed elitario. Nel mondo
globalizzato, la prospettiva del governo mondiale sta diventando
sempre più realistica. Il governo europeo che è
già una realtà in essere, con o senza la Costituzione
europea, non sarebbe che una dimensione regionale di quello
mondiale.
In tutto
il mondo sono in corso processi di integrazione economica
di aree sempre più allargate. La libertà e la
democrazia sono alla base dello sviluppo economico e civile.
La Turchia, a partire dalla rivoluzione di Ataturk, ha fatto
una scelta strategica ormai secolare a favore della democrazia
di tipo occidentale. In Germania milioni di Turchi convivono
pacificamente co i tedeschi e, così, in altri Paesi.
Il modello europeo di società è aperto. Oggi
sono i Turchi a chiedere un Trattato di associazione ed in
prospettiva la piena adesione. Domani potrebbero essere altri
Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e non. Ai tempi di
Roma, il Mediterraneo era un mare interno. Se i paesi rivieraschi
adeguano le loro istituzioni agli standard democratici della
Unione europea, dell’OSCE, delle Nazion Unite, non si
può opporre un rifiuto perché altrimenti si
tradirebbe lo spirito universalistico della Costituzione europea.
Se quelle scritte nel II Trattato di Roma non sono solo parole,
bisogna essere coerenti e bisogna battersi perché esse
diventino realtà operative.
P.S.:
Già in occasione dell’esito del referendum francese
ed ora, dopo quello olandese, il Presidente del Senato, la
seconda carica dello Stato, trova modo di affermare che ormai
la Costituzione europea è morta. Non si può
dire che egli sia allineato con il Presidente Ciampi che,
solo alcune settimane fa, ha ricevuto il Premio Carlo Magno
proprio per il suo alto impegno per l’Europa e la sua
Costituzione.
*Enzo
Russo è un economista che insegna alla Facoltà
di Economia de La Sapienza. Ulteriori approfondimenti sul
suo Blog http://enzorusso2020.blog.tiscali.it/
|
Torna
su
|
WORLD
PRESS PHOTO
Edizione 2005
I dolori del mondo, quasi soltanto questi, come se la storia
dell’anno appena trascorso fosse soltanto fatta di guerre,
violenze, tsunami…
E’, come al solito, un pugno allo stomaco l’edizione
2005 delle migliori foto giornalistiche “World press
photo” giunta alla quarantottesima edizione e visibile
fino a domenica prossima (29 maggio) al museo di Roma in Trastevere.
Circa 200 immagini, in bianco e nero e a colori per fissare
la disperazione di una donna per la morte di un parente dopo
la catastrofe dello tsunami (Foto dell’anno 2004 a Arko
Datta, dell’agenzia Reuters); o la fragile sopravvivenza
di un soldato americano scampato a un primo attentato (è
l’immagine di David Robert Swanson), ma non al secondo;
o l’allegra fuga di due ragazzini che attraversano una
nuvola di locuste.
L’Iraq e l’Afghanistan: le guerre e i dopo-guerra.
Il boom cinese spiegato con immagini da “Tempi moderni”.
Le violenze fisiche su ragazze che possono oramai esprimersi
soltanto con gli occhi. Ma anche le sperdute regioni dove
la religione battista vieta l’elettricità o una
foto del campionato di tennis da tavolo apparentemente rubata
a Mondrian…
Da non perdere, dalle 10 alle 20, lunedì escluso. Piazza
Sant’Egidio 1/ B. Roma
Fe. Al.
|
|
|
Torna
su
|
a.a.a.
vendansi vecchia Volkswagen “benedetta XVI”
|
|
| Internet
è comunicazione globale, l’abbiamo già
detto molte volte. Una comunicazione che si declina in molti
modi e dà molte occasioni, alcune anche insospettate.
Capita così che un sito che conosce in questi ultimi
mesi un grande successo, sia protagonista di un fatto assai
singolare.
Il sito è eBay (per tutti i soci che sono curiosi e
vogliano darci un'occhiata lo trovate all’indirizzo
www.ebay.it
) e si occupa di mettere in comunicazione utenti che vogliono
vendere e acquistare qualcosa. Una specie di Porta Portese,
il noto mercatino romano, o di PortoBello, la nota via londinese.
Solo che eBay, che funziona e dove puoi veramente trovare
di tutto e a prezzi ottimi, collega utenti di tutto il mondo.
Così capita che si metta in vendita una Golf Volkswagen
di seconda mano una volta appartenuta al nuovo Papa Benedetto
XVI.
L’asta, perché eBay funziona con il meccanismo
dell’asta, si è conclusa alle 7:30 di giovedì
5 maggio ed ha visto la vittoria di un utente registrato come
"Golden Palace Casino" che ha acquistato la vecchia
auto per 188.938 euro.
"L'offerta vincente viene da qualcuno che ha spesso comprato
articoli inusuali in passato", ha detto la portavoce
di eBay, Daphne Rauch, aggiungendo che il vincitore è
di Austin, in Texas.
Il prezzo si è raddoppiato nelle ultime 24 ore. Ci
sono state 8,4 milioni di visite al sito web durante l'asta,
durata 10 giorni.
Le offerte si sono moltiplicate nei minuti finali di giovedì,
quasi in coincidenza con la ricorrenza cristiana dell'Ascensione.
"Non avevo mai visto niente di simile", ha aggiunto
Rauch, spiegando che il vincitore dovrà comparire di
persona per prendere l'auto, registrata per la prima volta
nel marzo del '99 a nome di Joseph Ratzinger, il cardinale
tedesco diventato Papa Benedetto XVI.
Ma il fatto più curioso, pensateci, non è tanto
la cifra raggiunta quanto il fatto che il pontefice stesso,
o comunque qualche suo stretto collaboratore, abbiano scelto
Internet per vendere l’auto.
Insomma signori, clicchiamo senza vergogna, su Internet capita
anche di incontrare il Papa.
|
Torna
su
|
Musica
per un ascolto inusuale.
Commenti al concerto di domenica 20 marzo
05 dell'A.R.A.M.
di
Ayres Cenni e Carlo Gabrielli
|
Ogni
domenica mattina la romana Galleria Nazionale d'Arte moderna
regala ai suoi visitatori concerti cameristici di gran livello
che si svolgono nella Sala dell'Ercole. Dal lucernario al
parquet l'ampia sala sembra lo scrigno ovattato di opere d'arte
convenute a mirarsi l'un l'altra nello specchio armonico del
proprio esistere.
Quando ai piedi della imponente statua canoviana dell'Ercole
un pianoforte canta, la magia avvolge gli ascoltatori in una
ideale parabola rasserenatrice. Se il pianista si chiama Corrado
Nicola de Bernart l'incanto è completo; l'interprete
ha mani lunghe e sensibili, tocco profondo, tecnica d'artista.
Il programma scelto ha un titolo subliminale "Un petit
train de plaisir - Rossini e il pianoforte": sono pagine
misconosciute del Rossini ultimo periodo, che compose per
il suo salotto parigino brevi spartiti pianistici, lontani
dal clamore romantico-wagneriano che dominava nei teatri d'epoca.
Il compositore non pubblicò mai questi lavori, che
riservava al piacere dei suoi amici, eseguendoli di persona.
Con questi fogli d'album, dai titoli raffinati a quelli più
semplicemente umoristici, il maestro de Bernart introduce
gli spettatori in un mondo di sottili corrispondenze fra moti
dell'animo e interrogativi eterni.
Stendhal chiamò Rossini il Voltaire della musica, nel
senso che entrambi erano autori che si muovevano in punta
di piedi fra la profondità della vita e lo stile leggero
di una incredula atarassia. Schopenauer definì il cigno
di Pesaro un musico d'avorio, mandarino dei suoni, satrapo
delle biscrome, giocoliere del pentagramma.
Il pianista premette alle sue esecuzioni alcuni cenni storici
per costruire insieme un cammino verso la giusta comprensione
musicale. In tal modo, con grande sapienza intellettuale,
de Bernart aiuta a far capire le immagini ricreate dalla sua
valentìa interpretativa, il cui brillante dinamismo
dà vita a un incontro fuori del tempo.
Ringrazio il professor Corrado Nicola de Bernart, presidente
dell'Associazione Romana Amici della Musica, per l'ascolto
inusuale.
Ayres
Cenni
_________
I concerti
domenicali alla GNAM diventano sempre più interessanti,
vuoi per le opere trattate, vuoi per la bravura degli interpreti.
Quello di domenica 20 marzo in particolare, nel quale il Maestro
Corrado de Bernart ha trattato, con bravura pari alla signorilità,
del "silenzio" rossiniano dopo il trionfo del Guglielmo
Tell; certo, fu un silenzio "assordante" se si pensa
che a quel periodo si debbono i bellissimi Péchés
de Vieillesse di una modernità impessionante, ed alcune
delle sue più belle opere religiose come lo Stabat
Mater e soprattutto la Petite Messe Solennelle, ove si trovano
richiami al cromatismo di Frank! E scusate se è poco!
Carlo
Gabrielli
|
Torna
su
|
La
lingua italiana: Severgnini scopre l’acqua calda
di Paola Sereni
A
proposito della lingua italiana e dei vari approcci scelti
dalla stampa e dalle istituzioni per “salvare”
questo o quello, si è letto in questi giorni un articoletto
dell’editorialista del Corsera Beppe Severgnini. E’
il giornalista, per chi non se ne ricordi, che sul rapporto
dell’italiano medio con lo straniero e in particolare
sulla scarsa propensione degli italiani per l’inglese
ha costruito la sua fortuna letteraria con varie opere, tra
cui uno speciale manuale “L’inglese.
Lezioni
semiserie” in cui si metteva a confronto la “vera”
lingua inglese con le espressioni e pronunce finto-inglese
di velleitari italiani, amanti quanto ignoranti della lingua
britannica.
L’articolo ha il provocatorio titolo: “La difesa
dell’italiano? Affidiamola agli emigrati”.
In effetti Severgnini individua nella diaspora degli emigrati
italiani d.o.c., e nei loro comportamenti, che si presuppongono
ispirati dalla nostalgia e dall’innamoramento dell’Italia,
la salvezza della nostra lingua: imprese, uffici, emigrati
all’estero con o senza antenati italiani sarebbero -
se opportunamente coinvolti - risolutivi in questo senso.
A proposito di burocrazia, enfatizza l’importanza e
i doverosi condizionamenti di un fattore “casuale”
di carattere storico-familiare: chi ha antenati italiani,
non si limiti ad amare l’Italia, ma studi la lingua,
soprattutto se pretende di ottenere il passaporto e la cittadinanza
italiana. E i “cervelli” emigrati ci aiutino e
si diano da fare con il loro prestigio e la loro lungimiranza...
Fin qui, se sono dichiarazioni di principio, si può
essere d’accordo, ma c’è un fattore che
sembra - nella migliore delle ipotesi - oltre che scontato,
ingenuo, quando dice che bisogna utilizzare “aggressivamente”
gli istituti italiani di cultura all’estero. Sulla cronica
inadeguatezza dei nostri istituti di cultura all’estero
si è tanto discusso e si continuerà a discutere
fino a che mancherà la trasparenza e doverosa attenzione
nelle nomine individuali e nelle risorse di cui dotarli.
Nessuno mette in dubbio la valenza teorica di tali Istituti:
una corretta diffusione della lingua è un elemento
rilevante - forse il più rilevante - dell’attività
istituzionale e della loro stessa sopravvivenza.
Lo stesso Capo dello Stato ha enfatizzato in più di
un’occasione la valenza di tali Istituti, un po’
lodando, un po’ stimolandone l’attività,
ricordando anche lui il grande impulso dato rispettivamente
alle tre lingue europee più comuni, dal British Council,
l’Alliance Française e l’Istituto Cervantes
e rammaricandosi che non vi fosse un’istituzione che
potesse dare un analogo apporto all’italiano.
E mi sembra un po’ingenuo Severgnini che riporta le
parole di Pia Luisa Bianco, attuale direttrice dell’Istituto
di Bruxelles (già direttrice, dopo Feltri, del famigerato
quotidiano L’Indipendente in voga negli anni ’90
negli ambienti leghisti) che ha “scoperto” che
ci sono settori portanti dell’Europa dove si parla italiano:
il design, la moda, la conservazione museale, il teatro lirico,
la musica....
A proposito di musica, l’etimologia del nome del Segretario
di Stato Condoleezza Rice, figlia di musicofili e appassionata
di musica ella stessa -che sarebbe una contaminazione americana
del “movimento” in musica “con-dolcezza”-
ha insegnato anche al grosso pubblico che i movimenti musicali
sono sempre stati denominati in italiano, mai tradotti...).
L’italiano -come dicevamo su queste pagine- è
parlato in Europa in ambienti culturali e “di nicchia”
ad alto livello, enclaves non comunicanti, ma la
Bianco dà per scontato ciò che non lo è
affatto dicendo che “non è una lingua di comunicazione
internazionale così come lo sono francese, inglese
e spagnolo”.
Passi per l’inglese e lo spagnolo che costituiscono
la lingua madre per un numero altissimo di individui, a prescindere
dalle caratteristiche intrinseche che ne favoriscono la diffusione,
da prendere per esempio è la Francia, per cui la lingua
nazionale è uno dei “beni culturali” da
proteggere e valorizzare e che legifera e amministra strenuamente
in difesa della sua lingua. Ed è qui la differenza:
ad un Paese come il nostro, in cui per “miracolo”
si è riusciti a bloccare la scriteriata, disonesta,
criminale, ipotizzata estensione del silenzio-assenso della
DIA al patrimonio di cultura “materiale” (archeologico,
architettonico, paesaggistico) che avrebbe distrutto le tracce
materiali della straordinaria vicenda storico-culturale dell’italica
gente...cosa volete che importi la difesa di un bene immateriale
che pure ne fa parte integrante e le cui vicende, dal latino,
attraverso il vulgare e il Medioevo - come ci racconta Dario
Fo, Premio Nobel 1997 per la letteratura - fino ai nostri
giorni, hanno fatto parte della Storia dell’umanità!
|
Torna
su
|
La
ricerca dell’infinito
Acquerelli
e disegni del Romanticismo tedesco e austriaco
Negli
acquerelli e disegni le correnti culturali e filosofiche del
Romanticismo hanno trovato la loro più sensibile espressione
artistica. Ritratti, scene bibliche e allegoriche, e soprattutto
i paesaggi rivelano una nuova concezione personale del mondo
e della natura.
La
storia di numerosi artisti e delle opere esposte è
strettamente intrecciata all’Italia: nel 1810 infatti
i fondatori dell’associazione viennese antiaccademica
„Lukasbund“, i futuri „nazareni“,
tra cui Friedrich Overbeck (1779-1869) e Franz Pforr (1788-1812),
si trasferirono a Roma nel convento di S. Isidoro. In seguito
si aggiunsero a questo gruppo di amici artisti importanti
come Peter Cornelius (1783-1867) e Joseph Fürich (1800-1876).
I temi
trattati sono paesaggi, ritratti, scene religiose, soggetti
tratti dalla letteratura, dalla storia, dalle fiabe e dalle
saghe. In mostra opere di 23 artisti austriaci e tedeschi
del Romanticismo e tardo Romanticismo. Pezzo forte della mostra
il „Römische Porträtbuch“ [Ritratti
romani] di Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872). La raccolta
di ritratti degli amici romani offre contemporaneamente al
nostro sguardo alcuni dei più importanti intellettuali
della Roma del 1820. Nella sezione „Paesaggi“
segnaliamo tra l’altro due precoci acquerelli di Joseph
Anton Koch (1768-1839), il geniale ispiratore del disegno
di paesaggio di epoca romantica. Il suo „Vietri sul
golfo di Salerno“ è un’opera chiave che
prelude ai suoi paesaggi eroici, mentre i disegni di Joseph
Führich sono i più significativi della sezione
religiosa.
Roma
è l’ultima stazione della mostra, già
apprezzata a Stendal, Koblenz, Bologna e Vienna.
Il paesaggio romantico
Il paesaggio come specchio di un ordine superiore
Più che per gli altri generi, il modello rappresentato
da Joseph Anton Koch è stato fondamentale per il paesaggio
“romantico”. Il suo ruolo di maestro e mentore
delle generazioni che si sono susseguite a Roma è fuori
discussione. Il suo influsso è stato determinante anche
durante il periodo trascorso a Vienna dal 1812 al 1815, dove
ha trasmesso importanti stimoli artistici a Ferdinand Olivier.
La concezione romantica del paesaggio non si ferma mai alla
sola rappresentazione della realtà empirica. Mentre
Koch nelle sue «vedute della natura» andava alla
ricerca di una idealità superiore nello spirito di
Poussin, l’urgenza del paesaggio cristiano-romantico
era quella di rappresentare la natura come rifrazione dell’operare
divino e come testimonianza dell’immanenza divina nel
mondo. In questo senso il posto centrale spetta certamente
a Ferdinand Olivier. I suoi paesaggi, con la loro “geometria”
volta a suggerire un ordine superiore, e con il complesso
sottofondo allegorico-cristiano che vi è sotteso, incarnano
in modo esemplare il paesaggio sacrale auspicato da Friedrich
Schlegel. Molto simile è la posizione sostenuta da
Johann Christoph Erhard e August Heinrich. La loro concezione
della natura è legata ad una grande sensibilità
per la descrizione della realtà, ma dalla restituzione
minuziosa dell’aspetto esteriore della natura traspare
la nostalgia dell’infinito. In questi paesaggi non c’è,
infatti, traccia di virtuosismi fine a se stessi. Si percepisce
piuttosto uno sprofondare quasi religioso nel dettaglio. Il
paesaggio inteso come allegoria della condizione umana ci
viene, infine, presentato da Ludwig Richter, il quale spesso
rievoca nei suoi disegni del paesaggio italiano anche l’idillio
del locus amoenus.
Quanto sia ancora forte, nella seconda metà dell’800,
una concezione del paesaggio profondamente debitrice al sentimento
romantico dello sconfinamento, è dimostrato dagli studi
paesaggistici - mirabili per la perfezione del disegno - di
un allievo di Führich, Bonaventura Emler, il quale rinnova
sia la tradizione del “paesaggio cosmico” quale
specchio dell’armonia cosmica, sia “il paesaggio
originale omerico” della Serpentara di Koch.
Scene
bibliche, leggende di santi e allegoria religiosa
Scene religiose come allegoria della conditio humana
La storia
religiosa del primo Romanticismo è caratterizzata il
più delle volte dall’esperienziale soggettivizzazione
di eterne verità salvifiche. Esperienze quotidiane,
situazioni limite dell’umana condizione come l’abbandono
e lo smarrimento, vengono trasposte e nella storia biblica
e nella vita dei santi, e trovano così la loro sacrale,
sublime formulazione. I ritratti a chiave - ad es. la fidanzata
di Olivier nella scena della prima notte di nozze di Tobia
e Sara – sono la spia più evidente che esiste
questo nesso con la vita personale degli artisti. Scheffer
identificò la defunta Santa Cecilia con Cäcilia
Bontzak, da lui adorata. Un chiaro esempio di proiezione dell’umano
desiderio d’amore in una storia religiosa. Il binomio
romantico di amore e morte, che solo può portare a
vero compimento l’amore terreno, ha un ruolo centrale
in entrambi gli esempi. Agar cacciata e al limite della disperazione
e salvata miracolosamente dall’intervento di Dio, diventa
l’immagine originaria della situazione esistenziale
dell’artista romantico. Ma le rappresentazioni bibliche
contengono anche riferimenti rivoluzionari ai fatti dell’epoca.
La parabola delle spighe, illustrata da Schnorr, è
un complesso manifesto allegorico delle posizioni dei confratelli
di San Luca contro l’Accademia di Vienna, da loro violentemente
contestata. Entrambi i partiti sono rappresentati sotto le
mentite spoglie di figure bibliche – i confratelli di
San Luca nelle vesti degli apostoli di Cristo, gli “accademici”
in quelle dei farisei. Nel tardo Romanticismo questo aspetto
rivoluzionario si trasformerà nell’atto di fede
genuinamente messianico dell’artista che lavora e crea
sulla spinta di un profondo sentimento religioso. Steinle,
Kupelwieser e Joseph Führich – la figura più
significativa – rappresentano in modo esemplare l’idea
dell’artista messaggero delle divine verità cristiane;
talvolta ricorrendo ad una retorica un po’ barocca,
ma avvalendosi anche di strutture narrative assai innovative.
Steinle, dal canto suo, nell’opera che raffigura la
prima coppia del genere umano, fa di Eva, dopo il peccato
originale, il prototipo della “femme fatale”.
I ritratti
Il volto umano come immagine di Dio
La ritrattistica
romantica nasce da un rapporto personale e affettivo. Non
si esaurisce però nella pura descrizione dell’aspetto
esteriore o dell’interiorità del soggetto raffigurato.
La serie di ritratti ad opera di Julius Schnorr, in particolare,
incarnano in modo esemplare l’idea della sostanza etica
dell’uomo – tipica della tradizione umanistica
– in stretta connessione con la storia biblica della
creazione che vede nell’uomo l’immagine di Dio.
Si ispira all’arte del Rinascimento la “solenne
dignità” del “Libro dei ritratti romani”
di Schnorr, i cui ritratti degli amici - una serie in sé
conclusa – sono un sublime esempio di idealizzazione
del volto umano che si esprime a livello formale nella stereometria
dei busti e nella fisiognomica delle singole figure. È
sorprendente la coincidenza della descrizione minuziosa dell’aspetto
esteriore e dello stato psichico con la sublime, quasi sacrale
etica dell’umano. Con riferimento alle numerose testimonianze
scritte dell’artista, possiamo dire che Schnorr ha tentato
per tutta la vita di realizzare questo nobile programma. I
ritratti di Schnorr si concentrano esclusivamente sull’aspetto
umano – ogni attributo ulteriore è eliminato
in quanto non essenziale.
L’autoritratto di Scheffer davanti al cavalletto, invece,
è un esempio di un secondo tipo di ritratto romantico,
in cui l’immagine, arricchita da diversi attributi,
diventa allegorica e, mediante complesse allusioni, arriva
a raffigurare l’artista come messaggero di verità
trascendenti. Grazioso solo in apparenza, il motivo schefferiano
dei tre bambini con il trifoglio veicola ideali rivoluzionari
ed è quasi un manifesto politico. Un’opera come
questa sottolinea una volta di più che “lo smarrimento
esistenziale” dei romantici spesso è un fatto
solo apparente, dato che molti hanno preso attivamente parte
alle guerre di liberazione contro Napoleone (i corpi franchi
di Lützow).
La ritrattistica di Friedrich Nerly rappresenta, in modo qualitativamente
ineccepibile, lo sciogliersi del ritratto romantico nella
restituzione dell’attimo che passa. Kupelwieser, dal
canto suo, mette il ritratto al servizio della propaganda
monastica rinnovando così la tradizione dell’iconografia
barocca.
Letteratura,
storia, fiabe e leggende
Forme della riflessione sull’amore, sulla morte e sulla
solitudine
Nell’ambito
dei temi letterari – come, peraltro, nell’ambito
del paesaggio – Joseph Anton Koch assolve un importante
ruolo di mediatore. Le sue illustrazioni della Divina Commedia
dantesca e dei Canti di Ossian del poeta scozzese Macpherson
- due opere letterarie centrali sia per Koch sia per il Romanticismo
tutto - segnano, infatti, l’inizio di questo filone
tematico. Entrambi i testi contengono una serie di topoi tipicamente
“romantici”, come, ad es., amore e morte (Paolo
e Francesca), oppure il tema della disperazione che sconfina
nella follia (Ugolino), o quello dell’esistenza umana
consegnata a se stessa, alla solitudine e alla riflessione
(Clessàmmor). Le interpretazioni di Koch si sono conquistate
una posizione chiave nella visione “romantica”
di quelle opere letterarie, anche se successive generazioni
di artisti si sono confrontate con quei testi in modo del
tutto personale. Per esempio, Bonaventura Emler ambienta la
scena del canto di Sulmalla, tratta dall’Ossian, in
un paesaggio costiero notturno potenziando in questo modo
il contenuto romantico del racconto. Significativo esempio
di concezione nazarena, Johann Evangelist Scheffer von Leonhardshoff
nel rielaborare il motivo di Ugolino, significativamente non
descrive la disperazione del conte, bensì la sua docile
rassegnazione al destino. Le fondamentali esperienze dell’esistenza
umana, come già era accaduto per le scene bibliche,
vengono espresse utilizzando immagini tratte dalla letteratura,
dalla storia, dalle fiabe e dalle saghe.
La storia è dominata dalla nostalgia per un Medioevo
romanticamente trasfigurato – spesso strumentalizzato
in chiave di propaganda politica storicamente legittimata
(Julius Schnorr, “Il corpo di Federico Barbarossa recuperato
dal fiume Kalykadnos”; Schwind, “L’Imperatore
Massimiliano I sulla Martinswand”). Nel corso del secolo
l’uso dell’immagine sacra nella raffigurazione
di soggetti storici entra in crescente conflitto con la richiesta
di una dettagliata autenticità – cosa che accade
anche negli studi storici che tendono sempre di più
ad analizzare in modo critico le fonti. La trasfigurazione
del Medioevo viene resa anche attraverso immagini accostate
con grande libertà in modo da evocare l’agognata
unità di arte e vita (Ludwig Ferdinand Schnorr, “Cavaliere
e suonatore davanti ad un castello” ; Schwind, “Il
cavaliere e il menestrello”).
La modalità dell’arabesco romantico moltiplica
e potenzia l’immagine centrale, intorno alla quale si
dispongono le variazioni sul tema, le analogie o anche sequenze
narrative autonome (Dobyaschofsky, “La fiaba dei sette
corvi”). Ispirato alle illustrazioni di Dürer per
il libro di preghiera dell’imperatore Massimiliano I
(litografate nel 1801 da Strixner), l’arabesco è
la forma narrativa più importante e caratteristica
dell’800, cui si affianca un’altra importante
modalità: la tendenza a collocare le singole immagini
all’interno di un ciclo di illustrazioni.
Una
mostra del Kupferstichkabinett
der Akademie der bildenden Künste di Vienna in collaborazione
con la
Casa di Goethe e il Forum Austriaco di Cultura Roma
Con
il patrocino di Michael H. Gerdts,
Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania
e Alfons Kloss, Ambasciatore d’Austria
Curatrice
della mostra: Cornelia Reiter
|
Torna
su
|
La
lingua italiana non ha bisogno di essere amata ma rispettata…
e soprattutto dagli italiani
di Paola Sereni
L’italiano
non è più una lingua stabile dell’Unione
europea, al pari dell’inglese, francese e tedesco. Ovviamente
i giornali hanno riportato la notizia enfatizzando il valore
politico dell’esclusione. Certamente
è una discrasia patente il fatto che l’Italia,
uno dei paesi fondatori e quindi teoricamente comprimari dell’Unione,
che ha saputo elevarsi e sistemizzare i propri squilibri economici
traballanti in nome della partecipazione all’Unione
europea, venga ora ad assumere un ruolo gerarchicamente subordinato
al ristretto gruppo di Stati che si sono assunti di fatto
un ruolo di guida. Insomma l’esclusione della lingua
italiana dal novero di quelle “organiche” all’Unione
rischia di diventare simbolica proprio di un consolidamento
nello scenario politico europeo dell’esistenza di una
gerarchia di Stati che era fin dall’inizio ben radicata.
Che questo sia successo per mille motivi e
che non sia altro che un corollario riguardo al ruolo complessivo
dell’Italia nell’Unione e alla politica schizofrenica
che da una parte guarda all’Europa e quando invece “fa
comodo” al governo nei suoi fin troppo “perscrutabili
motivi” guarda oltreoceano, è evidente. Come
pure è evidente che in questo come in tutti i settori
della vita pubblica il governo detta slogan programmatici
e smaccatamente pragmatici (ricordate le tre “i”
delle campagne elettorali berlusconiane, Inglese, Impresa,
Internet?) che fanno presa ma si evitano i discorsi più
complessi perché poco redditizi sul piano elettorale.
Il problema vero è che tutte le vicende legate alla
lingua, comprese quelle – poche – positive sono
subite, ma mai “cavalcate”. La situazione disastrosa
dei nostri istituti italiani di cultura all’estero è
ben nota ma la Farnesina è ben lungi dal tener conto
delle vicende legate alla lingua e porsi il problema di incrementare
le risorse in maniera significativa o assicurare che i rappresentanti
italiani ivi preposti abbiano un indiscusso prestigio personale
internazionale che dia agli istituti una garanzia di serietà,
ma anche di efficienza e di rispetto.
In questi giorni, sull’onda recriminatoria e polemica
sollevata dalla decisione dell’Unione Europea di instaurare
un regime trilingue di fatto nelle conferenze tenute dai Commissari,
il CNR si è scosso e si sta facendo promotore della
valorizzazione dell’identità linguistica e culturale
italiana, enfatizzandone il ruolo indiscusso di fattore di
integrazione: è uscita su qualche quotidiano di oggi
(23 febbraio) la notizia che il CNR finanzierà ben
139 progetti di ricerca in proposito e pare che vi sia coinvolto
in qualche modo il Ministero delle Attività Culturali
e l’Accademia della Crusca..
E’ noto comunque in proposito che le istituzioni preposte
alla tutela e valorizzazione della lingua vivono e si rinnovano
soprattutto grazie alla passione dei titolari e degli studiosi,
essendo la povertà di risorse in queste istituzioni
un fatto storico e ormai endemico.
Ci si accorge solo rispetto a speciali eventi mediatici che
anche la lingua italiana fa parte della straordinaria vicenda
storico-culturale del nostro Paese. Quando Benigni recita
la Divina Commedia - che pure fa parte del nostro bagaglio
scolastico di base -, è come se la si “rilanciasse”,
riscoprendo uno straordinario momento della nostra lingua,
quello in cui veniva "di-vulgata" attribuendole
un respiro più ampio, nell’ambito di una poetica
universale, anzi "sovrauniversale", dato che era
parlata dalle nostre anime.
La nostra lingua non ha bisogno di essere spettacolarizzata
per essere apprezzata, né deve avviarsi ad essere soltanto
amata come “reperto”. Noi l’abbiamo già
nel nostro DNA culturale una lingua universale, “morta”:
il latino, che dal medioevo si è evoluto come sappiamo.
Ora non facciamoci fuorviare da studiosi e stranieri che amano
la nostra lingua per il suo contenuto “culturale”,
quasi fosse un riflesso dovuto al nostro straordinario patrimonio
architettonico e artistico. La lingua è soprattutto
un mezzo per esprimerci e la nostra lingua ha, al pari delle
lingue più evolute, una straordinaria gamma di sfumature,
che, come tutti, utilizziamo al meglio quando è la
nostra lingua madre e delle quali perciò non dobbiamo
doverne fare a meno
Abbiamo già scritto in queste pagine web che la lingua
italiana ha una “straordinaria” diffusione nel
web rispetto alle altre lingue che vi sono presenti con percentuali
dovute soprattutto alla loro diffusione nei Paesi in cui sono
lingua-madre, a parte l’ovvia diffusione dell’inglese
- lingua ufficiale - . Però sappiamo pure che l’uso,
anzi lo straordinario uso della lingua italiana nel web, soprattutto
nei siti culturali, rischia di essere relegato in una enclave
aristocratica e nostalgica, ad uso e consumo, seppur nobile,
degli stranieri europei più colti quasi in un riflusso
delle pulsioni e istanze del Grand Tour. E’
invece una lingua viva, molto duttile e molto ricettiva di
espressioni prese da altre lingue, soprattutto, quasi paradossalmente,
francesismi e anglismi, il che non è la sua debolezza
ma la sua forza se i lemmi che via via diventano di uso comune,
riescono ad ampliarla e renderla sempre più aderente
alla realtà sociale, non ad estraniarla da se stessa.
Sull'argomento segnaliamo un
interessante articolo su "La lingua della politica italiana
dal 1994 al 2004" disponibile sul sito della Treccani
|
Torna
su
|
Shelley,
l’ateismo e... l’inventore della carta carbone
|
E’
successo a Londra in questi mesi. Tutto comincia quando due
anziani fratelli di 88 e 91 anni muoiono e lasciano in eredità
ai loro generosi vicini, che li hanno accuditi fino alla fine,
la loro casa e tutto ciò che contiene. Nessuno avrebbe
mai immaginato che la loro eredità contenesse un piccolo
tesoro.
Tra polverosi scaffali e scatole sono infatti saltate fuori
alcune lettere di Percy Bysshe Shelley, il famoso poeta inglese
dell’800, e preziose prime edizioni di Charles Dickens
e HG Wells.
Così le lettere di Shelley saranno il lotto più
importante di un’asta che terrà Christie’s
la prossima estate per un valore totale che si aggira tra
i 30-40 mila euro.
Le quattro lettere sono particolarmente preziose perché
risalgono al periodo tra il dicembre del 1810 e il febbraio
1811, poco prima che Shelley venisse espulso da Oxford per
aver pubblicato un opuscolo intitolato La necessità
dell’ateismo, ed erano indirizzate a Ralph Wedgewood,
passato alla storia per essere l’inventore della carta
carbone.
Il poeta scriveva al “papà del duplicato cartaceo”:
“Cristo non è mai esistito. La caduta dell’uomo
e l’intero tessuto della superstizione non possono più
ottenere il credito dei filosofi”.
da: La Repubblica, Cultura, venerdi 25 febbraio 05
|
Torna
su
|
| American
Academy in Rome
Keats-Shelley House
St. Paul’s Within-the-Walls
Museo Hendrik Christian Andersen
INCANTATI
DA ROMA / SPELLBOUND BY ROME
La comunità anglo-americana a Roma, 1890-1914,
e la fondazione della Keats-Shelley House / The Anglo-American
community in Rome, 1890-1914, and the founding of the Keats-Shelley
House
16 febbraio – 16 aprile 2005
|
|
La mostra, nata per iniziativa dell’American
Academy in Rome e della Keats-Shelley House, vuole celebrare
il centenario della fondazione del museo della Keats-Shelley
House, avvenuta nella prima decade del secolo scorso, grazie
all’impegno del poeta americano Robert Underwood Johnson
con l’aiuto del diplomatico e poeta inglese James Rennell
Rodd e di H. Nelson Gay, diplomatico e storico americano.
L’edificio in piazza di Spagna, dove il poeta John Keats
morì di tisi nel 1821, fu acquistato dalla Keats-Shelley
Memorial Association nel 1906 e inaugurato come museo dal
re Vittorio Emanuele III nel 1909. Da allora, esso costituisce
un polo di attrazione non soltanto per gli studiosi e i cultori
dei poeti romantici inglesi e dei loro legami con l’Italia,
ma anche per i semplici turisti.
Con questa mostra gli organizzatori hanno dunque inteso focalizzare
l’attenzione sulla variegata comunità intellettuale
di artisti, letterari e collezionisti inglesi e americani
che vissero o transitarono a Roma, giovane capitale d’Italia,
tra l’ultimo decennio del secolo XIX e il primo del
XX, immediatamente a ridosso della prima guerra mondiale.
In essa figurano scrittori quali F.Marion Crawford, Henry
James, Rudyard Kipling, Edith Wharton; inoltre artisti quali
George William Breck, Moses Ezekiel, Frederic Crowninshield,
Hendrik C.Andersen, Paul Manship, Augustus Saint-Gaudens,
Elihu Vedder. E, accanto a questi, gli amici artisti italiani
quali Enrico Coleman, Nino Costa, Adolfo de Carolis e altri.
Se il fulcro della mostra sarà nel bell’edificio
novecentesco dell’ American Academy in Rome di via Angelo
Masina al Gianicolo, il percorso complessivo dell’iniziativa
comprenderà la Keats-Shelley House, la Chiesa Americana
di St. Paul in via Nazionale e il Museo Hendrik C.Andersen
in via P.S. Mancini al quartiere Flaminio. L’itinerario
si completerà con la segnalazione di tutti quei luoghi
della città che furono punti di ritrovo della comunità
anglo-americana e dei loro amici a Roma, dalla All Saints
Church in via del Babuino al Tea-room Babington in piazza
di Spagna, dal Caffè Greco in via Condotti agli studi
di via Margutta, dal Grand Hotel di via Vittorio Emanuele
Orlando al Cimitero Acattolico del Testaccio.
Il catalogo della mostra, edito da Palombi, contiene saggi
di Christina Huemer, Catherine Payling, Anna Bruno, Frank
Dabell, Gertrude Wilmers, Sarah Moore, Regina Soria, Elena
di Majo.
************
L’American Academy in Rome fu fondata
dall’architetto Charles Follen McKim nel 1894 e trasferita
sulla collina del Gianicolo nel 1913. Di fatto, la sua prima
storia coincide con il periodo della mostra e l’edificio
stesso – opera degli architetti Mc Kim, Mead & White
– ne fa parte integrante. Sono esposti in mostra dipinti
dei primi due direttori dell’Accademia - George Willam
Breck e Frederick Crowninshield, ambedue noti per i loro contributi
al “Rinascimento Americano” - come pure alcuni
dipinti di Elihu Vedder, grande amico dell’Accademia
nei suoi primi anni, e di altri artisti loro contemporanei,
sia italiani che inglesi. Ai dipinti e ai disegni si aggiungono
opere di arte decorativa, come un grande candelabro in bronzo
disegnato per la Biblioteca dell’Accademia da Gorham
Phillip Stevens e targhe commemorative di Augustus Saint-Gaudens
e Paul Manship. Completa il percorso espositivo una sezione
sulla committenza e sui ‘conoscitori’, rappresentati
da personaggi quali J.Pierpoint Morgan (patrono sia dell’Accademia
Americana che della Chiesa di St.Paul) e Richard Norton (direttore
della Scuola Americana di Studi Classici dal 1899 al 1907
e collezionista di antichità, ora nelle collezioni
dell’Accademia stessa).
Nella Keats-Shelley House
si presentano gli aspetti piu’ letterari della mostra,
ma anche alcune importanti opere d’arte del periodo
preso in esame. Fra queste, il busto-ritratto in marmo di
Shelley eseguito da Moses Ezekiel, importante scultore americano
espatriato a Roma. Sono anche esposti documenti relativi alla
fondazione del Museo, come la lettera autografa del Presidente
Theodore Roosevelt (1906) e le lettere dei poeti americani
amanti del Romanticismo. La Keats-Shelley House è anche
la sede propria per mostrare le illustrazioni dei libri del
periodo, come quelle eseguite da Maxfield Parrish per le Italian
Villas and their Gardens di Edith Wharton (1904)
Nella chiesa americana di St.Paul’s
Within-the-Walls possono ammirarsi due importanti
opere monumentali in mosaico dei primi anni del XX secolo:
nella parte inferiore dell’abside, i mosaici di Thomas
Rooke, assistente di studio di Sir Edward Burne-Jones; sulla
facciata e la contro-facciata, i mosaici di George W. Breck,
americano. La mostra all’interno della Chiesa presenta
i disegni preparatori per questi mosaici, alcuni dei quali
di proprietà della Chiesa e altri provenienti da collezioni
private romane. Sono inoltre in mostra opere d’arte
raccolte dal rev. Robert Jenkins Nevin, rettore della Chiesa
dal 1869 al 1906 nonchè autorevole collezionista.
Nella sezione della mostra presso il Museo
Hendrik C. Andersen si presentano esclusivamente
materiali facenti parte delle collezioni del Museo, il quale
di per sè costituisce un capitolo molto significativo
della comunità anglo-americana a Roma tra fine Otto
e primi decenni del Novecento. Nei due vasti atelier al piano
terra dell’edificio, fatto edificare dallo stesso Andersen
(Bergen, 1872 – Roma, 1940) tra il 1922 e il 1924 come
suo studio-abitazione, sono collocati in permanenza i grandi
disegni e le sculture monumentali dell’artista relativi
al suo visionario progetto di ‘Città mondiale’,
progetto che nel suo complesso rappresenta un esito di straordinario
interesse nel panorama culturale di quegli anni, soprattutto
in quanto frutto dell’utopia di un artista americano
a contatto con la storia e la tradizione dell’Europa.
Al primo piano, già abitazione di Andersen e della
sua famiglia, sono invece esposti quei materiali (sculture,
dipinti, disegni) piu’ strettamente relativi alle frequentazioni
dell’artista (v. immagine sopra), e selezionati in base
al taglio cronologico della mostra stessa. Fotografie, libri
e documenti illustrano inoltre il suo lavoro, la sua vita
quotidiana, le sue letture.
American
Academy in Rome (via Angelo Masina, 5), da martedì
a sabato, 16.00 – 19.00
Keats-Shelley House (piazza di Spagna, 26), da lunedì
a venerdì, 9.00-13.00, 15.00-18.00; sabato 11.00-14.00,
15.00-18.00
St. Paul’s Within-the-Walls (via Napoli, 58): da lunedì
a venerdì, 9.00-16.00
Museo Hendrik Christian Andersen (via P. Stanislao Mancini,
20): da martedì a domenica, 9.00-19.30 (ingressofino
alle 19.00), tel.06.3219089/32298302, edimajo.gnam@arti.beniculturali.it
|
Torna
su
|
Incisioni
pittoriche di vedute italiane
Acqueforti di Johann Christian Reinhart,
Jacob Wilhelm Mechau e Christoph Albert Dies
di Caterina Pellitta
Nella
mostra “Mahlerisch radirte Prospecte von Italien”
(Incisioni pittoriche di vedute italiane) la Casa di Goethe
mostra al pubblico romano il recente acquisto di una cartella
di 72 opere che porta il medesimo nome della mostra. Le incisioni,
esposte dal 3.2 al 6.3.2005 alla Casa di Goethe, sono il frutto
di un progetto ideato e realizzato dall’artista tedesco
Johann Christian Reinhart date (1761-1847) con la collaborazione
di altri due importanti nomi del panorama artistico tedesco
come Jacob Wilhelm Mechau (1745-1800) e Christoph Albert Dies
(1755-1822).
Tra il 1790 ed il
1798, anni in cui la Città Eterna diede loro ospitalità,
i tre incidono ognuno 24 acqueforti raffiguranti paesaggi
di Roma e i dintorni. L’intera opera viene pubblicata
nel 1798 presso la casa editrice Frauenholz di Norimberga
con un ordine che non rispetta la cronologia delle opere bensì
la loro “topografia”: si parte dal centro di Roma
per arrivare alla periferia. Proprio questo è l’ordine
ricostituito nell’allestimento delle sale che accolgono
le incisioni della casa goethiana.
Osservando queste acqueforti non si
può fare a meno di notare le differenze rispetto alle
incisioni di paesaggi e vedute soprattutto romane di quel
periodo: qui a prevalere è la resa pittorica dell’incisione,
il paesaggio e la natura che invade le rovine rendendole con
un senso già preromantico.
E l’evidente intenzione artistica piuttosto che didascalica
nella resa del paesaggio si manifesta in alcune delle incisioni
con la raffigurazione degli stessi pittori nel loro atto di
ritrarre quei posti. Ciò è anche presente nella
raffigurazione, all’interno di quei paesaggi, di scene
di vita quotidiana - che oserei definire “drammatizzata”
- come il combattimento di due uomini sotto gli occhi sconvolti
di una popolana o i giochi dolcissimi di una madre con i suoi
piccoli bimbi.
All’osservatore sembrerà così di penetrare
in una realtà non più fredda e distaccata, simile
a quella di molte vedute dei paesaggisti dell’epoca,
ma in un mondo nuovo e fascinoso, per perdersi nei sentieri
incontaminati della campagna romana settecentesca che portano
verso ripide cascate o sotto le fronde ombrose dei tanti alberi
che, come le rocce, gli animali e le luci quotidiane, affollano
queste acqueforti.
Tutto ciò è poi reso ancora più piacevole,
agli occhi del visitatore di questa particolarissima mostra,
oltre che da alcuni disegni preparatori che pure sono esposti,
dalle piccole variazioni di stile che si possono cogliere
tra i tre artisti nella pur omogeneità di base delle
incisioni che rendono la serie una delle più alte espressioni
grafiche dell’epoca di Goethe (nella cui dimora romana
è giusto che ora trovino collocazione).
Gli
artisti
Johann
Christian Reinhart nasce nel 1761 a Hof. Studia
teologia a Lipsia e prende lezioni dall’insegnante
di disegno di Goethe, Adam Friedrich Oeser. Nel 1789 giunge
a Roma dove vive e lavora come acquafortista, disegnatore
e pittore fino al 1847, anno della morte. Influenzato da
Jakob Philipp Hackert, è accolto più tardi
nella cerchia di Jakob Asmus Carstens del quale segue le
orme come anche quelle di Joseph Anton Koch; godrà
per tutta la vita dell’apprezzamento dei Deutschrömer.
Dopo il matrimonio con una romana, avvenuto nel 1800, l’Italia
diviene per lui una vera e propria seconda patria. Intrattiene
una corrispondenza con Friedrich Schiller e Wilhelm von
Humboldt. È proprio nelle sue acqueforti che si rintraccia
il suo ideale di idillio paesaggistico. Il progetto delle
“Mahlerisch radirten Prospecte von Italien”,
nel quale riuscì a coinvolgere Albert Christoph Dies
e Jacob Wilhelm Mechau, si deve al suo entusiasmo per le
bellezze paesaggistiche dei dintorni di Roma.
Jacob
Wilhelm Mechau nasce a Lipsia nel 1745. Studia
anch’egli pittura e tecnica dell’acquaforte
con Oeser, che, tra gli altri, gli fa conoscere Reinhart.
È allievo di Rode a Berlino. Seguono poi soggiorni
a Lipsia e Dresda dove realizza le sue prime opere. Nel
1776, grazie ad uno stipendio offertogli dal duca di Sassonia,
Mechau si reca a Roma, dove lavorerà per quattro
anni come paesaggista, dedicandosi innanzitutto al paesaggio
eroico. Nel 1790, dopo dieci anni di permanenza a Dresda,
dove cerca invano di ottenere un impiego fisso presso l’Accademia,
ritorna a Roma dove verrà accolto nella cerchia degli
amici di Reinhart. Realizzerà le sue ventiquattro
incisioni delle “Prospecte” negli anni tra il
1792 e il 1795. Tre anni dopo le mutate condizioni politiche
costringono Mechau a lasciare l’Italia.
Albert
Christoph Dies nasce nel 1755 ad Hannover. Dopo
un apprendistato e un breve soggiorno presso l’Accademia
di Düsseldorf, raggiunge Roma nel 1775. Nella città
eterna si mantiene a fatica, dipingendo paesaggi, profittando
occasionalmente dell’aiuto di Piranesi e del mecenate
Lord Bristol. Studia la natura dei colli Albani e di Tivoli;
si reca a Napoli due volte. Negli ultimi dieci anni del
suo soggiorno romano, vive con l’archeologo Hirt,
che nell’estate del 1787 gli fa conoscere Goethe.
Per il poeta colorerà uno dei suoi disegni. La partecipazione
al progetto delle “Incisioni pittoriche” può
essere considerato l’apice dell’opera artistica
di Dies, sebbene i contemporanei criticarono la sua fedeltà
al dettaglio naturalistico che differenziava le sue incisioni
da quelle di Mechau e Reinhart. Dopo il lungo soggiorno
italiano, da 1796 vive a Vienna, dove morirà nel
1822. L’ultimo incarico sarà la direzione della
Galleria del principe Esterhàzy. Nella capitale austriaca
scrive anche una biografia di Joseph Hayden.
|
Torna
su
|
L'Home
Banking...
questa sconosciuta
di
Rita Crisante
L’home
banking (o e-banking) non è un mostro a tre teste,
non è un terrorista, non è un pericolo
per il focolare domestico. L'home banking non è
un ordigno nucleare e non ci vuole una laurea in ingegneria
per utilizzarla. Chiunque sappia controllare la propria
casella di posta e-mail, sa anche utilizzare la home
banking: infatti la procedura non è affatto dissimile
e non solo ti permette di evitare file agli sportelli
e risparmiare soldi sulle operazioni, ma ti permette
anche di agire sul tuo conto se sei fisicamente lontano
dalla tua banca, come durante un viaggio o una vacanza
(anche all'estero). Dunque tranquillizziamoci, l'home
banking è una grande comodità è
un'occasione di risparmiare tempo e denaro.
Nell’ultimo periodo perfino noi sembriamo accorgercene,
infatti diminuisce sensibilmente il gap che divide l’Italia
dal resto dell’Europa, dove il tasso di penetrazione
dell’e-banking era quasi il doppio di quello Italiano.
|
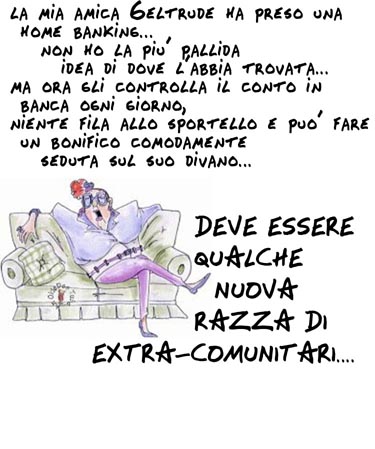 |
Secondo le previsioni dell’ultima rilevazione
del Kmpg Business Advisory Service basate sul tasso
di crescita, il tasso di sviluppo dei conti bancari
online in Italia è previsto nell’ordine
del 25 – 30 % di qui alla fine del 2006. Sono
7,5 milioni i conti online aperti dagli italiani alla
fine del 2004; di questi conti i 2/3 sono “conti
unici” cioè conti bancari accessibili soltanto
da Internet, mentre circa 2 milioni sono conti complementari
a quelli tradizionali in cui il cliente opera recandosi
fisicamente presso lo sportello della propria filiale:
di questi la maggior parte ancora sono stati attivati
ma per la maggior parte sono quasi inutilizzati, anche
se l’incremento del tasso di frequenza è
costante e in misura esponenziale (il 19 %).
In realtà uno dei maggiori fattori di questa
crescita è la politica aziendale delle banche,
soprattutto di quelle maggiori che un po’ per
l’aumentare dei costi di un conto tradizionale
un po’ essendo “obbligate” dal diffondersi
degli sportelli online, incentivano la propria clientela
al conto online.
Quanto ai collegamenti ad Internet, la stragrande maggioranza
degli utenti (88%) si limita alla consultazione del
proprio conto, il 65% effettua bonifici e (piccoli)
pagamenti e tra questi uno dei comportamenti più
diffusi è la ricarica dei cellulari. Le banche
incentivano questo servizio che non è redditizio
di per sé, perché gli importi sono modesti,
ma fidelizzano il cliente, per i quali sarebbe molto
oneroso e scomodo andare allo sportello. Inoltre la
banca “educa” una nuova generazione di utenti
che, abituati ad identificare il servizio bancario con
lo sportello, cominciano ad accettare che lo sportello
fisico e l’impiegato sono soltanto una delle “forme”
della banca, e che il servizio può essere più
efficiente (e con maggior comfort) anche senza il rapporto
fisico con il luogo.
E’ indubbio che -da parte dell’utente- consultare
il proprio conto online con la dovuta calma da casa
o dal luogo di lavoro è molto più gradevole,
rispetto a richiederlo all’impiegato allo sportello
(sono sempre di più le banche che l’e/conto
richiesto allo sportello lo fanno pagare) o a chiederlo
al bancomat con la fila di persone dietro che aspetta
(e con il rischio che anche la tessera bancomat si smagnetizzi
e ci abbandoni sul più bello!), il cellulare
che squilla e la fretta di concludere la transazione
senza quei piccoli inconvenienti che spesso succedono.
E’ possibile, inoltre, pagare le bollette, richiedere
i libretti di assegni e controllare lo stato di ogni
assegno, prenotare valuta estera, traveller chèque,
assegni circolari, visualizzare gli estratti conto delle
carte di credito, analizzare saldo e movimenti, richiedere
l’aumento del fido, monitorare lo stato dei finanziamenti.
Tutto ciò però quando il PC viene veramente
vissuto come “erogatore di servizi” con
cui si ha una discreta familiarità e quindi può
diventare una piacevole abitudine anche per l’utente.
La riservatezza dei clienti è protetta dalle
migliori soluzioni tecnologiche e sistemi di salvaguardia
su vari livelli. Basta seguire alcuni accorgimenti per
scegliere la password per entrare nello sportello bancario
e memorizzarla senza doverla scrivere qua e là,
ma sono gli stessi accorgimenti da mettere in conto
per tutte le password (o le combinazioni delle casseforti
o delle valigie ecc.). Se poi si vogliono fare bonifici,
c’è una “password dispositiva”
inviata dalla banca al singolo utente da immettere nel
PC, cosicché il bonifico ha tre “filtri”
che si combinano insieme, per dare il massimo grado
di segretezza e efficienza all’operazione: il
codice cliente, il codice segreto di ciascun cliente
e la password dispositiva.
|
|
Torna
su
|
Ricerca
scientifica e nuove tecnologie:
Bill Gates compra le uova e Trento si tiene la gallina.
|
|
Domanda:
è meglio un uovo oggi o una gallina domani? Secondo la
Provincia Autonoma di Trento è meglio una gallina domani…
e i fatti sembrano darle ragione.
Così, mentre l’Italia si affanna a far quadrare
i suoi bilanci, e la parola “taglio dei costi” echeggia
un po’ ovunque, partendo dal taglio degli investimenti
alla ricerca scientifica (cosa che sta facendo collassare gli
atenei), e le autostrade si trasformano in chilometriche piste
da sci per la strana novità che d’inverno nevica,
arriva in questi giorni nel nostro paese Bill Gates, presidente
e fondatore della Microsoft (sì, proprio quella che produce
il sistema operativo -di gran lunga più diffuso- dei
nostri Pc) per investire a Trento molti soldi. Precisamente:
15 milioni di euro.
Ma cosa abbiamo da vendere a uno come lui? La risposta è
semplice e neanche tanto nuova: cervelli. In Europa, secondo
il presidente della Microsoft, c’è la maggiore
concentrazione di scienziati con le caratteristiche giuste per
le sfide del futuro. E il primo gruppo di cervelli che godrà
di questo finanziamento e del relativo supporto logistico sarà
l’Università di Trento, che secondo una ricerca
dell’Ocse ospita i migliori matematici al mondo. Forse
che l’aria del Trentino favorisca un’intelligenza
matematica? No, “il genio trentino” dice Marco Andreatta,
preside della facoltà di Scienze “ qui non c'entra
nulla. Il nostro è un polo di ricerca riconosciuto a
livello internazionale, ma il 90 % dei docenti non è
trentino.” Semplicemente la Regione ha investito in questo
settore, e ora, provincialismo a parte, l’investimento
dà i suoi frutti. Notizia confortante, dopo aver dovuto
leggere su tutti i giornali che - secondo Harvard, portavoce
delle mitiche Università americane - gli atenei italiani
sono -secondo i loro più o meno opinabili parametri-
agli ultimi posti della classifica mondiale.
A Trento la ricerca e il relativo finanziamento verterà
intorno al genoma. Nel prossimo futuro si cercherà di
determinare, ad esempio, gli effetti dei farmaci sugli individui
grazie al profilo genomico di ciascuno. Ma la cosa più
interessante è che si calcola che questi studi di bio-info-nano-tecnologie
porteranno in 5 anni 100 milioni di nuovi posti di lavoro. Speriamo
molti in Italia.
Morale della favola: a investire sui nostri cervelli si riesce
a vendere le idee, e non i cervelli… c’è
da meditare per altri atenei italiani troppo spesso preoccupati
a vendere la gallina per un uovo oggi. Fonte:
Corriere della Sera, del 03/02/05, p. 22
|
Torna
su
|
Morandi
e Firenze
I suoi amici, critici
e collezionisti
di Isabella La Costa*
“Delle
città visitate per studiare la mia arte, quella che
più mi attira è Firenze dove ritrovo i sommi
ed ove conto amici a cui mi lega una certa affinità
spirituale”.
Così Giorgio Morandi descriveva nel 1928 il suo simbiotico
legame con Firenze, dove dal 20 gennaio sarà possibile
visitare una piccola ma interessantissima mostra dedicata
al pittore morto ormai quarant'anni fa. Significativo è
anche il luogo che ospiterà l'esposizione: quella Fondazione
che il celeberrimo critico d'arte Roberto Longhi, fra i primi
e più entusiasti sostenitori di Morandi, volle istituire
con legato testamentario "per vantaggio delle giovani
generazioni" nella villa un tempo appartenuta all'umanista
Cristoforo Landino —il maestro di Lorenzo il Magnifico,
di Marsilio Ficino e di Agnolo Poliziano— e che fu la
sua dimora dal 1939.
Alla notizia della morte di Morandi, Longhi pubblicò
un intenso saggio che ne celebrava il talento con profetica
consapevolezza del ruolo di protagonista da lui svolto nell'ambito
dell'arte contemporanea italiana. Tale commosso apprezzamento
si concretizza oggi nella scelta di esporre le dieci tele
che costituivano il nucleo della raccolta privata di Longhi
e della moglie, la scrittrice e storica dell'arte Anna Banti,
assieme alle altre opere (quadri, incisioni, acquerelli, disegni)
che Morandi stesso, con la sua "gelosa cura" nella
scelta del destinatario, aveva regalato agli amici, ai critici
e ai collezionisti residenti a Firenze. La provenienza dei
pezzi in mostra, dunque, comprende le raccolte di Carlo Ludovico
Ragghianti e della moglie Licia Collobi, di Alberto della
Ragione, Giovanni Spadolini, Maria Luigia Guaita Vallecchi,
Mina Gregori, Giuseppe e Adelia Noferi. Sono inoltre presenti
un raro disegno risalente al 1929 donato da Morandi all’Accademia
di Belle Arti di Firenze, due significative acqueforti tra
quelle lasciate dalle sorelle del pittore al Gabinetto Disegni
e Stampe degli Uffizi e, con un prestito importante, l’Autoritratto
del 1924, che fu di Giuseppe Raimondi.
Attraverso queste immagini è possibile cogliere in
tutta la sua forza e la sua raffinata eleganza, la particolare
poetica dell'artista così attenta al dato formale eppure
così ipnoticamente essenziale: è il caso, naturalmente,
delle numerose nature morte (genere prediletto ma non esclusivo)
che nella selezione espositiva consentono di ripercorrere
con chiara immediatezza l'iter stilistico e creativo del maestro.
Nelle silenziose armonie delle composizioni di oggetti quotidiani
rivive la meticolosità di un dialogo privato che si
consumava in giorni di solitaria riflessione nello studio
a contatto con quelle cose umili ma mai banali, che infine
Morandi sapeva trasfigurare in istantanee di delicato equilibrio,
dove la nuda semplicità delle forme è il mezzo
per sviscerare la vera essenza della realtà circostante
e insieme indulgere all'espressione di puri valori estetici.
È forse anche per questo che Morandi incontrò
il favore critico di Roberto Longhi, la cui vena lirica ha
ispirato pagine fra le più intense nella storia dell'arte
italiana, e forse anche di questo si nutriva "quella
certa affinità spirituale" fra il pittore e il
circolo fiorentino che la mostra curata dalla professionalità
e dalla passione di Mina Gregori e Maria Cristina Bandera
intende sottilmente rievocare.
(fonte: Corsera, 5 gennaio 2005, Terza
Pagina)
*
Isabella La Costa è una nostra
preziosa collaboratrice e cura il corso "Il Rinascimento@Venezia"
che si svolge presso la nostra sede.
Per tutte le informazioni
consultare la pagina:
 Corsi. Corsi.
|
Torna
su
|
Lingue,
linguaggi e dialetti
di Paola Sereni
I
limiti
del mio linguaggio
significano i limiti
del mio mondo.
LUDWIG WITTGENSTEIN, Tractatus 5.6
|
Nel
mondo di oggi, dove gli spazi sono annullati dai nuovi mezzi
di comunicazione globale (Internet in testa), si sente l’esigenza,
da un lato, di comunicare attraverso la mediazione di una
lingua comune funzionale, ruolo che in occidente è
occupato senza dubbio dall’inglese, grazie anche alla
sua adattabilità, che la rende idonea a specializzarsi
in tanti linguaggi diversi.
Dall’altro lato si afferma l’esigenza di avere
dei contenuti originali da trasmettere, che fatalmente sono
elaborati nella propria lingua madre o addirittura nella lingua
del proprio ‘microcosmo’ socioculturale di riferimento:
un professore universitario padovano possiede una lingua di
riferimento molto diversa dalla musicista barese o dal poeta
genovese, come diverso è il contesto in cui questi
personaggi si muovono.
Insomma, sembra un paradosso, ma proprio mentre la lingua
acquista gradi di stilizzazione e di minimalizzazione in microtesti
(dagli sms alle e-mail), tanto più si sente lo stretto
legame della lingua con la cultura che in essa si riflette.
Un simile fenomeno coinvolge particolarmente l’area
culturale dell’Italiano: ad esempio, da una ricerca
condotta qualche tempo fa dall’Unione Latina è
risultato che la lingua italiana è molto presente nel
web, soprattutto nell’ambito di siti culturali (circa
il 3% del volume globale di comunicazioni in rete) e comunque
certamente molto più presente in rapporto alla relativamente
esigua popolazione che parla l’italiano.
E’ noto pure che non solo gli stimoli provengono dalle
istituzioni culturali – dall’Accademia della Crusca
alla Società Dante Alighieri – ma da studi e
ricerche statistiche è noto che gli stranieri che studiano
l’italiano all’estero vanno aumentando in misura
esponenziale, con una crescita di circa il 60% nell’ultimo
quinquennio, tanto che l’italiano sta avvicinandosi
al tedesco e allo spagnolo.
In particolare nelle scuole tedesche l’italiano, per
scelte governative, sta acquistando sempre più consensi.
Da ricerche di marketing, sembra che la lingua italiana sia
percepita all’estero come un riflesso del ‘buon
vivere’ italiano, dalla cucina all’arte, al paesaggio,
alla musica, alla qualità di vita non solo in termine
di durata ma di piacevolezza. Insomma, gli stranieri studiano
volentieri l’italiano per riflesso della propensione
che hanno verso il nostro Paese e i suoi abitanti. E’
quasi un revival del mito dell’Italia del Grand Tour!
Sarà anche che l’apprendimento di una lingua
straniera, oltre ad essere un mezzo di autopromozione professionale,
è scientificamente riconosciuto come un mezzo eccellente
di quella ginnastica mentale oggi chiamata mind building (costruzione
della mente) che aumenta la nostra densità neuronale
nella sostanza grigia del nostro cervello.
In Italia, le ultime statistiche permettono di rilevare che,
se l’inglese continua ad essere la lingua più
studiata dai nostri compatrioti (circa il 78%), molti iniziano
a scegliere anche lo spagnolo (il 10%), la lingua più
diffusa nel mondo in termini numerici (negli stessi USA segue
dappresso l’inglese). Gli Italiani si stanno avvicinando
anche a lingue complesse come l’arabo o il cinese, mentre
lo studio del francese e del tedesco è decresciuto
considerevolmente nell’ultimo quinquennio.
Per quanto riguarda il latino, notoriamente nei licei italiani
è studiato come una lingua morta, a differenza dei
Paesi del nord (a partire dalla Germania); in Finlandia l’emittente
di Stato (Yle) da circa quindici anni trasmette un giornale
radio settimanale (Nuntii latini) interamente in latino. Il
programma dura cinque minuti e raccoglie gli avvenimenti più
importanti nazionali e internazionali della settimana e le
più significative notizie scientifiche e culturali.
Nel Paese vi sono molti studiosi ed estimatori della lingua
latina che sostengono che l’insegnamento del latino
è fondamentale perché è una delle identità
comuni dell’Europa e quindi dovrebbe non solo essere
studiato come una lingua morta ma in maniera da scriverlo
e parlarlo correttamente al pari di un’altra lingua
viva.
In questo contesto generale di ‘difesa della lingua’
è apparsa recentemente sulla stampa la notizia che
nel Lazio è stata - su input dei Verdi e con il plauso
dei leghisti - addirittura approvata una normativa per sostenere
i dialetti laziali, anche attraverso la creazione di un Istituto
per la Tutela e la Promozione dei Dialetti del Lazio.
Una simile iniziativa ha ricevuto l’apprezzamento anche
del più grande linguista italiano, Tullio de Mauro,
che però in un recente articolo su l’Unità
ha messo in guardia contro operazioni di sapore campanilista
e per lo più artificioso, ricordando che un singolo
dialetto laziale non è mai esistito.
In effetti, nell’ambito di questa apparente necessità
generalizzata di difesa a oltranza della Lingua (con la ‘L’
maiuscola) e della sue insostituibili funzioni di espressione
e di comunicazione, si tende a dimenticare che quando ci si
erge a ‘paladini’, a monte deve esserci una implicita
‘scelta culturale’, che non appare così
scontata nel caso dei dialetti, quanto meno perché
hanno storie socio-politiche molto differenti, dai linguaggi
delle terre irredente al vernacolo di carattere più
popolare o spettacolare oppure semplicemente caratteristiche
‘estetiche’ più o meno gradevoli.
Ed è rischioso pensare che un dialetto è più
valido di un altro e più meritevole di tutela perché
ad esempio nobilitato dal Belli o da Trilussa...
Sarebbe inoltre da considerare che i dialetti per loro natura
sono dinamici e mutevoli perché ‘seguono la vita’
e perciò sono insofferenti -per definizione- ad una
cristallizzazione e ad una loro istituzionalizzazione che
appare quasi una ‘contraddizione in termini’.
Ma
le parole non le posso amare. Ecco perché le dottrine
non contan nulla
per me: non sono né dure né molli, non hanno
colore, non hanno spigoli, non
hanno odori, non hanno sapore, non hanno null'altro che parole.
Forse è questo ciò che impedisce di trovar la
pace: le troppe parole.
HERMANN HESSE, Siddharta
Un
libro o una lettera può costituire un'associazione
più intima fra esseri
umani che distano migliaia di chilometri l'uno dall'altro,
di quanto non
esista fra conviventi sotto lo stesso tetto
JOHN DEWEY, L'Arte come esperienza
Da
un'intervista a Salvatore Settis (in occasione della
querelle sulla definizione di Buttiglione alla Commissione
Europea degli
omosessuali come peccatori) : "ciò che è
linguisticamente corretto è
anche socialmente corretto"
“Ogni
parola ha confini fluttuanti. Sfruttare questo dato di fatto
ai fini del risultato estetico è il segreto dello stile”
ARTHUR SCHNITZLER, La trasparenza impossibile
|
Torna
su
|
Mostra
internazionale
Il Codice Atlantico
nell’edizione Hoepli 1894-1904
curata dall’Accademia dei Lincei
|
|
La mostra dedicata al Codice Atlantico di
Leonardo da Vinci è legata a una delle più prestigiose
collezioni di modelli di macchine realizzati per il Museo
Leonardiano di Vinci e al più importante documento
storico sugli studi dei manoscritti vinciani.
Infatti l'edizione Hoepli del 1894 del Codice Atlantico, curata
dall'Accademia dei Lincei, coincise con l'avvio della trascrizione
integrale e degli studi più sistematici sulle tavole
contenute nel più famoso e consistente fra i codici
leonardiani.
Istituzioni importanti, come il Museo Leonardiano di Vinci
e l'Accademia Nazionale dei Lincei, conservano le rare copie
di quell'edizione che oggi, dopo il restauro dell'originale,
costituisce l'unica opportunità di rivedere l'Atlantico
così come Pompeo Leoni lo "costruì",
alcune decine di anni dopo la morte di Leonardo.
Una selezione significativa e commentata delle tavole dell'Atlantico
accompagnata da un catalogo di oltre 250 pagine a colori in
inglese, italiano e tedesco ha consentito di realizzare la
più imponente mostra di carattere divulgativo sul codice
vinciano. Circa settanta supporti ospitano le tavole e pannelli
introduttivi aprono le sezioni in cui l'allestimento è
stato diviso. La mostra si sviluppa in un percorso di oltre
90 metri e si estende su una superficie di circa 400 mq.
Le sezioni in cui
è divisa la mostra
La mostra è divisa in 3 sezioni: la prima è
dedicata al lavoro di Pompeo Leoni, lo scultore che raccolse
i manoscritti leonardiani ordinandoli in un grande volume
oggi conosciuto con il nome di Codice Atlantico.
La seconda sezione esamina la struttura del Codice, e le tavole
selezionate raccontano il modo di
lavorare di Leonardo e l'ampiezza dei suoi interessi. La terza
sezione è dedicata al restauro che l'Atlantico ha subito
fra il 1962 e il 1972. Vengono documentate le scoperte (in
verità poche) fatte scollando i fogli che Pompeo Leoni
aveva unito e anche i danni che il restauro ha provocato.
I materiali
I materiali esposti sono soprattutto le tavole leonardiane
dell'Accademia Nazionale dei Lincei, selezionate secondo i
criteri sopra ricordati e prodotte a partire dal 1894 su carta
speciale Fabriano e con la tecnica dell'eliotipia.
Inoltre un numero significativo di macchine, realizzate sulla
base dei disegni leonardiani negli anni '50 e facenti parte
della collezione del Museo Leonardiano di Vinci, arricchisce
l'esposizione aggiungendo un motivo di forte attrazione.
In questa sezione vengono esposti anche prodotti ad alta tecnologia
di aziende leader nel proprio
settore produttivo che svolgono il ruolo di testimoni del
progresso tecnologico e scientifico raggiunto dopo cinque
secoli dal Rinascimento.
Il
messaggio divulgativo
L'intento della mostra unisce alla volontà di esibire
in maniera articolata per la prima volta fra il grande pubblico
l'attività di Leonardo la spinta, soprattutto fra i
più giovani, a credere nel valore della curiosità
come molla fondamentale per il progredire della conoscenza.
Leonardo genio curioso è un modello da imitare perché
il rapporto con il sapere non sia mai ritenuto
sufficiente, esaurito.
Mostrare la quotidianità di un grande genio, negli
anni della nascita della scienza moderna, vuole essere una
provocazione per dire che il tempo che ci separa dal Rinascimento
è carico di grandi conquiste ma anche di grandi interrogativi
ancora irrisolti.
|
Torna
su
|
Le
realizzazioni di Francesca Cataldi al Giardino Segreto di
via di Panico
di Laura Fortunato*
.
Come
l’hortus conclusus medievale, ricco al suo interno di
allegorie e metafore, il giardino segreto vuole allo stesso
tempo meravigliare e spingere il visitatore ad indagare e
porsi domande.
In questo spazio, volutamente essenziale, trovano posto dal
26 novembre al 20 dicembre le interessanti opere di Francesca
Cataldi.
Alle pareti spoglie dello spazio espositivo fluide colate
di vetro, posate come morbidi tessuti su rigidi supporti metallici
imprigionano frammenti di ferro; i residui ferrosi sono fermati
e bloccati nel loro processo di degenerazione e sopravvivono,
rinchiusi all’interno del materiale trasparente variamente
modellato dalla creatività dell’artista e dalla
luce stessa che attraversa.
Separate dalla via solo da una vetrata e sospese a mezz’aria,
nuvole leggere e trasparenti, nuvole opalescenti, nuvole più
scure e inquietanti, nuvole inquinate (e gonfie di ferro)
che fanno piovere sulla terra (e si tratta di terra vera disposta
sul freddo pavimento in cemento della sala) ora gocce trasparenti,
ora gocce pesanti e metalliche; e sulla terra tutta l’acqua
si raccoglie; l’acqua pura o inquinata dalle scorie
e rifiuti della società industriale che le nuvole hanno
“catturato”; nuvole che sono metafora del mondo
e della vita, come le architetture naturali e artificiali
del giardino segreto medievale.
26
novembre - 20 dicembre 2004
Vernice il 26 novembre ore 18,30
*
Laura
Fortunato è una giovane architetta che svolge la sua
attività professionale sul campo soprattutto nel restauro
di complessi monumentali in regioni piene di storia e ricche
di città d’arte come l’Umbria e le Marche.
Laura è una delle prime socie di webtimec, che ha sempre
partecipato attivamente alle iniziative dell’associazione
ed è stata una collaboratrice preziosa della rivista
ItalyVision -che molti dei soci ben conoscono- su cui sono
comparsi molti suoi articoli scritti con una prosa piacevole
e spesso vibrante, da cui traspare una grande sensibilità
e una notevole cultura estetica, arricchite dalle suggestioni
dei luoghi pieni di storia che ha frequentato nel suo lavoro.
Alcuni titoli: Città e stabilimenti balneari italiani
tra Ottocento e Novecento (ItalyVision n. 6/2003); La dolce
Umbria di inizio Ottocento...(n. 7/2003); Le architetture
degli Ordini Mendicanti nelle città del ‘200
e ‘300 (n. 8/2003); Le architetture delle Certose e
la ‘solenne solitudine’ dei certosini; Paesaggio
della seta e l’architettura delle filande in Vallesina
(n. 3/2004).
Si veda anche la sua autopresentazione nella pagina:  Struttura Struttura
|
Torna
su
|
Il
boom di Google
Le strategie dei motori di ricerca.
di Fiammetta Lozzi Gallo
5 ottobre
- Google, il motore di ricerca più utilizzato del mondo,
è arrivato alla cifra vertiginosa di 300 milioni di
navigatori al giorno ed ha registrato un + 56% dall'ingresso
in Borsa il 18 agosto scorso.
Recentemente, ha lanciato il suo sito in cinese-mandarino.
Per riuscire nell’impresa ha firmato a fine settembre
un compromesso col governo di Pechino che minacciava di inserirlo
nel suo indice dei siti proibiti. Il motore ha di fatto applicato
lo stesso filtro governativo alle sue ricerche, limitando
così fortemente lo spirito libero delle ricerche in
Rete, ma potendo così lanciare la nuova interfaccia
e raggiungere un mercato gigantesco. Gli analisti di borsa
esultano e investono.
Il futuro per i motori di ricerca è, secondo gli esperti
del settore, nella pubblicità sponsorizzata cioè
quelle righe di testo che vediamo a destra della schermata
quando lanciamo una ricerca: mentre il traffico nel motore
cresce, sale in proporzione il "prezzo per click",
cioè il prezzo che l’inserzionista deve pagare
al motore di ricerca per apparire tra i risultati delle ricerche
per parole-chiave.
Nel frattempo, per cercare di rispondere ai successi di Google
e riconquistare gli utenti, gli altri motori di ricerca -
tra i quali giganti del settore come Yahoo! - cercano nuove
strategie.
Yahoo! ha lanciato Yahoo Local, un motore di ricerca su base
locale. La società vuole infatti fronteggiare Google
proprio sul suo terreno privilegiato: quello del business
regionale. Google si vanta di poter essere il veicolo ideale
per la pubblicità anche del ‘tassista di Londra’
o del ‘salumiere di Chicago’.
A metà settembre Amazon, la gigantesca libreria virtuale,
ha invece proposto ‘A9’, un motore di ricerca
personalizzabile: l'utente vi può trovare citazioni
e brani di libri, può scrivere on line e mettere segnalibri...
...
e vinca il migliore!
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|