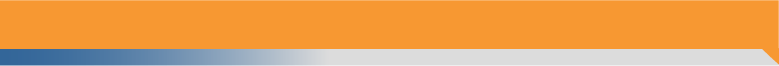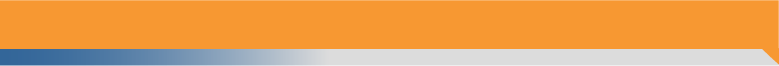|
“La
Luna di Carta”
di Andrea Camilleri
di Paola
Sereni
|
 |
Di
Camilleri si è già detto tutto, ha vinto tutti
i premi possibili, è al top delle vendite da sempre,
tanto che ormai nelle statistiche dei libri venduti è
considerato un fenomeno a parte: è notoriamente l’autore
vivente più lealmente festeggiato dalla critica, dagli
editori, dai lettori occasionali e non. E’ il fenomeno
letterario del decennio a cavallo del 2000 e perciò è
difficile lodare, senza rischiare di dire cose abusate e applicabili
ad ognuno dei suoi formidabili, strepitosi racconti, il suo
ultimo libro, La luna di carta -che presumibilmente sta villeggiando
in migliaia di copie insieme ai rispettivi acquirenti sotto
gli ombrelloni, nei rifugi alpini, in viaggio nei treni, aerei
e mezzi di trasporto in Italia e all’estero.
Tutti quelli che l’hanno letto definiscono il libro divertente,
leggero, vacanziero e si rendono conto che -tra l’ascoltare
le chiacchiere del vicino di ombrellone o dell’ospite
del comune albergo, conosciuto da poco- è più
piacevole abbandonarsi alla fascinazione delle metafore garbate
e accattivanti di Camilleri e soprattutto alle presentazioni
-attraverso flash semantici- delle situazioni e dei personaggi,
soprattutto quelli femminili: il paio d’occhi di Michela…
“preciso ‘ntifico a un lago viola e funnuto nel
quale sarebbe parso a tutti i mascoli bellissima cosa tuffarsi
e annigare in quelle acque…”
Le gambe di Elena Sclafani “…longhe di natura sò,
niscenno fora da quel giacchittuni rosso, parivano interminabili…”
Con i personaggi maschili è più cattivo: intanto
con i suoi collaboratori che usufruiscono di un trattamento
reiterato di brusca ma bonaria derisione (Catarella riferisce
delle telefonate di Lattes, storpiandolo “sempre”
in “Latte con la esse in funno” oppure chiama costantemente
la password del computer “guardia ai passi che non lo
fa passari…”; il suo seppur valido collaboratore
Augello è indebolito dalle sue ansie di padre per il
suo “Salvuccio” (e né lo salva dai sarcasmi
del commissario, anzi aggrava la situazione aver chiamato il
figlioletto come il suo capo).
Ma soprattutto riguardo agli specifici personaggi de La luna
di carta… impietosamente: “la lampo dei jeans [del
morto, protagonista dell’intreccio e al centro di vizi
e passioni] era aperta, lo stigliolo gli pinniva tra le gambe”;
il marito (che non consumava) “da cornuto pacinzioso era
cangiato in vestia feroce…” ecc. ecc.
E perciò, indipendentemente dall’intreccio dei
fatti raccontati ne La luna di carta che non è né
particolarmente coinvolgente né particolarmente originale,
chi non l’ha ancora letto perché magari pensa che
sia “inutile”, si rassegni a farlo: gli rimarrà
dentro qualcosa dello straordinario senso dell’humour
e del linguaggio immaginifico e frizzante dell’autore
o -quantomeno- qualcuna delle sue espressioni fascinosamente
sinestetiche: “La giornata pareva di porcellana…”
oppure qualche descrizione di persone genialmente azzeccata:
a chi -vedendo D’Alema accompagnato da -tanto per fare
un esempio- un tipo alla Dellera- non è rivenuto in mente
da non so più che racconto di Camilleri la descrizione
di una coppia: “lui di baffo stretto, lei di sostanziosa
bellezza…” oppure vedendo una giovane donna in una
decappottabile con motore rombante: “dipartirono con un
tripudio di cosce al vento…” E
sicuramente saranno ancor più lieti e gratificati i
lettori di sesso maschile dalla lettura del libro: perché
il commissario Montalbano ha eclissato nell’immaginario
collettivo tutti i commissari letterari e cinematografici
(con la sola probabile eccezione di quelli francesi di Simenon
e Jean Gabin… ). E anche perché è facile
e sottilmente consolatorio per un lett-ore identificarsi nella
speciale virilità di Montalbano con le simpatiche,”innocue”
debolezze e indecisioni che l’accompagnano, sempre ben
autogiustificate (Montalbano, di nette e malcelate tendenze
niciane si crede “in buona fede” depositario del
bene e del male…). Tanto più che da lui traspira
una fin troppo consapevole adamantina onestà e fiuto
professionale, uniti ad un aprioristico disprezzo per l’autorità
costituita e i suoi superiori gerarchici che sono sempre -loro
sì- sbeffeggiati da Montalbano-Camilleri perché
immersi nella loro fatale e immutata miopia.
Anche di queste ultime sue eccezionali qualità umane
e professionali il commissario è pienamente conscio,
anche se a volte finge con se stesso, nelle sue elucubrazioni,
un abbozzo di autocritica -in realtà autoassolvendosi
come tutti facciamo- tanto che va avanti per la sua strada
sempre, nella ferrea fiducia che Camilleri -alla fine- gli
darà sempre ragione…
|
Torna
su
|
“L'Isola
d'Arturo”
di Elsa Morante
di Michele
Mocciola
|
 |
Agosto
è un mese un po’ particolare: è un inarrestabile
ritorno. Si ritorna alla vacanza ma si ritorna dalla vacanza,
si ritorna al mare, alla spiaggia di sempre, al sole, si ritorna
a quelle amicizie che soltanto con i piedi a mollo oppure nella
sabbia calda riescono a sopravvivere, si ritorna alla svestitudine,
primordiale, alla essenzialità dei movimenti per poi
tornare – si dice – rigenerati ad uno stile quotidiano
affatto diverso, intanto che ritornano le prime piogge. E’
un continuo andirivieni, quello che in agosto si consuma sotto
i nostri occhi. Si torna anche a leggere, perchè c’è
più tempo – pare; in genere si scelgono libri freschi,
recenti, perchè durante l’anno non sembra ci sia
spazio per tali oziosità. Sarebbe però il caso
di celebrarlo meglio questo mese del ritorno, integralmente,
sfogliando di nuovo libri datati eppure indimenticati, e se
poi si tratta di un romanzo dove il sole e il mare, le partenze
e i ritorni sono all’ordine del giorno, potremmo dire
di aver goduto a tutto campo di questo mese così articolato.
Il libro in questione è: L’isola di Arturo, di
Elsa Morante.
L’isola di Arturo è un grumo in gran parte maschile:
la scrittrice Elsa Morante lo scioglie e lo regala, a noi, uomini
e donne, che di meglio non sappiamo fare, imponendo però
di purgarci in acque assolate, stagioni calde e amare, alti
e bassi di fronti misteriosi, lontano dalla terra ferma, relegati
tra i colori forti i sapori e gli odori di un’isola del
mediterraneo. E’ su quella isola, e solo lì, assenti
regole a noi ben note, distanti dai tempi di costrizione, privi
di coscienze artefatte, psicologismi di comodo, ragionamenti
edulcorati e atteggiamenti fittizi, che possiamo riscoprire,
riscoprendoci, di sapere amare, innamorandoci, godendo di ciascun
giorno intriso di un tale sconosciuto amore.
Il mistero degli uomini non è più tale, per gli
uomini come per le donne, dopo L’Isola di Arturo, impudicamente
svelato eppure mai, per un secondo neppure, esibito ostentato
divulgato: tutto resta attaccato ad una pelle bruciata dal sole
estivo, agli occhi significativi, alle movenze ai silenzi, a
questi ultimi in particolare; mai come in questo grande romanzo
il silenzio ci racconta una trama appena appena percettibile,
a volte sbeffeggiata – Vattene parodia – eppure
così tanto maschile, abituati come siamo, diversamente,
a vincolarci a categorie tutte insieme perse in una decadente,
ostinata, irritante: femminilità.
|
Torna
su
|
“Colpo
di spugna”
di Jim Thompson
di Paola
Sereni
|
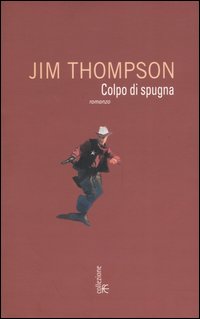 |
Strane
pulsioni letterarie per i vacanzieri… d’estate
va forte tra gli intellettuali a riposo la letteratura noir
italiana o straniera. E’ il momento che -a parte il
familiare e ormai innocuo Montalbano tempestivamente uscito
in concomitanza con i tempi della valigia- si riscoprono gli
autori più crudi: i Lucarelli, i Carofiglio, i Piazzese,
i De Cataldo… ma anche Jim Thompson.
La Repubblica ha tempestivamente pubblicato in questi giorni
un racconto di Thompson sull’inserto settimanale e così
si è aperto un rinnovato interesse per questo scrittore
americano tra Faulkner (non lo Steinbeck delle nostre letture
giovanili, troppo “ottimista” sulla natura umana…),
John Fante (troppo “trasognato”nella sua alienazione
circa i sentimenti e le emozioni…) e Bukowski (troppo
“romantico” nelle sue descrizioni porno…).
Chi scrive ha riletto “Colpo di spugna”: non è
l’ultimo pubblicato da Fanucci, ma quello più
autobiografico e non soltanto perché Thompson -come
di consueto- ricorre all’espediente letterario dell’io
narrante. Ma perché i fatti descritti non sono importanti,
così come non lo sono nella pornografia propriamente
detta: il libro infatti è, non tanto per i fatti che
descrive ma per le elucubrazioni -fintamente autogiustificative
ma consapevolmente elogiative- sulle malefatte compiute o
progettate che Thompson mette in bocca al protagonista: lo
sceriffo Nick Corey, la più pura pornografia intorno
alla natura umana.
Alla luce della poetica di Thompson i principii filosofici
di Hobbes sono roba da oratorio, i crimini della Storia: le
guerre, l’Inquisizione, il nazismo, il terrorismo sembrano
essere fisiologici alla natura umana e una inevitabile conseguenza,
se si moltiplicano i pensieri del protagonista (qui non si
può neppure definire eroe negativo) per i 4 miliardi
di persone del Pianeta e cioè se si pensa che la Storia
è fatta della somma di tante psicologie e comportamenti
individuali.
Ma gli americani -anche se Grandi- in letteratura come nel
cinema, nel teatro, nelle arti visive, hanno una caratteristica
nel loro DNA: considerano (o meglio: invidiano) la Cultura
come un fatto marginale, pur se importantissimo, nella vita
di un Paese, mentre per noi europei -via via spudoratamente
semplificando- è l’unico elemento portante e
positivo della nostra società, in grado di nobilitare
(o almeno provarci) i nostri sentimenti e le nostre azioni.
Del resto, nella Costituzione americana è espressamente
previsto il “diritto a perseguire la felicità”,
nella nostra democrazia alla base di tutto c’è
(o ci dovrebbe essere) la libertà, nel senso di “libertà
dall’ignoranza” che è spesso illusoria
ma la sola degna di orientare e quindi anche qualificare i
nostri comportamenti.. Ed è perciò che Nick,
lo sceriffo brutale, volgare, che ammazza, tradisce, pensa
sempre sporco e insozza tutto quello che lo sfiora, è
sì un personaggio disperante ma così abissalmente
ignorante e perciò lontano da noi che le sue avventure
ci divertono e ci “distraggono” dalla nostra vita
quotidiana intellettuale e reale.
|
Torna
su
|
| "La
scienza degli addii", di Elisabetta Rasy
di Paola Sereni
Nadezda
Chazina non ha ancora vent'anni quando, in un cabaret di Kiev
per artisti e bohémien, incontra un giovane dalle lunghe
ciglia che recita versi misteriosi e incantatori. Lui è
il bizzarro e anticonformista Osip Mandel'tam: uno dei più
grandi poeti del Ventesimo secolo.
Lei non sa ancora nulla della vita, ma il cuore e la mente
le suggeriscono che amare quel personaggio vuol dire diventare
donna, attraverso la fascinazione eterna di un’educazione
sentimentale compiuta dall’uomo, amato che diventa il
suo leader personale, il portatore di un modello di vita e
di pensiero mai discusso.
Nella Russia sconvolta dalla rivoluzione e dalla guerra civile,
tra speranza e paura, nasce un amore destinato a diventare
leggendario. I due si amano in maniera parallela e opposta:
lui ama Nadezda come una creatura sua, nata quando l’ha
conosciuto: è la sua creazione poetica vivente, lui
la inventa giorno per giorno: lei è la sua compagna
di traversie, la sua confidente ma anche il suo amico, il
suo uccellino, una cosa sua; gioca con lei dandole mille ruoli,
gioca anche con il suo nome deformandolo in mille diminutivi
e vezzeggiativi. La figura universale e mitica di Pigmalione,
celebrata nella società occidentale in letteratura
e arti visive, è sempre presente. |
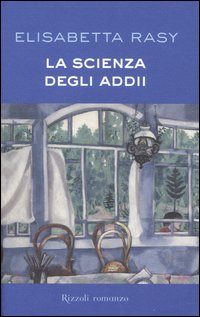
|
|
Lei lo ama -apoditticamente- perché,
dopo il fatale incontro, lo ha scelto, perché è
un “dato” nella sua vita: lui “è”
la poesia ed è tutto il bene che offre la vita e tutto
quello che lei desidera è perché lui lo desidera.
Lui parla, lei ascolta, lui crea versi e lei umilmente copia:
lui è la voce, lei la mano che scrive e poi sarà
la memoria storica di lui e dei suoi versi.
Lui si dedica ad altre donne e lei trova la forza di sopportare
perché preferisce vederlo vivo e appassionato piuttosto
che avvilito dalla povertà e dai disagi della vita
quotidiana.
Lei esiste attraverso di lui e i suoi speciali amici e conoscenti,
che non sono per lei che un pallido riflesso del suo genio.
Separati per quasi due anni dalle turbolenze della storia,
Nadezda e Osip si ritroveranno nel 1921 e non cesseranno di
amarsi del loro speciale amore fino a quando, nel 1938, al
culmine del terrore staliniano, Osip sarà deportato
e morirà in un campo di concentramento in Siberia.
Lei, tra persecuzioni e disagi, troverà un motivo di
sopravvivenza nella sua missione: far sopravvivere i versi
di Osip perché sono universali e il mondo, nel suo
lento risollevarsi, ne ha più che mai bisogno.
In questo libro laico si celebra -insieme-
l’amore per un uomo e per il suo genio vissuto come
l’unica -laica- fede ed è perciò che si
distingue da altri grandi romanzi incentrati su un amore scelto
per “destino”da una donna (ricordate “La
scatola nera” di Amos Oz?): qui è la poesia con
la sua potenza vincente e lenitrice che tutto trasfigura e
tutto nobilita, anche la Storia.
Il grande amore di Nadezda è un amore succubo, un amore
umile e grande nella sua dedizione che sublima l’amore
per Osip nell’amore per la Poesia nel suo aspetto più
puro: la passione di Nadezda è perciò anche
un inno alla Libertà, minacciata - in un contesto assurdamente
e brutalmente autoritario - dalla malvagità di persone
e circostanze che impediscono anche i più minuti piaceri
di cui si nutre la vita e che può essere neutralizzata
soltanto in una visione più ampia, trascendente, con
una sdegnosa e apparente indifferenza che cela -nel profondo-
una passione bruciante e un elegiaco rimpianto per ciò
che poteva essere e non è stato.
|
Torna
su
|
“Non
c’è problema, chiaramente”
di
Lucio Mariani
In
merito al tema ampiamente trattato in questa pagina web sulla
Lingua italiana, pubblichiamo un brano-divertissement inedito
del nostro amico, poeta e scrittore Lucio Mariani sulla corruzione
che subisce e i malvezzi che la infiorano. Il brano risale
a parecchi anni fa ma è "chiaramente" tuttora
valido...
|
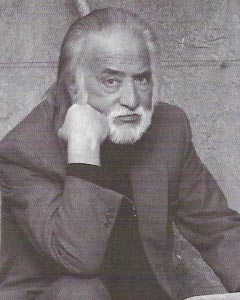 |
La nostra
lingua è in pezzi, sconnessa, sbriciolata. Ridotta
all’osso come deve essere uno strumento di comunicazione
generalmente utilizzato, senza troppe varianti per evitare
equivoci, senza dettagli per economizzare sui sogni e le divagazioni:
insomma un ritorno all’antico per essere moderni, nel
rispetto delle normali e brutali contraddizioni della “macchina”.
Lo stesso parlato, designato a soppiantare lo scritto nella
sempre più dirompente civiltà visiva, viene
minacciato dal “vocale” o meglio dal “sonale”:
si domanda, si interloquisce, si minaccia, si risponde, si
gioisce per grugniti, ululati, uggiolii, singulti.
Mentre questa mutazione si va compiendo, mentre il congiuntivo
va diventando un reperto, assistiamo all’invasione,
allo sparpagliamento, all’atomizzazione di alcune parole
o espressioni chiave che – nell’uso indifferente
che se ne fa – costituiscono un vero esercizio di vaniloquio,
prove generali di evirazione del significato e del significante.
Primo esempio. “Non c’è problema”
e sue variazioni. Questo modo di dire ha fatto una lunga strada
per arrivare a noi. Partendo dagli Stati Uniti, dopo una bella
sosta in Sud America è sbarcato in Europa Latina. In
Italia ha soppiantato definitivamente e indifferentemente
il “sì” e il “va bene”, la
sua ambivalenza risolvendosi nel tipo di domanda o di proposta
cui risponde. Ecco come: “Posso venire a cena?”
“Non c’è problema” (funzione del
sì): “Non vorrei parlare con nessuno al telefono”
(funzione del “va bene”). Ora, questa locuzione
affermativa che si nutre di una negazione, questa locuzione
più rassicurante che affermativa dalla formulazione
impropria (l’italiano pretenderebbe
semmai “Non c’è alcun problema”),
è una cretineria vera e propria che la dice lunga sulla
cultura e sui gusti dell’emittente.
Secondo esempio. “Chiaramente”. L’avverbio
ha perso ogni contatto con la luce così come ogni funzione
correttiva del verbo. Oggi, ripetuto fino all’ossessione,
secondo nell’uso e nella memoria storica solo al nefasto
e defunto “cioè”, vuol dire: “senz’altro”
o non vuol dire niente, è un puro flatus vocis
che viene infilato con compiacimento nei posti più
impensati del discorso.
Il massimo della perversione è rappresentato da questo
dialoghetto da me ascoltato: “Andiamo al cinema?”
“Non c’è problema, chiaramente”.
Sullo
stesso argomento leggi gli articoli di Paola Sereni:
La lingua italiana: Severgnini scopre l’acqua calda,
La lingua italiana non ha bisogno di essere amata ma rispettata
Lingue,
linguaggi e dialetti
|
Torna
su
|
L'uso
del colore e le indefinibili pennellate di Boldini
(Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma)
di
Francesca Montuori
|
 |
|
Si è
inaugurata a Roma la retrospettiva dedicata a Giovanni Boldini
(1842-1931) promossa dalla Fondazione di Palazzo Zabarella
di Padova (dove la mostra è rimasta aperta fino al
29 maggio scorso) in collaborazione con il museo Boldini di
Ferrara e la Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti
di Firenze.
I curatori della mostra - Francesca Dini, Fernando Mazzocca
e Carlo Sisi - hanno selezionato più di cento opere,
giunte per l’occasione da musei e collezioni private
italiane, europee e americane, che permettono di approfondire
la conoscenza e (ci auguriamo) gli studi e le ricerche su
questo straordinario e spesso sottovalutato artista italiano.
Il merito di questa importante e imperdibile mostra è
infatti quello di poter vedere, per la prima volta dopo più
di quarant’anni, opere di Boldini raramente esposte
l’una vicina all’altra, e di poter comprendere
le sue straordinarie qualità di pittore.
Nato con un’invalidità fisica che gli varrà
più tardi l’appellativo di “gnomo”
(nomignolo inventato dal famoso critico d’arte Diego
Martelli) Boldini si rivolse presto al disegno e alla pittura,
percorrendo una strada - a quell’epoca quasi forzata
- all’interno dell’Accademia di Firenze, fortemente
contestata dal movimento dei Macchiaioli. Ed è proprio
da qui e dal caffè Michelangelo, dove spesso si recava
Fattori, che parte il suo eccezionale percorso artistico che
lo portò presto a sperimentare nuove tecniche e un
nuovo utilizzo della materia pittorica, divenuta nel tempo
co-protagonista delle sue opere.
Boldini ha avuto sicuramente una grande fortuna rispetto a
molti artisti suoi contemporanei e - in parte - anche amici:
fu pittore di successo, ricercato e certamente anche ben pagato
dall’alta borghesia italiana e francese, accolto nei
principali salotti culturali, amico di artisti (oggi più
che noti) quali Degas, Manet e Sisley. Non si fece certo mancare
nulla nella sua lunga e invidiabile vita: e tutto questo era
sempre stato sotto i nostri occhi, abituati a vedere nelle
sue opere un riflesso di quella “belle époque”
fatta non di ballerine scollate e spesso anche un po’
brille (come le ritraeva Toulouse Lautrec), ma di vestiti
e cappellini alla moda, di bellissime dame, di eleganti artisti
e intellettuali colti all’interno di raffinati salotti.
Ma questa retrospettiva ci rivela qualcosa in più:
per quanto appartenente ad un mondo diremmo quasi ovattato,
Boldini fu un attento conoscitore di tutte le avanguardie
(anche degli artisti che non ebbero subito un’eco internazionale)
che si succedettero in quel magico periodo a cavallo tra il
XIX e il XX secolo e che rivoluzionarono completamente l’arte
occidentale. Basti guardare alla sua assoluta anti-classicità
nell’inquadratura delle immagini, nella scelta del punto
di vista, nella stesura del colore, ma soprattutto alla vorticosa
dinamicità delle sue opere, in particolare di quelle
più tarde (come la celebre Marchesa Casati con penne
di pavone del 1915 e qui esposta) che dimostrano come Boldini
accolse spunti e suggestioni dai macchiaioli come dagli impressionisti,
dai veloci schizzi di Toulouse Lautrec come dagli affascinanti
paesaggi di Sisley, fino alle eccentriche sperimentazioni
dei futuristi (il cui manifesto ricordiamo è del 1909),
sempre reinterpretando a suo personalissimo modo ogni nuova
proposta del poliedrico mondo dell’arte che si muoveva
tra l’Italia e Parigi. Una sperimentazione che non rimase
lettera morta, ma che a sua volta fu motivo di nuove ricerche
per i giovani pittori che muovevano i primi passi nel periodo
fra le due guerre: se ricordate qualcuno dei fiori di De Pisis
non potrete non riconoscerne gli antecedenti in alcuni particolari
delle opere più tarde di Boldini.
Ma quando sarete davanti ai suoi quadri (grandi e piccoli
che siano), dopo averli apprezzati da una giusta distanza,
fate un passo in avanti, avvicinatevi alla tela e guardatela
da vicino: scoprirete un nuovo mondo, un’incredibile
maestria nell’uso del colore, denso e materico, quasi
tridimensionale nelle vesti, nei fiori, nei gioielli resi
con poche, indefinite pennellate; un colore che però
si raffina fino a diventare leggero e velato, quasi trasparente
nei volti e negli sguardi. Un colore che da vicino sembra
quasi il pastrocchio di un bambino, impastato e secco, ma
che - facendo di nuovo un passo indietro - si scopre essere
attento e mai casuale, dinamico tanto da essere quasi “sfocato”,
e tale da accompagnare il nostro sguardo lungo un percorso
all’interno del quadro fino a quell’unico elemento
“fermo” che il più delle volte si rivela
essere uno sguardo vivo e penetrante, e che - in barba alla
statica classicità - sembra doversi volgere altrove
da un momento all’altro. E se non credete che tutto
ciò sia studiato e voluto, soffermatevi a guardare
i disegni, e rimarrete sorpresi!
|
Torna
su
|
Recensione
de: “TU NON C’ENTRI”
di Fe. Al.
Chi entra nel mondo di Elena?
Si diventa grandi facendo subito la cosa giusta o sbagliando
molte volte? Si trova un amore per sempre o cercandolo disperatamente,
concedendosi a tutti e dunque a nessuno? Si scrive immediatamente
un capolavoro, ovvero il libro della vita, o ci si muove lentamente
sperando in una vita di libri?
Se dovesse rispondere a un fantomatico test, Letizia Muratori,
al suo primo romanzo appena arrivato in libreria con Einaudi
Stile libero, metterebbe la crocetta sempre su B. |
 |
| Il suo “Tu non c’entri”,
sprazzo di vita di una quindicenne come tante e come nessuna,
figlia di una quarantenne come tante e come nessuna, è
un tuffo in una generazione che l’autrice osserva come
un’appassionata cronista. La Muratori, infatti, ha poco
più di trent’anni e dunque non è né
Elena, né la sua sbadata mamma. Eppure la sua scrittura,
che non si fa mai gergo giovanilistico, riesce a portarti
in quel mondo di ragazze e ragazzi troppo grandi e insieme
troppo piccoli che vedi a frotte nelle piazze romane, davanti
ai licei dove le lezioni sono già iniziate, o anche
nei parchi, ma muniti di zaino e tutto quel che servirebbe
per essere altrove.
Elena fa sesso con tutti, ma non si spoglia. Ha una storia,
ma non la esibisce. Forse ha anche un sentimento, ma tanto
vale non mostrarlo visto che nessuno riesce a entrare nel
suo quasi autismo. La Muratori sa raccontarla senza farla
diventare un’eroina dei suoi tempi. Sa usare le parole
e le immagini che queste suggeriscono, come dovrebbe fare
una giornalista. Forse c’entra il fatto che la scrittrice
(siamo già alla seconda prova ben riuscita: nell’estate
del 2004 uscì un suo racconto : “Saro e Sara”
in “Ragazze che dovresti conoscere” The sex-anthology,
Einaudi) è anche una cronista: si occupa di cinema.
Chi vuol posare lo sguardo su questi giovanissimi spesso
trasparenti persino ai loro genitori, non perda il libro.
Elena forse non è incinta, non è sfregiata dal
fuoco, non è sola, non è una campionessa di
skateboard, non è un simbolo. Di certo, è una
ragazza. E Letizia Muratori l’ha chiusa in un libro…
aperto come la vita.
“TU
NON C’ENTRI”
di Letizia Muratori
Einaudi Stile libero Euro 9,80
|
Torna
su
|
Sulla
lettura di poesia in un carcere
dalla raccolta: Il
sandalo di Empedocle
di Lucio Mariani*
a
G.G. Belli |
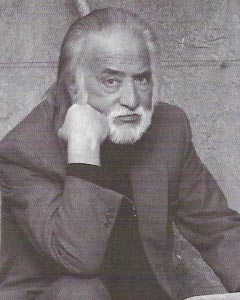 |
S’alzava
maggio a Roma e sulle balze del colle digradante
erano zuffe di menta e di cicoria. Impennata la cannaiola
stava in altalena su ciuffi che scortavano il ruscello
a improvvisare il suo percorso allegro fra le spalle dell’orto.
Dal Gianicolo fino alla Lungara il sole s’ingaggiava
nella gara contro gli embrici biondi per inondare d’una
luce
urgente l’edicola e il selciato.
Camminava su un lato della strada
disegnata dal taglio d’ombra esatto, tenendo a bada
le follie d’un gatto intorno a una borsetta abbandonata.
Era controra e pace. Solo rumori da campagna urbana.
Lettore
appassionato di poeti
qui era chiamato a esercitare l’arte.
Varcò la porta dei destini arresi per incontrare
i resti inquieti di fratelli presi
nei quartieri del male.
Erano i giudicati, gli esclusi, gli Altri
stivati e chiusi nel ventre della fabbrica che ieri
un reggitore di mala ironia
seppe votare alla Regina Coeli.
Tra i muri bianchi il lungo corridoio
lo sospinse su un palco.
Aspettavano in tanti, uguale gente
che non sembrava attendersi più gesto
che non fosse l’affronto. Passarono
minuti di dolore in cui non vide niente.
Adesso impugnò fermo il pulpito nei bracci
e, fra guardiani attoniti, riversò
su quel popolo di stracci vicende d’una grande
poesia. Lesse la carta forte dell’aedo
che affronta Dio
che parla della vita e della morte
dell’anima e dell’io, di voglie nella carne
e della metafisica di colpe
che non hanno mai fine.
Il canto prese il volo e, presto rotte
le astuzie degli stenti in chi ascoltava
sciolse i nodi
compose gli occhi e i visi che si fecero attenti
sgominò le minacce della sorte
ed i colpi di tosse dei dubbiosi – effigi ferme
solo sul passato – ne accarezzò le menti
richiamandoli a un simile vissuto
e aprì i battenti della primavera
al vento dei sorrisi.
Era il finale
e un po’ di luce del maggio romano
si fece strada fra le gabbie scosse,
Se ne
fuggì lontano.
Sulla
lettura di poesia in un carcere” è uno dei componimenti
centrali (oltre che uno dei più belli) della raccolta
Il sandalo di Empedocle di Lucio Mariani: un centro verso
cui convergono le linee di una poetica e di un’ispirazione
che si sviluppa e progredisce da molti anni nella sua opera.
Il potere del verso, che rigenera e salva un’umanità
confusa e degradata, è il tema che qui è reso
con immagini intense, raggiungendo, al tempo stesso, un nuovo
equilibrio formale...
da: “Note sulla lingua di Lucio Mariani“ di
Maurizio Dardano in “Poesia”, Mensile internazionale
di cultura poetica, maggio 2005, Crocetti editore
*
Lucio
Mariani è nato e vive a Roma. Ha pubblicato tredici
raccolte di
poesie. L'Università di Roma III gli ha dedicato un
volume di traduzioni in sette
lingue. Sue liriche sono state tradotte in Francia, Grecia,
Portogallo, Spagna e
Stati Uniti, dove è uscita recentemente un'antologia
poetica "Echoes of Memory" (Wesleyan
University Press, 2003). Una raccolta di suoi poemi "Connaissance
du temps" è in corso di
pubblicazione in Francia da Gallimard (Ed. de l'Arpenteur).
|
Torna
su
|
Perché
la filosofia è “difficile”?
di Alberto Madricardo
Per
quanto riguarda la comunicazione filosofica, è vero
quello che si dice: è spesso difficile, astrusa. A
volte, per lo più, la difficoltà è dovuta
al fatto che i filosofi, avvolgendosi di nebbie verbali, vogliono
darsi importanza e nascondere la pochezza del loro pensiero.
Altre volte l’asperità del linguaggio filosofico
dipende dal fatto che i filosofi usano parole abituali in
modo inconsueto. Il loro linguaggio è acerbo perché
hanno forzato le parole oltre il loro uso abituale, per indicare
qualcosa che non è mai stato detto.
Credo però che la difficoltà principale della
filosofia non sia in realtà quella della comprensione
dei suoi discorsi. La cosa più difficile è rinunciare
alle certezze acquisite. Ed è proprio questo che la
filosofia richiede. |
|
A volte le insuperabili “asperità
del linguaggio filosofico” possono essere un comodo
alibi per non dover mettere in discussione le proprie abitudini
mentali. La difficoltà principale che la filosofia
presenta allora non è linguistica, sta nel fatto che
essa richiede un “innaturale” procedere all’indietro,
a differenza della scienza (almeno nella sua accezione più
comune): non dall’incertezza alla certezza, ma, all’opposto,
dalla certezza all’incertezza, fino all’ideale
crocevia originario in cui l’orizzonte dell’esistenza
è totalmente aperto.
A parte ciò, ci sono, nella filosofia, cose effettivamente
difficili, sia da comunicare, sia da capire. Nessuno pretenderebbe
di capire di primo acchito la teoria dei campi magnetici della
fisica.
Tutti riconoscono che per entrare nell’ambito della
fisica (o della medicina, della biologia, ecc.) ci vuole una
preparazione adeguata.
Chissà
perché si crede che la stessa cosa non sia necessaria
per la filosofia. Forse perché le domande filosofiche
riguardano così intimamente ciascuno, che tutti ritengono
di essere “in diritto”, in quanto esistono, di
averne già le risposte certe. Ma bisogno e diritto
non sono la stessa cosa.
Gli antichi filosofi risolvevano il problema distinguendo
un insegnamento esoterico (per pochi esperti) da uno essoterico,
divulgativo, per i molti. Questo può essere un espediente
praticabile.
Ma secondo me questa distinzione va riconosciuta momento per
momento, mai accettata come scontata e definitiva. Vedo che
non tutti gli uomini sono filosofi, eppure non cesserò
mai di stupirmene.
|
Torna
su
|
A
che serve la filosofia?
di Alberto Madricardo
Mi si
chiede che utilità abbia la filosofia. E’ abbastanza
comune ritenerla inutile, specie in rapporto ad altre discipline
scientifiche che contribuiscono al miglioramento delle condizioni
dell’esistenza dell’uomo.
La filosofia - si dice- è assolutamente inutile. Credo
che questo sia esattamente vero.
La filosofia è inutile nel senso che “non serve
a nulla”. Che non serve a nulla vuol dire che essa,
letteralmente, non è al servizio di nulla. Ciò
che è al servizio di qualcosa è a questo subordinato.
La filosofia non serve a nulla perché non è
mezzo per qualcosa d’altro, è fine. Esser fine
vuol dire proprio non essere in funzione di nulla, “non
servire a nulla”.
La filosofia, insomma, è re, non servitore.
Ora, se consideriamo tutto al servizio - cioè in funzione
dell’uomo - come facciamo per lo più anche senza
rendercene conto - l’unica “cosa inutile”
risulta essere proprio l’uomo stesso, al quale tutto
ciò che è utile viene finalizzato. A che cosa
serve la nostra vita alla quale finalizziamo tutto?
Se adottiamo l’utilità come supremo criterio
possiamo dire che la nostra stessa vita è “inutile”.
Ma se affermiamo che è utile, dobbiamo ammettere che
essa è utile rispetto a qualcosa, a qualcosa che fatalmente
è a sua volta inutile.
Che cosa può essere ciò rispetto a cui la vita
umana è utile? Si potrà dire: una singola esistenza
umana può essere utile agli altri, al genere umano
nel suo insieme. Ma l’umanità è fatta
di individui, non c’è “l’umanità”,
ci sono solo gli uomini in carne ed ossa. Tanti uomini singoli.
Questa vita “più numerosa” non trova nel
numero più senso. Una montagna di sassi non fa una
pepita d’oro.
A che serve la vita
dell’umanità? La risposta dovrebbe essere: a
se stessa. Ma una vita, per quanto intesa come universale,
al servizio di se stessa, è marcata dalla subordinazione.
Importa meno che la subordinazione sia a se stessa del fatto
che subordinazione ci sia. Importa, ed è grave, che
la vita si riferisca a se stessa come ciò che è
al servizio. Una vita al servizio di se stessa è una
vita che vive all’ombra di ciò che serve: in
quanto ciò che serve è se stessa, essa “all’ombra
di sé”. Questo fatto, di essere al servizio di
sé, non toglie nulla, anzi, semmai aggrava, il peso
della servitù. La vita al servizio di se stessa è
una vita essenzialmente infelice. La posizione di Locke, il
maggior teorico del liberalismo, è di considerare la
vita umana essenzialmente come una ricerca sempre inappagata
dell’appagamento, e perciò perennemente infelice.
Va allora
rigettato in toto il criterio dell’utilità? Per
nulla affatto. Siamo stati in qualche modo costretti, per
sopravvivere a considerare il mondo dal punto di vista della
sua utilità a noi. L’umanità per un verso
è portata, diciamo, “istintivamente” a
garantirsi la sopravvivenza, a considerare l’esistere
di per sé un bene. Per questo organizza il mondo in
relazione alla sua utilità per lei. Ma, non appena
questo bene è abbastanza assicurato, cade nella noia,
perché avendo adottato il criterio dell’utilità
per valutare il mondo, scopre di riflesso di essere essa stessa
inutile. L’adozione del criterio dell’utilità
ci fa “salire” di potenza in relazione al mondo,
ma ci fa in proporzione analoga “sprofondare”
in relazione a noi stessi. Più allarghiamo l’orizzonte
dell’utile intorno a noi, più ci sentiamo inghiottiti
nella inutilità rispetto a noi stessi.
La filantropia
- che pone la esistenza umana singola al servizio dell’umanità
- sposta il problema dal singolo all’umanità,
ma non lo risolve. Si potrebbe sospettare che compie questo
spostamento per mimetizzare il problema della inutilità
dietro al paravento della “nobiltà della causa
universale”. Ma, se i singoli sono inutili davanti a
se stessi, non perché sono pomposamente elevati a far
parte di insieme universale divengono utili. A meno che l’universale
non venga esso stesso divinizzato. Allora avremo una “religione
dell’umanità”, ben nota alla filosofia
da qualche secolo. Chiunque può abbracciare questa
religione, purché ammetta che di religione si tratta,
irrazionale, in quanto al modo di ogni religione divinizza
qualcosa. In questo caso l’uomo invece che dio. Se si
dice: “meglio divinizzare l’uomo piuttosto che
dio”, si deve anche dire perché. Se si risponde
“perché è più utile”, perché
“serve di più”, forse non ci si rende conto
di indicare all’uomo una prospettiva di servitù.
Una prospettiva non certo rosea, ma cupa, da incubo. Come
quella che, nella sua onestà intellettuale, indica
apertamente Locke. Che la servitù sia “servitù
al genere umano” non toglie nulla alla gravità
del fatto che si concepisca l’esistenza come servitù.
Se posso esprimere sommariamente un’opinione riguardo
a questo problema, in poche parole riassumerò la mia
riflessione. Sono convinto che l’umanità abbia
costruito, per salvare la propria esistenza, la condizione
oppressiva di una servitù a se stessa. Mi pare che,
mentre la retroguardia dell’umanità deve ancora
arrivare alla meta della salvaguardia del proprio esistere,
e ci sono ancora enormi problemi di fame, di malattie, di
miseria, la parte avanzata stia già sperimentando “il
rovescio della medaglia”. Non credo che si debba aspettare
che siamo tutti allineati nella stessa condizione prima di
porci il problema, dopo esserci liberati della servitù
alla natura, di liberarci dalla servitù a noi stessi.
Anche perché credo che soltanto cominciando a risolvere
il problema che sta davanti al secondo punto di vista si possa
realmente risolvere, fino in fondo, quello che sta davanti
al primo.
Questo è ambito della ricerca filosofica, certamente,
volutamente “inutile”, perché rivolta alla
liberazione dell’uomo dalla subordinazione, che può
diventare schiavitù, della utilità, anche della
utilità a se stesso.
Non credo - è una mia convinzione che non pretendo
di dimostrare qui - che riunendo tutti i pezzi della realtà
secondo il criterio della utilità il “puzzle”
della vita riesca del tutto. Certo, fino ad un certo punto
funziona, secondo me “fino alla metà” del
puzzle. Ma appena dopo la metà, il “mezzo ordine”
creato ogni pezzo aggiunto secondo il criterio dell’utile
ritorna come un boomerang distruttivo. I pezzi aggiunti sortiscono
l’effetto di disordinare anche la metà che si
credeva già ordinata in modo definitivo. Sarebbe bene
che chi lavora entro la prima metà cominciasse a coordinarsi
con quelli che lavorano, cercando altri criteri, nella seconda.
|
Torna
su
|
Il
teatro di Peter Gill
di Gian Maria Cervo
Ci sono
certi drammaturghi inglesi che quando li incontri ti danno
l'impressione di essere spettri provenienti dagli anni ottanta.
Ti parlano di una società britannica che non esiste
quasi più, di maniere che appartengono alla storia.
Peter Gill, no. A sessantasei anni, al culmine di una carriera
spesa a fondare e a lavorare per alcune delle maggiori istituzioni
a sostegno della nuova drammaturgia, coglie ancora perfettamente
le evoluzioni della cultura globale ed è capace di
una scrittura profondamente proporzionale all'epoca che stiamo
vivendo.
Forse è perchè non ha mai perso interesse nei
giovani e nella loro cultura, forse perchè proprio
negli anni ottanta, il decennio in cui molti suoi coetanei
hanno raggiunto i picchi del loro successo, le opere di Peter
hanno conosciuto il periodo di minore fama e apprezzamento.
C'è chi crede che gli scritti di Gill non interessassero
all'epoca dura del thatcherismo perchè c'è una
tenerezza che li pervade. Peter Gill è un eccellente
ascoltatore, un antropologo. Il suo stile è stato definito
"naturalismo studiato". Peter è capace di
riprodurre con straordinaria maestria la vita di moderne tribù.
Pezzi di quartieri, strade che, come in "Cardiff East"
costituiscono dei microuniversi. |
|
L'innato senso del ritmo di questo originale autore taglia
le noie e i grigiori dalle conversazioni da vicinato, da camere
da letto, da giardinetto, fa coesistere più situazioni
nello stesso spazio scenico, mette insieme significati letterali
e metaforici, annulla la distinzione tra interno ed esterno,
tra fuori e dentro.
Per usare le parole del regista Dominic Drumgoole "La
comune percezione dell'opera di Gill è che essa sia
fondamentalmente naturalistica. E' sbagliato. L'autore usa
una pittura naturalistica solo in un primo momento, per spanderla
poi per il teatro con una serie di stravaganti pennellate
alla Jackson Pollock". Nel gioco di Gill i personaggi
sembrano ignorare deliberatamente la presenza del pubblico.
Fanno riferimenti a figure che non compariranno mai in scena
etichettandole semplicemente con un "lei", un "lui",
un "loro"; il pubblico capisce progressivamente
l'importanza di queste figure.
Il linguaggio è caratterizzato da un colloquialismo
estremo, da battute i cui significati si chiariscono con lo
scorrere delle scene. "Non sono venuta per niente"
dice un personaggio femminile di "Cardiff East"
al suo vicino di casa. "Che?" risponde lui. "Non
sono venuta per una tazzina di zucchero o qualcosa" replica
ancora lei. E noi ridiamo con lui perchè in quelle
battute sono racchiusi un ambiente e uno stato d'animo.
I dialoghi di Gill sono strutturati in maniera poliziesca.
Per questo catturano il pubblico. Vediamo coesistere la leggerezza
di "Eastenders" con la forza e la dimensione comunitaria
e rituale di una tragedia greca.
La mia preoccupazione, nel lavoro di traduzione compiuto su
"Cardiff East", "Over Gardens Out" e "In
the Blue", è stata fin dall'inizio quella di restituire
non solo la capacità di Gill di descrivere gli ambienti
(non a caso Peter mi ha parlato, in una nostra conversazione,
con grande ammirazione del teatro di Goldoni) ma anche l'unicità
degli ambienti descritti. Cardiff è una città
con caratteristiche precise. E' una città portuale.
Ma non può essere, per ragioni diverse, nè Napoli,
nè Genova, nè Piombino. Tradurre "Cardiff
East" in un preciso dialetto italiano sarebbe stata una
scelta che avrebbe potuto portare a un sostanziale fraintendimento
del teatro di Gill. Perchè Peter Gill studia luoghi
e comunità, e nei suoi studi adora la precisione, l'attenzione;
detesta quando si vuole far passare per carattere universale
il carattere generico di un testo- e questo nel mercato culturale
oggi succede fin troppo spesso- così come detesta il
localismo superficiale, populista e folkloristico di certo
teatro pseudopolitico.
E' uno scrittore complesso, che da un lato descrive la working
class della sua terra d'origine come se fosse l'unica cosa
che possa descrivere e dall'altro si dimostra curiosissimo
per gli impulsi culturali che si manifestano oggi nelle varie
parti del mondo e per un confronto con le drammaturgie di
tutte le epoche e le aree geografiche (non a caso è
stato il fondatore del National Theatre Studio che, prima
del cambio di linee programmatiche che l'ha interessato nell'ultimo
anno, è stato la più importante struttura informativa-
quasi un'agenzia di intelligence- sulla nuova drammaturgia
e sul teatro di ricerca a livello internazionale).
La soluzione migliore per la versione italiana di "Cardiff
East" , opera che si presenta come riflessione sul concetto
di origine e si interroga sui valori familiari, sulla condizione
proletaria, sulla storia del Galles e sulla condizione di
essere considerato uno straniero in patria, è sembrata
quella di adottare una lingua che desse l'impressione di un
dialetto pur non essendolo, che fosse capace di disegnare
senza ambiguità le storie e le origini dei suoi personaggi;
ne è venuto fuori un italiano con suggestioni dialettali
(più che altro del Centroitalia) che curiosamente mi
ha permesso a tratti di mantenere intatti alcuni giochi linguistici
del testo originale.
Per "Over Gardens Out", opera di drammaturgia impressionista
ricca di suggestioni visive, che descrive la delicata relazione
tra due ragazzini bloccati nell'espressione dei loro sentimenti
dai loro background, il colloquialismo nella lingua italiana
si è attenuato (quest'opera del resto è stata
scritta nel 1968 mentre "Cardiff East" è
del 1997) mentre per "In the Blue", testo musicale
sulle infinite possibilità nelle relazioni amorose,
la lingua si è fatta più surreale, dovendo descrivere
-fatto piuttosto eccezionale nella drammaturgia di Gill- una
situazione, prima che un ambiente, ricca di non detti, di
sottintesi, di doppi sensi, in cui i vissuti più o
meno traumatici dei due protagonisti costituiscono l'ostacolo
per un rilassamento nel loro rapporto.
Nel lavoro compiuto mi sono state straordinariamente utili
le conversazioni con Peter Gill e le lunghe riflessioni con
Tim Stark e Carolina Migli, oltre al sostegno dell'intera
compagnia di attori coinvolti nel progetto. Il mio ringraziamento
va a tutti loro per i preziosi contributi dati alla realizzazione
della produzione e del mio lavoro sull'opera di Gill.
|
Torna
su
|
| Le
rune, tra misteri e fandonie
di Lorenzo Gallo
L’origine
delle rune
La scrittura runica, l’alfabeto autoctono della tradizione
germanica, attestato -con più o meno certezza - presso
tutte le maggiori popolazioni antiche di lingua e cultura
germanica, ebbe un ruolo fondamentale nella cultura precristiana:
in una società prevalentemente analfabeta, la scrittura
assume necessariamente il valore di codice segreto attraverso
il quale coloro che sanno decifrarla comunicano tra di loro,
e a cui il resto della società, in soggezione nei confronti
di tale minoranza qualificata, attribuisce poteri soprannaturali,
e dunque anche un valore magico. Per questo il valore originario
della radice protogermanica run- sembra essere quello di “sussurrare;
esprimersi confidenzialmente o in segreto”. In diverse
lingue germaniche antiche esistono parole derivate da questa
radice che significano “consiglio” o “decisione
segreta”; per esempio in gotico, una parola runa traduce
il greco mysterion “segreto, mistero da iniziati”.
Il campo
semantico è chiaramente quello della trasmissione esoterica
di un patrimonio di conoscenze proprio di una classe tendenzialmente
chiusa, anche se non di un vero e proprio clero, di cui non
possiamo ricostruire l’esistenza in base alle testimonianze
storico-letterarie. Il legame tra questo termine e la magia,
almeno nella tradizione nordica, è testimoniato anche
dal prestito della parola germanica nella parola runo in finlandese,
dove indica un canto composto in metro allitterativo, che può
essere poema eroico o cosmogonico, oppure anche un incantesimo.
Anche oggi del resto in cui si tende a distinguere tra la valenza
funzionale della lingua come trasmissione di pensiero e le sue
suggestioni culturali legate alla storia di un popolo o al mito,
le rune incuriosiscono e affascinano proprio perché sembrano
celare i segreti e le brume del nord, evocano folletti e valkirie,
boschi incantati e spade insanguinate.
A volte perciò le rune vengono utilizzate proprio per
trasmettere un messaggio a pochi “iniziati”, cioè
per sottendere che si parla di qualcosa di esoterico, riservato
a pochi eletti. Se pensiamo all’informatica, il logo di
Bluetooth, il sistema di connessione wireless, deriva dal nome
del re vikingo Harald Bluetooth (ovverossia “Dente-azzurro”)
da cui prende il nome: infatti la sua icona è una “B”
runica.
Le Rune e il Web. Gli equivoci del nazifascismo
Invece, se malcapitatamente e distrattamente si digita la parola
inglese "runes" in Google, il motore di ricerca più
utilizzato attualmente nel mondo, si ottiene un gran numero
di risultati.
Si può subito notare che, a parte pochi siti di carattere
accademico, il grande interesse del pubblico dei non addetti
ai lavori è indirizzato principalmente in due ambiti:
in primo luogo, come ogni testimonianza di cultura germanica
precristiana, le rune sono molto amate dai movimenti di estrema
destra; inoltre, a partire da qualche notizia estrapolata da
fonti storiche e più o meno rimasticata, le rune sono
considerate un importante strumento magico, in particolare per
gli oroscopi.
Questi due atteggiamenti nei confronti delle rune non sono nuovi,
e sono intimamente connessi tra loro. Il legame delle rune alla
cultura politica della destra totalitaria risale alle radici
romantiche del nazismo, che ereditava dal Romanticismo (in particolare
tedesco) un grande interesse per il patrimonio germanico precristiano.
Il primo impulso in questo senso era stato dato soprattutto
in funzione anticristiana (il Cristianesimo come degenerazione
dello spirito), anche se poi il nazifascismo di fatto scelse
una via diversa, che potremmo definire "neoclericale",
riuscendo – tramite i Concordati ed un accorto lavoro
di avvicinamento culturale – a coinvolgere parte della
Chiesa nei suoi folli progetti.
Dall'interesse per la cultura germanica antica si passò
alla rivalutazione del Medio Evo, e quindi non stupiscono le
foto d'epoca che ritraggono folle di preti e suore che “in
perfetta buona fede” si esibiscono nel saluto romano.
Ciononostante.. il primo amore non si scorda mai, e il nazismo
conservò sempre un particolare amore per il periodo precristiano,
in cui i Germani erano ritratti, secondo l'ideale tratteggiato
nella Germania di Tacito, come un popolo forte e virtuoso, non
toccato dalla corruzione della Roma imperiale.
Questa particolare predilezione provocò durante il nazismo
un'imponente fioritura di studi sulle rune e sugli altri aspetti
della cultura precristiana, in particolare sul paganesimo germanico,
e di conseguenza l'attento studio della letteratura scandinava
antica, l'unica che conservava tracce non marginali di questa
cultura.
In tal modo, spesso gli autori nazifascisti finirono per attribuire
tout court alla cultura pangermanica ciò che più
tardi si rivelò come tipicamente scandinavo; per esempio,
appunto, il grande amore per le rune.
Com'è noto, i fascisti italiani furono purtroppo nient'altro
che “servi sciocchi” al servizio dei nazisti tedeschi;
se qualche indipendenza del fascismo dal nazismo vi fu, essa
fu distrutta con la nascita della Repubblica Sociale cui, com’è
noto, si rifaceva il vecchio MSI: i fascisti della RSI aderirono
entusiasticamente alle tesi naziste, ripetendole “a pappagallo”
anche laddove queste contemplavano la superiorità della
"razza" germanica sulle altre ("italica"
compresa, qualunque cosa volesse dire): ancora oggi i giovani
neofascisti delle borgate inneggiano dunque, usando le rune,
ad una loro conclamata inferiorità nei confronti dei
Tedeschi (e a volte risulta davvero difficile biasimarli!).
Naturalmente, tra gli studiosi nazisti c'erano filologi, archeologi
e storici profondamente competenti, anche se accecati dall'ideologia:
e questo permise al Nazismo di elaborare una mitologia germanica
posticcia, aggiungendo quello che era scomparso e falsificando
con cura e astuzia, sì che ancora oggi lo studioso ha
difficoltà a distinguere i falsi archeologici e filologici
prodotti all'epoca.
Le rune e l’oroscopo: distinguere il falso dal
vero
La cultura nazista per prima tentò di sistematizzare
una teoria delle rune come scrittura magica; ancora oggi, nessuno
nega che una cultura prevalentemente analfabeta come quella
germanica attribuisse un valore particolare al segno scritto,
ma l'uso delle rune, noto e comprovato per la magia nordica,
difficilmente può essere attribuito tout court all'ambito
germanico comune. Se infatti il Medio Evo ci ha tramandato numerosi
manufatti nordici: bacchette di legno, lamine di metallo e bastoncini
d’osso incisi con misteriosi incantesimi runici, simili
oggetti sono pressoché inesistenti sul Continente: sono
pochissimi, di incerta interpretazione e spesso sospetti agli
occhi degli accademici, consci che spesso il dilettante (e a
volte persino lo specialista) trova quel che vuole trovare.
In questo caso, ben poco sappiamo, e spesso la comparazione
tra culture germaniche permette di individuare non solo alcune
remote affinità, ma anche numerose profonde discrepanze.
Per esempio, è noto che la testimonianza più attendibile
sui nomi con cui ciascuna runa veniva designata è offerta
da alcuni poemi detti "runici", che descrivono in
versi le caratteristiche di ogni runa e spesso il suo nome;
ebbene, proprio questi componimenti mostrano che tra l'ambito
anglosassone e quello nordico le differenze possono essere profonde
ed estese, mentre i punti di contatto sono rari, limitati quasi
solo ai nomi delle lettere, ma a volte neanche a quelli.
Per quanto riguarda la possibilità di fare magia con
le rune, e in particolare di prevedere il futuro, tali pretese
si basano su supposti fondamenti non solo ascientifici, ma anche
astorici: infatti da una parte sappiamo che nell’antico
alfabeto runico solo quattro-cinque segni sembrano decisamente
negativi (come ci dicono i loro nomi: Thursaz "gigante
cattivo" - o Thorna "spina" -, Hagalaz "grandine",
Naudhiz "schiavitù", Isa "ghiaccio"
e forse Kaunaz "torcia, fuoco” poi anche “ascesso").
Dunque i veggenti presso i germani dovevano essere dei veri
ottimisti!
Inoltre, occorre notare che simili pretese si scontrano con
difficoltà nel ricostruire lo stesso nome dei segni,
che in alcuni casi (in particolare per “p” ed “e
chiusa”) si rivelano insormontabili allo stato attuale
delle conoscenze. In assenza di un nome ricostruibile per questi
segni, come si può azzardare una ricostruzione di magia
runica? Non si può, infatti: chiunque lo fa vi propina
una “bufala” non solo perché si spaccia per
mago-cartomante-zingara-che-vede-e-stravede, ma anche perché
basa la sua magia su informazioni sballate e inattendibili,
sconfessate da qualunque storico e filologo dotato di un minimo
di serietà professionale.
Per ulteriori informazioni su rune e magia, potete consultare
l’indirizzo www.filologiagermanica.info
|
Torna
su
|
Chi
legge lo sa bene…
di Antonino Pingue
Quando
si scrive un racconto è buona regola ambientarlo in
posti esotici e avventurosi. Salgari ambientava le sue saghe
in Malesia, Jules Verne al centro della terra, sotto il mare
e perfino sulla Luna.
Gli organizzatori
del concorso letterario “Io Feltrinelli”, indetto
dalla nota casa editrice, per i cinquanta anni d’attività,
sembrano conoscere bene questa regola. Infatti i racconti,
che tutti i clienti delle librerie Feltrinelli sono stati
invitati a scrivere (un massimo di 100 parole), e che ha visto
la premiazione lo scorso 15 aprile, dopo una grande partecipazione
(rimandiamo al sito della Feltrinelli per i dettagli sul concorso
che vedrà una seconda edizione) poneva come tema comune
che tutti i racconti fossero ambientati in assoluto in uno
dei posti più misteriosi e “pericolosi”
che le nostre comode città conoscono: le librerie.
Chi legge lo sa bene…
Frequentare una libreria non è cosa facile né
priva di rischi. Strani esseri la popolano (e fra questi ci
mettiamo noi stessi).
Ad esempio in una libreria c’è sempre il signore
che si sposta da un bancone all’altro (non va mai ad
uno scaffale ma il perché lo spiegheremo dopo), e ogni
tanto prende un libro e lo sfoglia.
Quello, potremmo definirlo l'Impollinatore.
La caratteristica principale di un Impollinatore da libreria
è la molteplicità dei suoi pensieri. Non ha
la più pallida idea di cosa comprare, capace che alla
fine non comprerà nulla. Tocca tutto però. Quindi
curiosa, cerca, forse si ispira. Disegna percorsi a zigzag
o a spirale. Generalmente un Impollinatore è onnivoro:
spazia dalla narrativa classica ai romanzi di fantascienza,
dal fumetto al bestiario medioevale, dal catalogo filatelico
all’annuale edizione dell’oroscopo. Quando afferra
un libro, lo sfoglia e legge qualche riga. E’ un avido
consumatore di quarte di copertina.
L’unico spauracchio di un Impollinatore sono i libri
incellophanati. Se può li snobba. Li rimette giù
stizzito. Ma a volte capita che un libro incellophanato lo
freghi e lo attiri nelle sue spire. Non si sa cosa, il disegno
sulla copertina, il peso (non l’odore che non passa),
ma deve assolutamente comprarlo.
Sta di fatto che l’Impollinatore, che è un tattile,
non può comprare un libro che non ha prima sfogliato.
E’ contro la sua natura. Allora i casi sono due: o con
fare sovversivo rompe l’odiato involucro plastico e
sazia illegalmente la sua curiosità; oppure si risolve
a comprarlo a scatola chiusa. Con aria di chi gli scappa la
pipì, si precipita alla cassa, paga e lo scarta. Correzione:
lo sventra. Imprecando perché, di solito, è
il libro sbagliato.
Un altro tipico personaggio che si incontra in libreria è
una signorotta ferma in mezzo a tutto, che segue con lo sguardo
un giovane e piacente commesso intento a mettere a posto libri.
Non è innamorata, e non stiamo assistendo ad una passionaccia
intergenerazionale.
Quella è una Domandante.
Ora la Domandante da libreria, come mette piede in una libreria
perde la capacità motoria, quasi tutta l’intelligenza,
e del tutto l’iniziativa.
La Domandante non sa cercarsi un libro da sola. Anzi i libri,
che le guizzano da per tutto, a non più di 50 centimetri,
e dai quattro punti cardinali, sono per lei oltremodo invisibili
e misteriosi.
La Domandante la puoi trovare all’ombra di dodici altissime
colonne formate dall’ultimo indimenticabile best seller
con gigantografia beota dell’autore, che aspetta il
commesso per chiedere dove può trovare proprio quel
libro. Magari nel frattempo nota un granello di polvere sul
tacco della sua scarpa destra o un’impercettibile smagliatura
alle calze. Comunque, la Domandante aspetta; colma di sovrumana
pazienza aspetta, cieca, in mezzo al mondo.
Infine segnaliamo il personaggio più divertente che
possiamo incontrare in libreria: la Regalomane.
Una Regalomane da libreria non vuole mai un libro per sé.
Che sia ben chiaro: si trova là solo perché
ha avuto l’idea di regalarne uno. E’ entusiasta
per antonomasia. Un po’ mecenatica, un po’ tazzina
di the o pasticcino, adora tutto. Ma è una attenta
acquirente e non bisogna lasciarsi ingannare dalla sua futilità.
Ama mercanteggiare, ha le sue opinioni, e vuole essere affiancata
da un suo pari. Una Regalomane entra in libreria come fosse
dal gioielliere. Pretende. Pretende di essere seguita passo
passo, pretende di essere consigliata e intrattenuta con perifrasi
amene quanto dettagliatissime, pretende di essere considerata
una cliente, mai un’occasionale avventrice. Si sceglie
il commesso più preparato (e anche quello più
avvenente), conosce tutti per nome e saluta. Riferisce i risultati
degli acquisti precedenti, e chiede sempre lo sconto.
Nota bene: la Regalomane è solo di sesso femminile.
E’ un animale dalla riproduzione agamica.
Se gli animali da libreria sono strani, ancora di più
lo sono i libri che li attirano.
Potremmo dividere lo scibile cartaceo in due fondamentali
branche: i libri di pancia, ovvero quelli poggiati sui banconi
in modo da mostrare la copertina, e i libri di culo, che sono
invece riposti lungo gli scaffali che ricoprono le pareti.
Libri di pancia e libri di culo costituiscono una discriminante
fondamentale nella scelta di una libreria. Ci sono librerie
dove abbondano i primi e librerie dove addirittura ci sono
solo i secondi (con conseguenti variazioni della fauna locale).
Trovo che i libri di pancia sono più aperti e democratici,
pronti a venirsene via con te; ma nulla vieta che un libro
di pancia successivamente diventi un libro di culo.
I libri di pancia a loro volta si dividono in capofila e retroguardie.
I capofila sono i primi della colonna, gli scafati. Se hanno
la copertina patinata, non è raro trovarci le impronte
di un Impollinatore che li ha appena aperti. Possono avere
anche qualche strappo o una piega. La retroguardia è
invece intonsa e nuovissima. Bellissima e vergine.
Scegliere se prendere il capofila o la retroguardia, è
tutta una questione d’intuito… Una regola precisa
non si può stabilire. In generale io preferisco prendere
retroguardie per i libri molto grossi, che ti seguiranno a
lungo, e capofila per quelli più piccoli.
I libri di culo sono tutta un'altra storia. Se i primi sono
il proletariato e il sottoproletariato cartaceo, i secondi
sono la intellighenzia. Rifiutano di farsi scegliere casualmente;
piuttosto devi stanarli. Per questo lungo uno scaffale non
troverai mai un Impollinatore né tanto meno una Domandante.
I libri di culo impongono la fatica di cercarli. Se i libri
di pancia cambiano di volta in volta luogo (ballano durante
la notte quando la libreria è chiusa), sanno sempre
come finirti sotto il naso. I libri di culo non cambiano posizione,
mai, ma se ti avvicini ti sputano in un occhio!
I libri di culo, sono di solito più cari dei libri
di pancia.
Con i libri di culo, può capitarti, però, qualcosa
di eccezionale. Puoi imbatterti nel grande vecchio. Ora un
libro vecchio non è mai un libro scritto tanto tempo
fa ma un libro stampato tanto tempo fa… e dimenticato.
Quasi sempre è di un autore sconosciuto e la storia
ricorda gli sceneggiati televisivi che vedeva tua nonna. Ha
le pagine ingiallite, i colori tutti sbagliati. Dritto da
un’eternità si è leggermente allunato.
I caratteri sono desueti. I titoli dei capitoli preistorici.
Se lo compri ti è garantito un viaggio nel tempo; ti
staccherai da tutto ciò che è live, avrai cento
anni per le cento pagine che lo compongono (i grandi vecchi
sono spesso corti). Sai, perché lo sai benissimo, che
l’autore è tornato al mercato a vendere pomodori.
Ha fatto le valige e ha rinunciato. Così a comprare
il suo libro ti pare di esplorare senza autorizzazione una
vecchia casa di campagna dove un tempo correvano bambini spettinati,
mancava la penicillina e il pane si faceva ancora con le mani
sporche di terra.
Potremmo proseguire a lungo, ma la finiamo qui.
Concludiamo dicendo che a conti fatti un libro, questo oggetto
strano, e antitecnologico che ossessiona alcuni di noi, si
comincia a leggere - come dice Calvino nel primo capitolo
di “Se una notte d’inverno un viaggiatore”
- molto prima di averlo comprato e letto.
Leggere dunque, come mi è gia capitato di dire, è
a tutti gli effetti una malattia, che ci espone a infiniti
rischi.
Chi entra in libreria, non solo si espone ad ogni possibile
avventura (e ben venga di scriverne) ma compie quasi un gesto
rivoluzionario, sicuramente anti-convenzionale. Come anti-convenzionale
e rivoluzionario era il fondatore della Feltrinelli, Giangiacomo
Feltrinelli (1926-1972) che fondò la casa editrice
nel 1955 in poche stanze e con pochissimo personale. Figlio
di industriali, entrò nel PCI giovanissimo, ma ne uscì
nel ’57. Nel ’57 pubblicò “il Dottor
Zivago” di Pasternak; l’anno dopo fu la volta
del “Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa, rifiutato
poco prima da Einaudi. Vicino alle rivoluzioni terzomondiste
e, in letteratura, alle avanguardie, Giangiacomo diede presto
alla sua casa editrice un profilo inconfondibile. L’editore
morì nel ’72 a soli 46 anni mentre tentava di
far saltare un traliccio a Segrate.
|
Torna
su
|
ADDIO
JULCA
di Adriano Aldomoreschi
Storia
e Memoria, Vita e Testimonianza, sono temi oggi vivi più
che mai, anche per i recenti eventi luttuosi che vedono Roma
centro del Mondo.Esistono dunque persone testimoni più
di altre della Storia, comunque la si pensi. Ed esistono anche
persone che vivono all’ombra della Storia e dei suoi
protagonisti. E’ perciò che la redazione di WebTimeC,
pubblica oggi, con particolare piacere lo splendido brano
del nostro socio Adriano Aldomoreschi, (brano già pubblicato
per Rinascita nel 1980), sulla morte di “Julca”,
la moglie di Gramsci, che Aldomoreschi conobbe personalmente
quando era inviato per il Corriere della Sera a Mosca. Un
brano che nella sua semplice liricità, nella sua lucida
e limpida prosa, mostra e narra più di ciò che
dice, diventando una testimonianza generazionale e storica
al di là del tempo e delle risonanze mediatiche, oltre
che una esemplare lezione di scrittura.
|
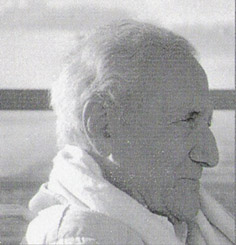
Adriano
Aldomoreschi
Adriano
Aldomoreschi è un giornalista che ha lavorato a L'Unità
dal '47 al '65 con sede di lavoro a Genova, Milano e Roma;
negli anni '70 e '80 - per circa otto anni - è stato
poi corrispondente di Paese Sera a Mosca.
|
Mosca, 4 luglio 1980 – Quando arrivai
a Mosca, più di sette anni fa, tra i tanti desideri
nutrivo quello di conoscere Giulia Schucht, la «Julca»
delle lettere di Gramsci. Vi sono scritti, vi sono immagini
che lasciano segni profondi che non si cancellano più
e concorrono a determinare decisive scelte di vita. Le lettere
di Gramsci dal carcere, le fotografie di Giulia con i suoi
due bambini, Delio e Giuliano, sono tra questi scritti e queste
immagini. Esse hanno condizionato le scelte e i sentimenti
di tanti comunisti e antifascisti della mia generazione.
Per quel che mi concerne, ho sempre creduto
che questo condizionamento sia stato, nel mio caso, più
intenso o diverso, proprio a causa dell’immagine di
Giulia. Forse perché a cinque anni perdetti mia madre
l’immagine di Giulia suscitava in me un sentimento di
acuta nostalgia per una donna come lei. E invidiavo l’amore
di Gramsci, la profondità dei suoi sentimenti, il suo
stesso dolore. In realtà, era la dolcissima impronta
materna del volto di «Julca» la mia vera suggestione.
Guardando la sua fotografia, più che identificarmi
con Antonio Gramsci, era in Delio e Giuliano che inconsciamente
volevo riconoscermi.
Mi proponevo di visitare Giulia Schucht,
ma il primo impatto con Mosca non fu positivo. Vissi per molto
tempo in preda a profondi scoraggiamenti e a forti rimpianti
per l’Italia. Passarono gli anni. Avevo sempre presente
il mio proposito di conoscere «Julca», ma senza
più lo slancio dei miei primi mesi moscoviti. Chiedevo
dove si trovasse Giulia Schucht e se, come su tante altre
cose, ricevevo generiche risposte («è in un sanatorio
fuori Mosca», mi si diceva, con un’aria di mistero,
come se si alludesse ad un «luogo strategico»,
interdetto agli stranieri, cui solo pochi potevano accedere),
anziché insistere, me ne facevo un alibi.
Altri alibi erano la mia timidezza, il timore
di essere indiscreto. Sapevo della malattia di Giulia. Mi
avevano raccontato che, prima di essere ricoverata nella Casa
di riposo dei vecchi bolscevichi (dove si trovava ancora due
giorni prima di morire), nell’abitazione dove Giulia
viveva con la sorella Eugenia e con Delio e Giuliano, vi era
una stanza non abitata, «la stanza di Antonio»,
che era come un santuario: lì c’era il suo calco,
c’erano i suoi libri, le sue lettere, i cimeli…
Non volevo creare turbamento o, forse, non volevo andare incontro
ad una delusione. Temevo, egoisticamente, che Giulia Schucht
fosse solo un simulacro della «Julca» dei miei
ricordi giovanili.
Poi conobbi Giuliano Gramsci, ci legammo
di viva amicizia. E puntualmente, ad ogni nostro incontro,
Giuliano mi prometteva che, una domenica o l’altra,
mi avrebbe portato «dalla mia mamma», come soleva
dire con tenerezza. Ma quella domenica non veniva mai. Ed
io sentivo ormai la omissione come una colpa: verso me medesimo,
verso Giulia Schucht, verso il mio stesso dovere professionale
di giornalista.
Finalmente, il 12 maggio dell’anno
scorso, Giuliano mi conduce da «Julca». Proprio
in quei giorni, per iniziativa dell’Istituto del movimento
operaio internazionale, nell’edificio adiacente al Cremino,
dove negli anni venti erano gli uffici della Terza Internazionale
e dove Gramsci aveva lavorato, era stata inaugurata una lapide
a lui dedicata. Dall’Italia erano venuti, oltre a Franco
Ferri, la nipote di Gramsci, Mimma Paulesu, ed Elsa Fubini.
Enrico Berlinguer aveva consegnato alle due compagne una lettera
per Giulia e una medaglia d’oro in cui erano raffigurati
i profili di Gramsci e Togliatti.
Con Giuliano, Mimma ed Elsa prendemmo posto
su una «Volga» nera e ci dirigemmo, da Mosca,
sulla strada di Minsk. Percorsi una trentina di chilometri
abbandoniamo la strada per Minsk e ci inoltriamo, a sinistra,
nel bosco di Peredelkiono, dove sono le «dacie»
di scrittori famosi. La Casa di riposo dei vecchi bolscevichi
sorge in alto, sulla sommità della collina, non lontano
da una vecchia chiesa settecentesca, tra sentieri di campagna
e tra orti. Poco lontano, sotto gli alberi, è la tomba
di Pasternak.
La primavera russa era già esplosa.
Gli alberi erano folti, si respirava un’aria profumata
di erbe e di fiori. Quando entrai nella piccola stanza e vidi
«Julca» rimasi stupito che la vecchiaia non avesse
intaccato la sua bellezza e che il fascino che emanava dalle
fotografie giovanili fosse così vivo e intatto nei
suoi sguardi, nel suo modo di parlare, nel moto delicato delle
sue mani. Quelle mani che sfiorando il profilo di Antonio
Gramsci, inciso sulla medaglia d’oro che le era stata
consegnata, le avevano richiamato alla mente ricordi dei quali
Giulia ci rese partecipi con parole dette come in un soffio:
«sento il suo sorriso». Parlava un italiano correttissimo
e voleva sapere di ognuno di noi mostrando una curiosità,
un interesse per tutto e per tutti. Allora sentii davvero
come una imperdonabile colpa l’aver tanto indugiato
ad incontrare Giulia Schucht.
*****
Giovedì 26 giugno 1980, dentro le
mura dell’antico monastero che porta il nome di Dimitri
Donskoj (il principe che sconfisse i Tartari) ho assistito
alla cerimonia che ha preceduto la cremazione di Giulia Schucht.
«Julca» era distesa nella bara rosso porporino
ed il suo bel viso (tante volte segnato dalle crisi di epilessia,
il «male sacro» di cui soffriva anche Dostoevskij)
era pacifico e quasi sorridente. Un fazzoletto a fiori da
contadina le avvolgeva il capo. Sul suo corpo, parenti ed
amici avevano deposto rose e garofani, e le sfioravano il
mento come un variopinto arazzo. L’edificio del crematorio
ha andamenti architettonici particolari che ricordano una
chiesa. La porta d’accesso è molto pesante, come
nei nostri templi. Sul fondo, dove da noi è l’altare,
c’è un grande organo a canne. Sotto quest’organo,
delimitato da una piccola balaustra di marmo, una forma di
letto su rulli metallici.
Vecchi bolscevichi, con grandi barbe e giacche
di lino bianco cechoviane su cui spiccano mostrine e medaglie,
sono intorno alla bara. Vicino a Delio e Giuliano, i rappresentanti
del Partito comunista italiano venuti a dare l’estremo
saluto a Giulia: Salvatore Caccipuoti, Elio Quercioli, Mimma
Paulesu. Ci sono anche molti corrispondenti italiani a Mosca.
La cerimonia comincia. L’organista intona una nota altissima,
e poi gli accordi dell’«Ave Maria» di Schubert
riempiono le volte di questa chiesa laica. Ascoltando l’organo
mi ritorna alla mente in termini assai vaghi, un pensiero
che, forse erroneamente, attribuisco a Gramsci. Il pensiero
è in sintesi questo: quando avremo risolto i grandi
problemi sociali, potremo dedicarci davvero a quelle questioni
che oggi consideriamo e sono metafisiche (molti problemi sociali
sono stati risolti nell’Urss, ma altri stentano ad essere
risolti, mi dico, forse proprio perché certe questioni
metafisiche si è voluto sbrigarle anzitempo).
Ora parlano gli amici e i compagni di Giulia
Schucht: il rappresentante dei vecchi bolscevichi, il dirigente
del partito del rione dove vivono i Gramsci (per il Pcus è
presente anche Enrico Smirnov della sezione italiana del Comitato
centrale), la figlia di Francesco Misiano, Lina, amica di
Giulia. Poi parla Elio Quercioli: un discorso lucido senza
ombra di retorica. Quercioli dice dell’amore nato tra
Antonio Gramsci e Giulia Schucht, inquadra le due figure negli
anni di lotta in cui si conobbero, rievoca le brevi gioie
e il lungo dolore di questa coppia. Conosco Quercioli da molti
anni. So la sua mite, lombarda ironia che lo difende dai groppi
della commozione. Eppure Elio si interrompe due volte durante
il suo discorso. La cerimonia è alla fine. Giuliano
e Delio danno un ultimo bacio alla loro madre. La bara è
portata a braccia sul letto metallico. Il cerimoniere preme
un bottone: la bara si avvia sottoterra. Tra poco la cremazione.
Dall’organo salgono ora le note dell’«Internazionale».
I parenti sono invitati a restare. Gli invitati sono pregati
di ritirarsi. Tra qualche giorno le ceneri di Giulia Schucht
saranno inumate nella tomba di un altro famoso monastero di
Mosca carico di storia: Novodevicij (monastero delle vergini).
Qui riposa anche il padre di «Julca» Apollo Schucht,
che fu amico di Lenin, il quale, durante l’esilio di
Svizzera cullò molte volte tra le sue braccia la piccola
Giulia figlia dell’amico. Come tutti i cimiteri, Novodevicij
testimonia di quel mondo «grande e terribile»
di cui Gramsci parlava nelle sue lettere a «Julca»,
e «grande e terribile» è stato il mondo
della vecchia Russia. E anche, purtroppo, della Russia nuova.
Estratto
da “Rinascita” n. 27 del 4 luglio 1980
|
Torna
su
|
L’hi
tech all’italiana: tanto fumo & niente arrosto
di Antonino Pingue
Italiani,
popolo di consumatori hi tech; giovani italici super informatizzati
che non fanno un passo senza computer, cellulare, palmare,
e non progettano una vacanza senza macchinetta digitale, arrendetevi:
in Giordania (per non parlare del resto d’Europa) sono
più “intelligenti” di voi! |
In
questi giorni sui maggiori quotidiani nazionali è apparsa
una notizia che tutti i giornali hanno commentato con generico
rammarico. Si tratta dell’ennesima graduatoria internazionale
che vede l’Italia sempre più perdente, fra i
Paesi più industrializzati, sul terreno delle tecnologie
per l’informazione e la comunicazione; in questo caso
anche con la Giordania, la Tunisia, il Sudafrica....
La lista, che indica il grado di utilizzo delle nuove tecnologie
nelle diverse nazioni (104 quelle prese in esame) è
stata compilata, nell’edizione 2004-2005 del Global
Information Technology Report, dal World Economic Forum: uno
degli organismi più accreditati del mondo in queste
cose, che si avvale della collaborazione della Banca Mondiale
e dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.
Insomma una cosuccia seria…
Rispetto alla scorsa edizione l’Italia è precipitata
dalla 28ma alla 45ma posizione.
Ma la vera sorpresa c’è se proviamo a capire
l’esatto significato di questa classifica.
Forse l’Italia ha meno tecnologia di altri paesi? Forse
che L’Islanda, (secondo posto assoluto dopo Singapore),
la Finlandia e la Danimarca (tutte a sorpresa davanti agli
U.S.A.), usano i computer, il cellulare, Internet, la posta
elettronica ecc. ecc. più di noi? Forse che in mezzo
ai fiordi e alle renne, Bill Gates fa molti più affari
che, poniamo, nel golfo di Sorrento?
No. Anzi, l’Italia rimane fra i primi consumatori di
tecnologia hi tech. Siamo, per esempio, al terzo posto assoluto
nel mondo per l’uso di cellulari (mentre Singapore non
va oltre il 15mo) al 9no per abbonati alla rete telefonica
fissa, e al 21mo per grado di diffusione di Internet.
Quello che questa classifica indica è che noi italiani
non siamo in grado di sfruttare le nuove tecnologie per migliorare
la qualità della vita, per modificare i metodi di istruzione
e potenziare la ricerca scientifica: siamo al 79mo posto per
“qualità delle istituzioni di ricerca scientifica”,
tanto per fare l’esempio più clamoroso.
Triste, tristissimo. Tutti ci colleghiamo ad internet (evviva!),
ma poi ci accontentiamo di scaricarci le nuove suonerie per
i cellulari, che a loro volta consumiamo a chili (siamo un
popolo di schede prepagate e di telericaricatori), per votare
a colpi di SMS il nuovo cantante di San Remo (ultima novità
della manifestazione canora), o poco più. Tutti, insomma,
super tecnologici e super frivoli nella vita quotidiana, pieni
di tanti giocattolini costosissimi, vero, ma poi tutti in
fila alla posta a pagare la bolletta o a mandare una raccomandata,
o in banca a fare un bonifico, o all’agenzia per prenotare
un volo aereo e alla stazione a comprare un biglietto, oppure
restiamo in ufficio - occupati in affari o decisioni importanti
- e... ci mandiamo la segretaria. Per non parlare del tele-lavoro,
vera nuova frontiera aperta dalle nuove tecnologie (e largamente
introdotta nelle altre nazioni), e al decentramento urbano,
altra possibilità che le nuove tecnologie ci consentirebbero,
alla formazione a distanza ecc. ecc.
Insomma teleinternauti italiani, mettiamoci in testa che l’hi
tech, non è una moda, non è uno status, non
è un modo per essere in, up o cool, è una seria
occasione di cambiare, di inventarsi, di migliorare e contribuire
a migliorare il nostro benessere. Noi, come WTC, non ci siamo
mai sentiti così lungimiranti e necessari, modestamente…
|
Torna
su
|
La
campagna romana de "I XXV"
di Caterina Pellitta
Questo
il titolo della mostra presente dal 10 marzo e fino al 24
aprile all´Accademia Nazionale di S. Luca. In essa sono
esposti un centinaio di pezzi tra dipinti, disegni, fotografie
e caricature creati dal gruppo di pittori detto "I XXV"
(nato nel 1904) per via del loro numero e per richiamarsi
al movimento de "I XX" (1883), gruppo di artisti
impressionisti belgi che non poco influenzarono la loro produzione.
Aggirandosi per le sette sale, corrispondenti ad altrettante
sezioni in cui si articola la mostra, si riscontrerà
immediatamente che il soggetto che accomuna ed appassiona
questa amena società di artisti è quello della
campagna romana, come appunto suggerisce il titolo della mostra.
Trovano, infatti, spazio sulle tele de "I XXV" enormi
campi di grano, immense distese di rossi papaveri, contadini
alle prese con le fatiche quotidiane, il tutto edulcorato
da un´aura di nostalgica immortalità di quei
luoghi a fronte di un´urbanizzazione sempre più
forte.
Dunque, la campagna romana secondo "I XXV", ma non
un´unitaria visione di un mondo, bensì l´evoluzione
e la differenziazione dello sguardo di un gruppo estremamente
eterogeneo che porta il visitatore dalla descrizione "verista"
(le prime tre sezioni) del paesaggio rurale, a quella "idealista"
(la quarta) che tende a preferire uno sguardo trasognato preferendo
tralasciare i tanti e gravi problemi della campagna - romana
e non solo - di quell´epoca, a quella ancora "simbolista"
(la quinta) fino a giungere all´espressione Liberty
e "divisionista" dei dipinti delle ultime stanze.
Colpisce in particolare la sesta sezione, quella dedicata
a D. Cambellotti (1876-1960), la cui modernità tematica
si coniuga ad un´enorme forza comunicativa: eloquente
della sua sensibilità verso la questione dell´Agro
Romano -Cambellotti aveva sposato la causa dell´antimodernismo
e dello sfruttamento della classe operaia- è in particolare
l´opera La falsa civiltà in cui un operaio
dal volto di teschio selcia la campagna trasformandola in
strada lastricata di sampietrini. Tra le altre sue opere qui
esposte, sempre dal sapore simbolico, vagamente espressionista
ed apocalittico, troviamo anche sculture, giocattoli, vasi
e terrecotte.
L´Accademia di S. Luca accoglie in questi giorni anche
opere di suoi ex allievi, come Arturo Noci che qui è
presente con due oli su tela: Giardino-Villa Doria
e Lago di Nemi; entrambi testimoni del suo Divisionismo
e della sua capacità di rendere il soggetto con espressività
e non in maniera meramente descrittiva. Colpisce, infatti,
l´uso dei colori caldi e la resa della luce poiché...
"dipinge a strisciate di colore, blocca la luce nelle
sue brume, ricerca (anche inconsciamente) le linee di energia"
(Fagiolo dell´Arco, 1996, p. 24). Attraversando le sale
della mostra rimane, infatti, viva l´impressione di
colori e di luci, sensazioni che proveremmo percorrendo la
campagna al crepuscolo (come nei quadri di C. Ferrari) o al
mattino (Petiti e Battaglia) o in giornate piovose (Coleman)
o, ancora, ammirando un campo di papaveri (Anivitti e Grassi).
Nella mostra sono presenti anche alcuni "cammei",
opere di autori non appartenenti a "I XXV", ma aventi
contatti col gruppo: La contadina dei "Marcelli"
di G. Balla (1871-1958), Paesaggio-Risveglio primaverile
di G. Costa e lo straordinario dipinto simbolista di E. Serra
y Auque, Mattinata autunnale, che rivela efficacemente
con le acque di una palude e con l´edera appassita che
ricopre le statue il sentimento di questo autore e dei suoi
"XXV" amici nei confronti della tanto amata campagna
romana che perisce nell´era dell’urbanismo.
|
Torna
su
|
Di
razza ebraica di Renzo Modiano
Atomi di memoria in una storia universale…
Quale
il senso di un nuovo libro sulla Shoah? Non c’è
il rischio che sia, dopo tante opere, letterarie e cinematografiche
(tanto per citare solo due delle arti che hanno cercato di
rappresentarla o di documentarla) un tentativo inutile?
La Shoah
come semplice materia di scrittura ci dà la misura
di quanto sia difficile per un autore contemporaneo commuovere
e comunicare avvenimenti così inauditi e al tempo stesso
personali e vivi, come ad esempio la retata al ghetto di Roma
dell’ottobre 1943. La Shoah come semplice materia di
scrittura ci dà la misura della pericolosità
di drammatizzare - nel senso di mettere in un tessuto narrativo
- un dramma senza apparire speculativi o peggio, banali. Perché
il male, specie quando è assoluto, è spesso
iconograficamente banale… e il “brutto”,
specie quando è ovunque è difficile da raccontare.
Il segreto
di “Di Razza Ebraica”, e il motivo per cui Renzo
Modiano vince la scommessa, se così si può dire,
sta allora nella scelta di recuperare la storia attraverso
la propria memoria, circoscritta, personale, soggettiva: un
atomo di storia, come la definisce lui stesso, ma sullo sfondo
della Storia universale. Ed è in questo recupero che
la vicenda familiare raccontata dall’autore commuove
e commuove profondamente.
“Di
Razza Ebraica” racconta delle sessioni scolastiche scomode
riservate agli ebrei, ricordando la soddisfazione dei ragazzi
che si “godevano” il sabato fascista... racconta
delle schegge di bomba ancora calde che davano ai bambini
l’illusione di vivere l’orrore della guerra come
un gioco con l’ebbrezza di piccole imprudenze... racconta
dell’arrivo al campo della sua compagna di banco Rachel...
quando dividono i prigionieri... “Mamma va a destra,
io vado a destra. Che fortuna… Noi faremo la doccia.
Dio fa che sia calda”. |
 [dal
retro di copertina]
[dal
retro di copertina] “La
vita mi ha mostrato i denti, all’inizio.
Tra le prime immagini del mio album di ricordi c’è
l’espulsione da un luogo di villeggiatura al mare,
il sequestro della radio, che era molto di più di quanto
oggi sia un apparecchio TV, l’allontanamento dalla casa
di un compagno di gioco perché ero ebreo, la pagella
di scuola dell’anno scolastico ’42-’43 con
la scritta in rosso “di razza ebraica”, il peso
di sentirmi diverso e disprezzato........”
|
|
E dell’uccisione dei maiali, di cui si ricorderà
per sempre... la raccolta cruenta del sangue prezioso, l’inseguimento
del maiale più ribelle e della rabbia di quelli che
il bimbo vede come carnefici, perché del sangue non
se ne doveva sprecare nemmeno una goccia... la divisione della
spianata di polenta come insegnamento del fondamento di una
società civile in cui ”il diritto dell’uno
ha limite in quello del vicino e esiste sempre qualcuno con
cui si deve dividere quello che c’è”.
“Di Razza Ebraica” mostra tante cose. Mostra che
l’essenza più nobile dell’uomo è
l’“umanità”, il segno che distingue
uomo da uomo. Mostra, verrebbe da dire “ci ricorda”,
che siamo il risultato delle nostre esperienze e che se esistono
esperienze obiettivamente negative perché creano sofferenza
o finiscono con la morte fisica, tuttavia ci distraggono dalle
sovrastrutture che costellano la nostra vita quotidiana, obbligandoci
a confrontarci con i grandi temi epici della vita, la morte,
il potere dell’uomo sull’uomo, la gratuità
e la banalità del male, sui quali soprattutto noi laici
non riflettiamo mai abbastanza.
E’ questo, credo, il senso ultimo, e qualificante di
questo libro.
Renzo
Modiano, nato a Roma, vive a Milano da molti anni.
Giornalista e dirigente, ha lavorato alla Olivetti nel campo
delle Risorse Umane ed è stato direttore del Personale
del gruppo Mondadori. Attualmente svolge attività di
consulenza e di docenza.
Ha pubblicato: La Risorsa Umana, Sperling & Kupfer, 1993
e i romanzi: Ipotesi di giustizia nel Principato di A, Mondadori,
1991; L’inganno degli Dei, Marietti 1999; La disattenzione,
Marietti 2002. Quest’ultimo libro, che ha già
vinto nel 1996, all’opera inedita, il premio Dino del
Bo,
è stato finalista al premio "Ultima frontiera"
Citta di Volterra nel 2004.
|
Torna
su
|
Vecchiume
in digitale:
“La foresta dei pugnali volanti”, l’ultimo
film di Zhang Yimou:
di Paola Sereni
|
| Vi
ricordate il Zhang Yimou di “Lanterne Rosse”?
Dimenticatevi di rivedere un film dolente, rigoroso, sostenuto
come quello. La foresta... è un western sentimentale,
niente di più. La trama -nel più abusato filone
erotico sentimentale dei vecchi film di cappa e spada (genere
che in oriente si definisce wuxia)- è schematica, i
dialoghi stereotipati -mai universali- ridotti a pretesto
per un estetismo estenuato, fotografia impeccabile ma gelida...
natura, carne e sangue ridotte a macchie di colore, la musica
-che si pretende autoctona- in realtà strizza l’occhio
all’Occidente nella maniera più smaccata, tra
il sommo maestro della musica da film occidentale Ennio Moricone
e i Mattia Bazar con i loro suggestivi gorgheggi.
Le azioni, la trama stessa, è piegata a questa logica
estetizzante di un iper-movimento, innaturale, fantastico,
dove gli attori saltano, quasi volano, compiendo acrobazie
fisicamente impossibili, tutte realizzate con la tecnica della
computer graphics. Una sorta di cartone animato, dunque, ma
talmente realista che il pubblico non si accorge che è
tutto finto, disegnato, disegnato al computer.
Nulla contro questo tipo di tecnica. Ma qui produce solo un
barocchismo fine a se stesso e noioso. Vecchiume digitale,
figlio dei più ritriti videogiochi.
Zhang Yimou si sarà anche nutrito dei drammaturghi
greci e di Shakespeare ma sembra aver dimenticato le sue radici
nel mondo dei mandarini e dei samurai. Non c’è
più magia nei suoi film e le sue improbabili leggende
d’amore e di morte non commuovono più.
Ciò che notiamo è solo una esasperante (e per
certi versi sconfortante) omologazione al gusto occidentale.
Incasserà un mucchio di sodi!
|
Torna
su
|
L’Ala
dell’angelo. Itinerario di un comunista perplesso"
di Lorenzo Gallo
|
| Dopo
aver letto questo libro di memorie, in cui Rosini delinea
il percorso intellettuale che lo portò all’adesione
e alla militanza all’interno del Partito Comunista Italiano,
d’impulso avrei voluto scrivere una sfilza di lodi mirabolanti
carica di punti esclamativi, sul profondo acume, sull’eleganza
del fraseggio, sulla modestia e l’onestà di quest’uomo
eccezionale. Mi sono reso conto, però, che una simile
recensione non si adatta allo stile piano e spoglio d’ogni
retorica del Rosini. Cercherò, pertanto, di contenere
e dissimulare il mio entusiasmo.
Tutto
il libro mi è apparso come una lunga elegia, dominata
dalla consapevolezza di aver servito un ideale splendido,
senza poterlo realizzare – né, d’altra
parte, sarebbe stato possibile: voler cambiare il mondo nel
corso di una generazione fu un peccato di hybris, da cui l’autore
si proclama guarito, senza però aver perso fiducia
nell’Ideale, nonostante le rivoluzioni comuniste nel
mondo per ora siano fallite: si sono spente nel sangue, o
– peggio – si sono trasformate in tirannidi.
Però
l’umiltà, l’impegno e la dedizione alla
causa che traspaiono da queste pagine sono per me un carissimo
frammento della storia di quello che fu, nonostante i suoi
numerosi torti, il Partito più bello della storia d’Italia,
in cui migliaia di cuori potevano vibrare all’unisono;
una comunità di spiriti eletti che si disperse solo
con il venir meno dell’Ideale.
Rosini,
rifuggendo da apologie e autoencomi, ha realizzato così
quasi controvoglia un piccolo, leggiadro monumento alla moralità
delle donne e degli uomini comunisti, cui l’Italia deve
tutto ciò che di bello e di dignitoso è avvenuto
nell’ultimo secolo; un monumento il cui nitore spicca
nel grigio di questi tempi gretti.
In conclusione,
L’ala dell’angelo è un libro commovente,
che emozionerà tutti coloro che non abbiano un cuore
marcio, nero come la tirannide da cui Emilio e tanti altri
eroi sconosciuti ci hanno liberato.
Leggi
anche "Presentazione de: L'Ala
dell'Angelo"
|
Torna
su
|
Quando
le parole… affilano i coltelli
di Antonino Pingue
Chi fa
il mio mestiere, cioè lavora con le parole da mattina
e sera, cercando anche di ricavarci un guadagno, sa molto
bene che un testo nasconde al suo interno tanti piccoli ingranaggi
segreti.
Eppure a scuola ci hanno insegnato ad individuare queste “macchinerie”
solo nei grandi autori, con il risultato che la bellezza di
un testo ci appare ormai qualcosa che sa di Rinascimentale
o comunque di lontano.Invece spesso la bellezza delle parole
(o comunque la loro efficacia), fa parte della nostra vita
quotidiana.
Tanto
più che questi “trucchi del mestiere”,
ci sono continuamente propinati nei telegiornali, nelle pubblicità,
negli articoli dei giornali, ma anche nei romanzi e nelle
fiction. Conoscerli può essere utile. Aggiungo anche
che non bisogna guardarli con alterigia: essi sono parte integrante
dell’arte di saper scrivere che è anche arte
di saper comunicare o meglio arte di saper “interessare”.
Tentiamo allora l’analisi di un brano molto molto particolare,
accostandosi a questo con il massimo (!) rispetto e la massima
(!) stima e ammirazione… lasciamo al lettore valutarne
il grado di ironia.
Ad urlarlo nel mio quartiere (S. Giovanni) è un arrotino
ambulante. Egli passa tutte le domeniche mattina sotto casa
mia a bordo di una vecchia macchina, con megafono montato
sul tetto da cui recita:
DONNE, È ARRIVATO L’ARROTINO!
ARROTO: COLTELLI, FORBICI, FORBICINE, FORBICI DA SETA, COLTELLI
DA PROSCIUTTO.
DONNE! E’ ARRIVATO L’ARROTINO E L’OMBRELLAIO
AGGIUSTIAMO GLI OMBRELLI
L’OMBRELLAIO, DONNE!
RIPARIAMO LE CUCINE A GAS.
ABBIAMO I PEZZI DI RICAMBIO PER LE VOSTRE CUCINE A GAS.
SE AVETE PERDITE DI GAS, NOI LE AGGIUSTIAMO.
SE LA VOSTRA CUCINA FA FUMO, NOI ELIMINIAMO IL FUMO DELLA
VOSTRA CUCINA A GAS.
LAVORO SUBITO
IMMEDIATO!
Il testo,
apparentemente commerciale, è in realtà sommamente
poetico ed efficace.
Il primo verso è pronunciato marcando la D di donne,
facendo una piccola pausa prima del verbo, e prolungando leggermente
l’ultima vocale di “arrotino”.
L’incipit è breve, preciso, inequivocabile. Contiene
sia il messaggio, sia il soggetto a cui il messaggio è
diretto. Inoltre, sfruttando il suono duro della D di “donne”,
l’arrotino lo utilizza come rombo, tuono, mortaretto.
E’ implicita una sospensione temporale. Sembra dire:
“Se state facendo qualcosa smettete di farla (ddonne!).
Se state passando l’aspirapolvere, invaghitevi della
mia voce che è riuscita a raggiungervi nel vostro tecnologico
rumore: ho da parlarvi, e potete giurarci, ne varrà
la pena”.
Nel secondo verso (Arrota: coltelli, forbici, forbicine, forbici
da seta, coltelli da prosciutto), l’arrotino passa ad
un tono più trattenuto. A livello fonetico si limita
a sottolineare la doppia R di “arrota”, ma trasforma
un noioso elenco d’utensili, in una piccola filastrocca.
Non dice infatti: “forbici, forbici da seta e forbicine”,
che suonerebbe noioso, ma sfrutta la graziosità del
diminutivo così che: “forbici, forbicine, e forbici
da seta”, ci serva da viatico per entrare in un mondo
di sogni, nel regno felice dove tutto è affilato.
Attento a non cadere nel lezioso, però, chiude il verso
con un concetto maschio, pratico, concreto, metallico e inflessibile,
ma al tempo stesso, saporito, salato, sostanzioso come: “coltelli
da prosciutto”. E per legare la cosa alle svariate e
infinite forbicine citate, sfrutta la ripetizione di “coltelli”,
con cui la frase si apre.
Il verso, perfettamente simmetrico, allude al tempo stesso
ad un’energia vigorosa, levigante, rappresentata da
“coltelli”, ma ammicca anche ad una sensibilità
tipicamente femminile (le “forbicine”). Insomma
questo arrotino ha braccia forti, capaci di arrotare, ma è
anche dolce, paterno e ispira fiducia.
Va da sé che a questo punto ha attratto la nostra attenzione.
Ma non basta. Ripete: “ddonne! è arrivato l’arrotino
e l’ombrellaio”. Pronuncia il verso con uguale
tono, ma ora, quando comincia a prolungare l’ultima
vocale di “arrotino”, che noi quasi c’eravamo
assuefatti, che quasi lo prevedevamo, lui improvvisamente
prende fiato, pronuncia squillante la congiunzione e subito
dopo dà la notizia: è anche un ombrellaio!
Se stavate correndo alla porta con i vostri coltelli e le
vostre forbicine, ora vi fermate e tornate indietro a prendere
anche gli ombrelli.
Notare come il verso, molto astutamente, ha una duplice funzione.
Ricominciando da “ddonne” palesa la sua ambizione
di poesia, di verseggiare, di Trovatore sotto il vostro castello
(ovvero non state assistendo ad un annuncio ma ad una serenata);
dall’altra la ripetizione del verso attutisce la sorpresa
dell’ombrellaio. Egli non vuole apparire come qualcuno
che nasconde qualcosa. Non vuole essere cioè ansiogeno.
Agganciando “l’ombrellaio” ad “arrotino”
coniuga le due cose. Implicitamente sembra voglia tranquillizzarvi.
Non dice: sono un arrotino, e poi… errore! sono un ombrellaio.
Dice: sono un arrotino e un ombrellaio.
Lui è il genio della lampada, porta buone nuove dal
paese dei balocchi, ha mille storie per voi, e chi lo ascolterà
cadrà in stato di grazia.
Consapevole della novità, l’arrotino insiste
con tono dolce, un pizzico didascalico. Spiega, conciliante,
che un ombrellaio aggiusta ombrelli. L’ombrellaio, appunto,
dddonne.
Ora che con accortezza ha conquistato la vostra fiducia, ma
che dico? il vostro affetto! mette subito a frutto la cosa,
esplicitando le sue nobili origini (che vanno a legarsi con
le sue nobili intenzioni). Si autopromuove Principe Azzurro
e passa al plurale maiestatis. Ogni residuale sospetto cade.
Ogni barriera fra te, antropologicamente definita ddonna,
e un, tutto sommato estraneo, è annullata. Una nuova
realtà affascinante è inventata di sana pianta
(come solo i grandi poeti sanno fare). E’ la fine di
tutte le colpe, il giubileo delle buone maniere, della vecchia
galanteria; tanto più pregna di significato se annunciata
da, niente popo’ di meno, un principe. Il principe degli
arrotini… che è anche ombrellaio!
E allora egli fa un altro piccolo passo avanti e allude...:
“Ripariamo le cucine a gas. Abbiamo i pezzi di ricambio
per le vostre cucine a gas”.
Allude per la prima volta, non solo a che voi scendiate sotto
il portone a portargli coltelli, forbicine e ombrelli, ma
che sia lui, udite udite, a salire a casa vostra, ad entrare
nel talamo, nella centrale operativa del vostro potere casalingo:
la cucina!
Riflettiamo…
Quanto assurda sarebbe stata questa richiesta solo cinque
righe sopra?
Un uomo, dal timbro di voce vagamente fallico, che passeggiando
rumorosamente in macchina (per giunta su una macchina fuori
moda) invita in coro le donne a farlo salire in casa? Inaudito!
E di mattina per giunta, quando i mariti sono fuori. Sì,
i poveri mariti poco fallici, e dai soprannomi capponeschi
(pici pici, cipollino di Tittina tua, puffetto della casa,
puzzolo, pancino, rolletto, coccolino, eccetera eccetera).»
Ora la cosa appare invece perfettamente plausibile. Lui è
arrivato a questo risultato senza che voi ve n’accorgevate,
anzi, senza neanche che voi poteste sospettare a cosa realmente
mirava. Ha modificato l’orizzonte delle nostre conoscenze.
Aperto possibilità considerate remote. Non ha inventato
nulla a ben vedere, ma ha dato forma.
Ecco la vera poesia! Quella nascosta, modesta, pregna d’odori,
non avulsa, ma completamente calata nel reale. Pratica!
Bisogna inoltre notare che non ha mai usato su di sé
un aggettivo. Non ha detto: sono bravo, vi ha alluso. Non
ha detto: sarò gentile, lo ha dimostrato.
Così, tutte trafelate dalle vostre faccende domestiche
(ddonne!), circondate da detersivi corrosivi, smagliate nelle
calze, tradite dai parrucchieri e insultate dalla cellulite,
vi torna in mente, il sapore pratico e corposo di: “coltelli
da prosciutto”. E ve lo ripetete estasiate: “Coltelli
da prosciutto”.
E anche noi maschietti, certo, noi poveri maschietti casalinghi
(n’esistono sempre di più), siamo presi alla
voce nerboruta dell’arrotino, da una folata omofobica
e ci precipitiamo, nostro malgrado, alla finestra, invidiosi
a guardare.
E’ una primavera femminile quella che si scorge. Donne,
donnine e donne di servizio affollano le vie, e i portoni
si aprono e si chiudono, mentre pantofoline piumate tacchettano
lungo vialetti condominiali condonati da malconce piante grasse.
E’ un fiorire di mondi alternativi.
“Se la vostra cucina fa fumo” giura il Poeta,
“noi eliminiamo il fumo della vostra cucina a gas”;
ripetendo cucina, gas e fumo, come un unguento speziato steso
a lenire le preoccupazioni quotidiane.
“Quando, quando?”, urlano le ddonne.
“Lavoro subito” annuncia finalmente esplicito,
“Immediato!”.
Il resto, è letteratura.
|
Torna
su
|
Giovanni
Boldini
di Isabella La Costa
Giovanni Boldini (1842-1931) è stato
uno dei grandi protagonisti della cosiddetta Belle époque,
di cui seppe incarnare, soprattutto attraverso gli splendidi
ritratti femminili, lo spirito di effimero compiacimento e
di implicita decadenza.
L'importante mostra che si è aperta a Padova da pochi
giorni intende dunque ripercorrere la carriera del pittore,
cercando di superare il luogo comune che lo vuole esclusivamente
fine interprete del gusto dell'alta borghesia parigina a dispetto
delle sue sperimentazioni stilistiche così prossime
all'ambiente impressionista da fargli guadagnare l'amicizia
di Degas e la sospettosa diffidenza di Monet e Renoir. Le
quasi centoventi opere, prestate dalle più famose collezioni
pubbliche e private sia europee che americane, offrono uno
spaccato completo e approfondito sui vari passaggi della crescita
artistica di Boldini dalla formazione a Firenze a contatto
con il gruppo dei Macchiaioli, alla fortunata avventura francese
(preludio a una vita di viaggi anche oltreoceano) caratterizzata
dalla proficua collaborazione con lo scaltro Groupil, scopritore
di talenti e vero magnate del mercato d'arte di Parigi. Non
solo ritratti, quindi, ma anche vedute (come quelle di Venezia)
e scene di vita cittadina che consentono al visitatore di
apprezzare la sua particolare tecnica pittorica fatta di improvvise
sciabolate di colore (memori dello studio sui maestri spagnoli
del Seicento, in primo luogo Velazquez) che quasi sciolgono
le forme in immagini vacue ma frementi, simili per certi versi
agli effetti cromatici del pastello, che non a caso era uno
dei medium prediletti dall'artista.
Tra i tanti capolavori in mostra è
infine interessante sottolineare la presenza del Ritratto
della marchesa Lucia Casati della Galleria Nazionale d'Arte
moderna di Roma (vera icona della manifestazione, nella brochure
in copertina), recentemente al centro di una piccola ma singolare
esposizione -in contemporanea con la mostra La Primavera di
Galileo Chini- tenuta nella sala Boldini della stessa Galleria
Nazionale d’Arte Moderna: L’Opera in prestito,
dalla National Gallery di Toronto, “The Marchesa Casati”
di Augustus John. In questa mostra, a suo tempo segnalata
nel nostro sito in “Appuntamenti in città”,
si poneva a confronto l'opera di Boldini con un altro ritratto
della marchesa realizzato da Augustus John e un terzo quadro
di Kees van Dongen, dubitativamente proposto come ulteriore
effigie dell'eccentrica nobildonna.
|
Torna
su
|
“Mitteleuropa
sul Tevere”
Neoclassico e Biedermeier
dalle collezioni Coronini Cronberg di Gorizia
22
ottobre 2004 – 27 febbraio 2005
Museo Mario Praz – Roma
Pochi
anni separano il Conte Guglielmo Coronini Cronberg (1905-1990)
da Mario Praz (1895-1982). Collezionisti entrambi, quasi coetanei,
l’uno conservò ed accrebbe un vasto patrimonio
familiare di arredi
ed opere d’arte, oggi confluito nella Fondazione che
ne ricorda il nome, l’altro creò dal nulla, confortato
dai suoi studi, una dimora di squisita coerenza che esemplarmente
illustra il gusto dell’abitare tra il1770 ed il 1850,
tra neoclassicismo appunto e biedermeier.
Anche questa casa è divenuta un museo – il Museo
Praz – e proprio in questa sede, nel piccolo spazio
dedicato ad esposizioni temporanee vengono ora mostrate trenta
opere, selezionate tra le tante che la collezione goriziana
possiede, proprio sulla base della loro appartenenza agli
anni prediletti da Praz.
Scelte sulla base della loro eccellenza, della loro capacità
di rappresentare sinteticamente la storia della famiglia Coronini
Cronberg in quegli anni, e soprattutto sulla base della loro
capacità di sviluppare sintonie e rimandi con le opere
della collezione Praz, le trenta opere spaziano dal mobilio
ai bronzi impero, alle scene di conversazione, ai ritratti
familiari di gusto biedermeier, alle malachiti ed agli argenti
russi, fino agli acquerelli d’interno.
Accanto ai nomi assai noti, come quelli dello scultore danese
Thorwaldsen o del bronzista parigino Thomire, si trovano quelli
di artisti minori ma non meno rappresentativi, come quello
del francese J.B.G. Youf, autore di molti dei pregevoli mobili
impero delle case dei Bonaparte, di cui anche in collezione
Praz esiste un secrétaire, o della pittrice Margherite
Ancelot Chardon (1792-1875) il cui ritratto della famiglia
russa Kuschnikoff, a Parigi nel 1818, avrebbe potuto configurare
nelle Conversation pieces pubblicate da Praz nel 1971.
Ritrattisti dell’area mitteleuropea come J.N.Ender (1793-1876)
o M.Sthol (1818-1881) sono presenti in entrambe le collezioni,
ma l’assonanza più tipicamente “prazzesca”
è quella offerta dalla bella tempera, presente in mostra,
di Michelangelo Maestri (notizie tra il 1779 e il 1812), desunta
come molta della sua produzione da un prototipo raffaellesco,
che raffigura Medea e che con altri tre analoghi soggetti
è riprodotta identica all’interno di uno degli
acquerelli della collezione Praz, eseguito in Inghilterra
attorno al 1840 dal pittore di origine russa Francio Stephanoff.
La collaborazione
offerta dal Museo Praz è stata per la Fondazione Palazzo
Coronini Cronberg un’occasione davvero unica sia per
la splendida cornice messa a disposizione sia per aver dato
alla dimora storica goriziana la possibilità di poter
essere presente sul panorama artistico e culturale nazionale
in una fase molto delicata del proprio sviluppo: dallo scorso
anno infatti sono in atto importanti restauri strutturali
del complesso museale che ne hanno richiesto la chiusura temporanea
al pubblico, mentre sono rimasti visitabili i cinque ettari
di parco all’inglese che circondano la Villa cinquecentesca.
Galleria
Nazionale d’Arte Moderna Museo Mario Praz
Roma |
Fondazione Palazzo Coronini
Cronberg
Gorizia
|
Per informazioni:
Palazzo Coronini Cronberg, v.le XX Settembre, Gorizia 0481.533485
fax 0481.547222
Museo Mario Praz, via Zanardelli, 1, 00186 Roma tel. 06.6861089
fax 06.3221579
|
Torna
su
|
"Vecchiaia"
di Alberto Madricardo*
Proponiamo
un saggio che ci sembra particolarmente interessante per
il tema e il titolo che, nella sua rude semplicità,
appare coraggioso e quasi provocatorio (se non altro perché
parla di "Vecchiaia" e non di quella ormai universalmente
denominata "Terza Età"...)
La vecchiaia è prima di tutto uno stadio della vita,
quello finale. Con l’iniziale condivide la delicatezza:
l’inizio, come alla fine, la vita è più
fragile ed esposta. La vecchiaia è insieme evento personale,
“privato”, e pubblico. E’ però prima
di tutto un fatto intimo, riguarda il rapporto che ogni uomo
ha con la propria esistenza.
Solo in epoca relativamente recente la vecchiaia è
diventata una questione di rilevanza generale: con la creazione
dello stato sociale. Prima – fino a poco più
di un secolo fa – era un problema dei singoli, delle
famiglie, al massimo delle associazioni caritative ed assistenziali.
*
Per il profilo dell'autore vedi in calce a "Aforismi"
in Cultura
Per
leggere l'articolo clicca qui
Commenti
al testo di voi soci
|
| |
|
| |
 (13/1/05)
da Paola Sereni (13/1/05)
da Paola Sereni
Il
saggio è scritto in maniera intensa e suggestiva, però
lo trovo – spero che l’autore mi perdoni –
discretamente autoreferenziale, e soprattutto astratto rispetto
allo spaccato della società in cui viviamo. Sembra che
l’autore dimentichi che la valenza sociale della vecchiaia
è tanto differente da individuo a individuo e meraviglia
che riesca a scrivere di vecchiaia in maniera così dotta
e filosofica, ma avulsa dalla realtà sociale... come
se un vecchio ricco e uno povero fossero simili (e invece c’è
un abisso!) o un vecchio “intellettuale” fosse simile
a un vecchio camallo (altro abisso!). E’ difficile soprattutto
che i pensieri dell’autore - peraltro affascinanti - stimolino
riflessioni serene.
Credo che l’autore non abbia ad esempio mai pensato quanto
è doloroso per una donna dover metabolizzare che la vecchiaia
per un uomo può essere socialmente neutralizzata dal
potere, i soldi, e quant’altro, mentre le donne –
diceva giustamente una volta in televisione Aldo Busi che di
misoginia se ne intende – non hanno capito che per loro
la bellezza (e il suo “vissuto” che, secondo il
comune sentire per una donna è legato indissolubilmente
alla giovinezza) è una trappola mortale... Ci vorrebbe
un po’ di leggerezza calviniana per sorvolare sulla pesantezza
dell’argomento... ma non è facile. Mi piacerebbe
conoscere il parere di qualche altro socio e/o frequentatore
del sito
|
| |
|
| |
 (29/1/05)
da Alberto Madricardo (29/1/05)
da Alberto Madricardo
Cara
Paola Sereni,
riguardo alla medietà certo che c'è una branca
della psicologia, ma anche della sociologia, della economia,
ecc. che si basano sulle statistiche della media. Ma si tratta
comunque di una astrazione necessariamente rozza ed approssimativa,
compiuta per scopi operativi, che non funziona neanche sempre
e non più di tanto (pensa ad es. alle "previsioni
scientifiche" degli economisti, che si avvicinano per
esattezza di previsione agli oroscopi) .
L'uomo medio, inoltre, come il ricco, non passerà mai
attraverso la "cruna dell'ago" e per la "porta
stretta" di cui parla il vangelo. La medietà è
il pericolo che minaccia la democrazia. Nella medietà
ciascuno si conferma attraverso gli altri e nessuno per e
davanti a se stesso. Tutti perciò sono subalterni e
nessuno libero. Il demagogo lo sa, e si presta a far da schermo
rassicurante tra ciascuno e se stesso. Ma anche lui appartiene
alla medietà, perchè egli stesso usa la massa
che domina come schermo tra sè e sé.
L'alternativa alla medietà non è l'aristocraticità,
che è caratterizzata dalla legittimazione davanti a
se stessi per "l'essere meglio degli altri", è
il legittimarsi davanti a se stessi prima che davanti agli
altri.
Continuando, sarebbe un bel tema. Per quanto riguarda lo "spaccare
la parola in quattro" credo che sia proprio quello che
si deve fare.- Il linguaggio è come un labirinto che
offre una infinità di vie, tutte apparentemente obbligate
- le parole - che non portano però da nessuna parte
(cioè alla chiacchiera). Bisogna esaminare le parole,
specie alcune, perchè possono contenere dei trabocchetti.
Le situazioni di stallo, in cui veniamo a trovarci storicamente,
hanno prima di tutto ragioni linguistiche. Il bla bla che
impera nei mezzi di comunicazione non è altro che la
rappresentazione dello spettacolo per molti aspetti osceno
dell'impotenza della democrazia, che evoca neanche tanto velatamente
sullo sfondo la figura del "decisore".
Mi rendo conto che mi sono lasciato andare troppo. Mi fa piacere
che il mio discorso sulla vecchiaia abbia suscitato qualche
reazione.
Ciao Alberto Madricardo.
|
Torna
su
|
Presentazione
de: "Finale, presto" di Ayres Cenni
Ayres
Cenni è nata a Roma ma, di famiglia colta e cosmopolita,
è vissuta a lungo all’estero e parla correntemente
tre lingue. Le sue poesie infatti sono in italiano, in inglese
e spagnolo. Così, non solo affascina nei suoi versi
l’intreccio sinestesico di sfere sensoriali diverse,
ma la musicalità della lingua di volta in volta scelta
riflette la cultura sottostante e spinge a cambiare continuamente
registro nell’ascoltare la poetica dell’autrice
per apprezzarne a fondo l’intensa vitalità e
umanità che ne traspare.
“Finale, presto” si snoda entro sei percorsi intitolati
corripondenze, patrie, scorie, evasione, amore, musicalia,
in un fuoco d’artificio fantastico ed incalzante tra
esperienze storiche ed emozioni private.
|
Torna su
|
Presentazione
de: "L’Ala dell’Angelo.
Itinerario di un comunista perplesso", di Emilio Rosini*
|
| Roma
2003, Edizioni di Storia e Letteratura (collana: Letture di
pensiero e d’arte)
Dal risvolto di copertina: Dove siano finiti
i comunisti italiani, si chiedeva recentemente Vittorio Foa:
«...sarebbe importante sapere qualcosa delle loro scelte,
come le vedevano allora e come le vedono adesso, se sono ancora
comunisti e in quale modo, se non lo sono più, da cosa
sono stati mossi. Il comunismo specificamente italiano...minaccia
di restare senza testimoni».
Questo libro è una testimonianza.
L’autore si confronta con le sue esperienze archiviate
ma non rimosse. Un tentativo di estrarre qualche barlume di
storia dalla elaborazione e revisione critica di atteggiamenti,
convincimenti e giudizi condivisi da buona parte della sua
generazione.
*Dalla
quarta di copertina: Emilio Rosini (nostro socio onorario,
ndr) ha operato attivamente nel Partito Comunista Italiano
dal 1944 al 1966 rappresentandolo anche alla Camera dei Deputati.
E’ stato avvocato, docente, consigliere di Stato, presidente
del T.A.R. del Veneto, vicesindaco di Venezia
|
Torna
su
|
Parapista
che cipista! di Antonino Pingue*
Come
confrontarsi con persone di culture diverse, che parlano strane
lingue, e vengono da paesi lontani… anche molto lontani?
Può essere la lingua il paradigma di un gigantesco
equivoco? Sembra un tema difficile, ma Antonino Pingue lo
affronta con originale allegria nel suo “Parapista che
cipista!”, uscito per la Mursia a primavera del 2003
e che la redazione di WebTimeC non poteva non segnalare insieme
agli altri libri che i nostri soci scrittori hanno pubblicato. |
 |
Un
romanzo per giovani lettori (svegli) dai 10 anni in su. Cominciamo
dal titolo: non è ostrogoto, è Laktanese. Significa:
“gioia, stupore, meraviglia. Lo puoi dire quando la
tua squadra fa goal, quando ti regalano una torta al cioccolato,
quando senti cose intelligenti in tv, e per altri avvenimenti
straordinari”. Altri esempi di laktanese: “Pazza
li panza”, vuol dire in bocca al lupo. “Gambalsta
con la gasta bartamista”: salve come stai?. E, per finire,
l’intraducibile proverbio: “Sella garba non spiscialla
va alla morra del pollilla”
A parlare così è Lak, un extraterrestre atterrato
sulla Terra per studiarci. A fare le spese di questo strano
linguaggio sarà il giovane Simone. Tra i due nasce
una rocambolesca amicizia, piena di fraintendimenti e personaggi
bizzarri, dove Lak si convince che Simone nel frigorifero
tiene elicotteri e che la sua maestra è una scimmia.
Leggi
l’incipit
Leggi
l’incipit in Laktiano
HANNO DETTO DI PARAPISTA CHE
CIPISTA:
«Parapista
è un libro rodariano in piena civiltà dell´immagine,
con il risultato che se Lak parla una lingua inedita –
tanto che al libro il suo autore ha deciso di allegare un
mini dizionario indispensabile per decifrare il laktiano –
a rivelarsi sorprendentemente nuova finisce per essere quella
di Simone, cioè la nostra, secondo un gioco di rispecchiamenti
da cui Rodari ha tratto miracoli.»
LaRepubblica 9 marzo 2003
«Un romanzo divertente, costruito intorno
ad un argomento che i ragazzi affrontano tutti i giorni: il
linguaggio, il suo valore e la sua relatività. Le regole,
e l’invenzione. Per scomodare parole più complesse:
il significato e il significante.»
LaStampa, 15 marzo 2003
«Nel leggere Parapista
che cipista non ho potuto fare a meno di pensare al grande,
anzi, gigantesco Roald Dahl e alle sue indimenticabili storie,
prima fra tutte “Il GGG”: con il suo strano modo
di esprimersi ed un aspetto così particolare, il Grande
Gigante Gentile non potrebbe benissimo essere un alieno, proprio
come Lak?!»
SuperEva
Leggi l’articolo apparso
su SuperEva qui
*
Antonino Pingue vive a Roma con una
moglie e un gatto (non necessariamente in quest’ordine).
Lavora come sceneggiatore, e per la Rai scrive fiction e sit-com.
E’ socio di WebTimeC con cui collabora attivamente nella
redazione e come coordinatore-responsabile dei corsi d’informatica.
In particolare Antonino sta predisponendo moduli (individuali
o a piccoli gruppi) di scrittura professionale e/o scrittura
creativa.
Leggi
la scheda dell’autore in laktiano
|
Torna
su
|
Le
cose dell’amore di Umberto Galimberti
Libro
complesso e colto, sta diventando il successo editoriale di
queste feste. Un’analisi dell’amore svolta, non
con una prospettiva psicanalitica (come al solito!), ma tramite
una vasta cognizione filosofica. Agile, ma non per questo
semplicistico, diviso in rapidi capitoli monotematici (Amore
e Trascendenza; Amore e Sessualità; Amore e Seduzione;
Amore e Passione; ecc.) Galimberti, docente in Filosofia della
Storia e Psicologia Generale all’Università di
Venezia, ci regala uno sguardo diverso e critico verso questo
sentimento così come si è venuto a trasformare
ai giorni nostri. |
|
Scrive nella prefazione Galimberti: «L’amore
da un lato è diventato l’unico spazio in cui
l’individuo può esprimere davvero se stesso,
al di fuori dei ruoli che è costretto ad assumere in
una società tecnicamente organizzata, dall’altro
lato questo spazio, essendo l’unico in cui l’Io
può dispiegare se stesso e giocarsi la sua libertà
fuori da qualsiasi regola e ordinamento precostituito [ a-more:
dove l’alfa privativo si accosta al sostantivo latino
mos, moris, costume, regola, ndr], è diventato il luogo
della radicalizzazione dell’individualismo, dove uomo
e donna cercano nel Tu il proprio Io, e nella relazione non
tanto il rapporto con l’altro, quanto la possibilità
di realizzare il proprio Sé profondo, che non trova
più espressione in una società tecnicamente
organizzata, che declina l’identità di ciascuno
di noi nella sua idoneità e funzionalità al
sistema d’appartenenza.»
Curiosità: mentre riflettiamo con
Galimberti sul pudore (se Dio non ha pudore in quanto non
ha corpo, e l’animale non ha pudore perché non
ha il senso della propria individualità, il pudore
umano esprime costantemente la dialettica fra queste due dimensioni
che così intimamente ci costituiscono) o sulla passione
(la passione è “patire l’altro” e
non c’è passione che non comporti una sorta di
alienazione da sé), apprendiamo anche, sorprendentemente,
che la canzone “Come te non c’è nessuno”
della Rita Pavone degli anni ’60 ricalca fedelmente
i concetti espressi da Giovanni Gentile in “Frammenti
di una gnoseologia dell’amore”…
|
Torna
su
|
Uno
sguardo sulla disciplina giuridica e tributaria dei fondi
pensione
di Massimo A. Procopio*
Il
libro, di cui segue un abstract, illustra le fondamenta giuridiche
e tributarie dei fondi pensione. |
Com’è
noto, il legislatore ha attribuito alla previdenza complementare
un ruolo di fondamentale importanza per la soluzione dei problemi
che si porranno in un prossimo futuro in ordine alla (purtroppo)
inevitabile riduzione delle prestazioni pensionistiche obbligatorie.
Più in particolare, le prestazioni erogate dai fondi
pensione saranno destinate, da una parte, a compensare la
riduzione di quelle pubbliche e, dall’altra, a costituire
una vera e propria pensione per quei soggetti sprovvisti di
previdenza di base. Si tratta, come può rilevarsi,
di un rilevante problema di ordine sociale.
Il d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 contiene la disciplina delle
forme pensionistiche complementari. Tale decreto, tuttavia,
nonostante le numerose modifiche cui è stato oggetto,
non appare sufficientemente incentivante a favorire l’adesione
alle forme pensionistiche complementari. Per tale ragione
il Parlamento ha approvato la legge 23 agosto 2004, n. 243,
contenente norme in materia pensionistica e deleghe al Governo
nel settore della previdenza pubblica, per sostegno della
previdenza complementare. Il decreto legislativo dovrà
essere emanato entro il mese di settembre 2005. Uno dei principi
contenuto nella citata legge-delega è quello relativo
al conferimento del tfr quale fonte di finanziamento della
previdenza complementare.
La
disciplina giuridica e tributaria dei fondi pensione, Collana
di diritto del lavoro, FrancoAngeli s.r.l., Milano, 1^ edizione
2002
di Massimo A. Procopio
*
Il nostro socio Massimo A. Procopio
è dottore commercialista in Roma. Autore di numerose
pubblicazioni in materia di diritto tributario e societario,
è docente in vari corsi organizzati da primari istituti
di management e dall'Istituto Superiore dell'Economia e delle
Finanze.
Si è dedicato alla complessa problematica delle forme
pensionistiche complementari sin dall’entrata in vigore
della legge delega 421/92, partecipando quale relatore a convegni
nazionali e tenendo numerosi seminari.
E’ così competente e appassionato nella sua materia
(!) che è disposto - su richiesta tramite il nostro
sito - a dare ampie spiegazioni sugli argomenti trattati dal
suo libro e dalle altre sue pubblicazioni, affiancando eventuali
soci/socie che vogliano apprendere la normativa e/o suggerimenti
in tema di fondi pensione o altri argomenti collegati, avvalendosi
anche di ricerche su Internet o altri mezzi informatici.
|
Torna
su
|
La
globalizzazione e i suoi oppositori,
di Joseph E. Stiglitz
di
Alberto Madricardo
A
due anni dalla pubblicazione in edizione italiana, il libro
di Stiglitz sui contraccolpi devastanti di una globalizzazione
liberista "ideologica" e sulle gravi responsabilità
degli organismi internazionali che dovrebbero garantire la
armonizzazione delle diversità nel mondo resta un punto
di riferimento imprescindibile per chiunque voglia comprendere
più a fondo le dinamiche economico-sociali in atto.Riproponiamo
perciò una vibrante recensione del volume pubblicata
subito dopo la sua uscita sul periodico "Polizia e democrazia",
Ed. d.D.E,. Roma
I
veri nemici della globalizzazione
Nella globalizzazione vi sono organizzazioni che dovrebbero
regolare e orientare nel senso di una crescente armonizzazione
le economie del mondo. Ma queste organizzazioni, come il Fondo
Monetario o la Banca Mondiale, spesso agiscono secondo logiche
che non corrispondono agli interessi del mondo, specialmente
della sua parte più povera.
Stiglitz, che conosce bene i meccanismi degli organismi finanziari
mondiali per avere ricoperto in essi incarichi di primo piano,
conduce una serrata analisi da cui si può giungere
ad identificare chi siano veramente, al di là delle
apparenze, i nemici della apertura delle economie e dello
sviluppo mondiale.
Per
leggere l'articolo clicca qui
Commenti
al testo di voi soci |
| |
|
| |
 (13/12/04)
da: Francesca (13/12/04)
da: Francesca
Caro webtimec, da tempo volevo complimentarmi
per l'impostazione divertente e
interessante che avete dato al SITO, per
la sua qualità.
Alcuni giorni fa mi sono soffermata sulla recensione del libro
di Stiglitz
di Alberto Madricardo che ho molto apprezzato. In particolare
ho apprezzato
la sua capacità di sintesi e di interpretazione "onesta"
del complesso
pensiero di Stiglitz che evidentemente l'autore condivide
lucidamente
(anch'iooooooooo!). A presto
Francesca
|
Torna
su
|
"Aforismi"
di Alberto Madricardo*
•
Che cosa c’è di peggio dell’inferno? Il
momento in cui ci si accorge di essere passati attraverso
il paradiso e di non averlo visto.
• Il mondo effettuale senza la possibilità è
come un asteroide morto.
• La realtà è una linea retta. Ma noi
sappiamo tracciare solo cerchi.
• Alla poesia almeno un poco collabora l’ignoto,
il mondo non chiuso.
• Pensare all’universo come ad un “cosmo”
è già di per sé esprimere la essenza
di ogni teodicea.
• La sacralità ha prima di tutto bisogno dell’assenza.
Ma sacro è ciò che nell’assenza è
più vicino alla presenza.
• Nel labirinto la via d’uscita è dove
non c’è nulla.
• La violenza diviene sovranità quando nessuno
osa più misurarsi con lei.
• Più ci si avvicina all’essenziale, più
si assapora il gusto della semplicità. Ma anche, allo
stesso tempo, tutte le furie si scatenano.
• Chi non ha un aggancio nel rovescio delle cose è
condannato a scivolare qua e là, sospinto da ogni piccolo
urto, insieme a tutto il suo sistema di riferimenti. Perciò
senza accorgersene.
• Quando si afferma che tutto è dominato dalla
necessità si intende dire che solo ciò che è
necessario davanti a se stesso può accettare di passare
al nulla.
• A volte, per sentire meno dolore, ci si rende più
piccoli. Restringendo se stessi si restringe anche il dolore.
• Non si ama pienamente una persona se non si prova
stupore per la sua esistenza.
• Preoccupato di tenere dritta la prua alla meta, non
si cura affatto di raggiungerla: questo è lo spirito
della morale.
• Che il passato possa essere redento è un’idea
molto più totale che quella di dialogare infinitamente
con l’infinito.
*Alberto
è un socio di WebTimeC... che vive e opera a Venezia
e in Friuli.
Laureato in filosofia all'Università di Padova, ha
insegnato nelle scuole superiori, è
attualmente presidente dell'Associazione
Culturale Nemus e in contatto con associazioni culturali
in area veneta e friulana, ha interessi molteplici che spaziano
dalla pedagogia, all'estetica, al teatro, oltre che alla filosofia,
soprattutto alla filosofia della storia. In collaborazione
con l'Istituto Studi Filosofici di Venezia o con altre istituzioni
nazionali e locali ha
promosso corsi di aggiornamento per docenti, ha partecipato
come docente o relatore a corsi, master per docenti, convegni
anche internazionali. Collabora a riviste e siti culturali,
è autore di saggi e in particolare di testi teatrali
che sono stati rappresentati a Udine e in Friuli - tra l'altro
- anche nel suggestivo Castello di Villalta, e a Bologna (Teatro
di S. Martino).
|
Torna
su
|
“La
Mala Educacion”
Analisi di un film
di Antonino Pingue
“La
Mala Educacion”, di Pedro Almòdovar è
un film che divide
“La Mala Educacion”, di Pedro Almodovar è
un film che divide. Usciti dal cinema avrete la sensazione
di aver visto un capolavoro (probabilmente non capendo il
perché), o sarete profondamente delusi. Il motivo è
presto detto: La Mala Educacion non spiega nulla e dice pochissimo.
Spinge dunque lo spettatore a speculare sul suo significato.
Cosa che non tutti sono disposti a fare. |
Sono
sempre molto scettico quando si tratta di decriptare gli intenti
di un artista. E’ raro, infatti, che un autore voglia
nascondere dentro la propria storia messaggi di carattere
profondo. Qualche grande autore fa eccezione. Me ne viene
in mente uno per tutti: Ingmar Bergman. Lo stesso Kubrick
sovente minimizzava le interpretazioni dei suoi esegeti. Non
c’è però alcun dubbio che per questo film
Almodovar ha voluto compiere un’operazione intellettuale
piuttosto complessa. Occorre dunque incamminarsi sulla strada
del recupero dei significati nascosti (sgradevole ma necessario).
Permettetemi almeno di farmi e farci una promessa: di fronte
a due scelte interpretative, prendiamo sempre quella più
semplice, e teniamo presente che in un percorso creativo spesso
il caso ha più rilevanza di quanto si pensi.
“La
Mala Educacion” e Nanni Moretti
Cominciamo col dire che il film è per stile e conduzione
molto simile ad un altro film uscito relativamente di recente:
“La stanza del Figlio”, di Nanni Moretti. Entrambe
le opere sono dirette con sguardo distaccato e lucido, senza
nulla concedere ad una qualsivoglia emozione. La storia è
scarna, quasi inesistente per Moretti, pretestuosa per Almodovar.
A livello narrativo è l’equivalente di un verbale
di polizia, pieno di particolari, ma privo di aggettivi e
di enfasi. Le ragioni di una simile scelta, sono chiare a
livello tecnico: si vuole parlare di categorie complesse e
alte, dunque un buon autore capisce che il massimo che può
fare… meglio: la cosa che è chiamato a fare,
è di mostrare ciò che ha osservato. Nel caso
di Moretti: la concretezza della morte. Se non avesse scelto
questo taglio, sarebbe apparso ridicolo o retorico.
La scelta ha però interessanti ricadute, in un mondo,
il nostro, dove il linguaggio è sempre più enfatico
e barocco. Punto.
Scomodiamo
queste alte categorie
Scomodiamo queste alte categorie: La Mala Educacion vuole
essere un film antologico e ontologico. Antologico perché
raccoglie in sé una serie di situazioni tipiche che
è molto raro poter riscontrare tutte insieme (sfido
chiunque a presentarmi qualcuno che conosca un travestito
con cui ha avuto un amore omosessuale da bambino mentre era
importunato da un pedofilo e che poi si è scopato il
fratello del travestito che si scopava anche il pedofilo che
si scopava suo fratello… ). Ontologico perché,
cito dal vocabolario: “studia le modalità fondamentali
dell’essere in quanto tale al di là delle sue
determinazioni particolari”.
L’Amore
A chiunque si lamenti che nel film manchi l’Amore adduco
questa impostazione ontologica a giustificazione. A chiunque
invece (esistono entrambe le correnti di pensiero) voglia
a tutti i costi rintracciarci l’Amore, faccio presente
che sostenere che il film parli dell’amore tra gli uomini
è sostenere che gli uomini che si amano sono delle
vere fetenzie. Il personaggio del regista è talmente
commosso dall’incontro con il suo vecchio amico che
lo mette alla porta come uno scocciatore. Veniamo a sapere
subito dopo che il nostro regista ha appena terminato una
relazione con il suo assistente, ed è così addolorato
che in capo a pochi giorni si trova un nuovo amante. Il prete
adora il bambino, vero, ma è un’adorazione tutta
fisica, e quando lo rivedrà dopo anni lo getterà
via come uno straccio preferendo suo fratello. Per il fratello
poi il sesso è pura merce di scambio. Infine, il travestito
che sembra amare solo le sue tette (su questo personaggio
sottolineerei soprattutto la mancanza di amore verso la madre
e verso il fratello). No, questo film decisamente non parla
d’amore, signore e signori.
Analizzare
i personaggi?
A mio parere non dobbiamo cadere nell’errore di scavare
nei personaggi perché essi sono estremamente inconsistenti,
poco più che iconici, ed è solo l’abilità
del regista a non farcene accorgere. Esempio: il prete. Se
dovessi giudicare il personaggio da sceneggiatore, lo definirei
poco approfondito, contraddittorio, superficiale. Perché
è prete? Cosa lo spinge a spretarsi? Possibile che
commetta un omicidio senza il minimo rimorso? Nessuno risponde
a queste domande.
La verità è che il volto del prete presta la
voce a due personaggi accomunati insieme per pura necessità
narrativa. Ma come, Almodòvar, attento osservatore
delle diversità, si confonde e ci descrive un pedofilo
che da vecchio diventa un amante d’aitanti ventenni?
Sono due categorie sessuali completamente diverse che non
coincidono. Il bambino è esile, magro, asessuato. Il
giovane è muscoloso, atletico, virile. Con il bambino
il prete è dominante e gode nell’essere dominante.
Con il ragazzo è invece il tipico vecchio dominato.
Nulla coincide.
Sappiamo benissimo che esistono parecchie decine di omosessualità
diverse e che queste fra loro non solo non si incontrano ma
spesso si guardano con sospetto.
Se giudichiamo i personaggi, non possiamo che concludere che
La Mala Educacion è un brutto film.
Dunque
uno sguardo ontologico
E veniamo allora all’ontologico. Possiamo affermare
che il film è ontologico perché ogni singola
scena mostra in maniera dettagliata le dinamiche di incontro
e di scontro tra diverse tipologie di uomini, che per quanto
diversi gli uni dagli altri sono tutti identici.
Tutti i personaggi maschili agiscono per ottenere potere sull’altro
maschio. Stabilire chi dei due è dominante. Stabilire
la posta in gioco e i reciproci interessi. Tutti potenzialmente
si odiano, ma accettano di condividere la medesima strada
apparentemente per un tornaconto personale e oggettivo (che
sia rubare una moto, lavorare, realizzare un sogno o una passione),
ma in realtà per puro spirito di competizione. Ossia:
chi molla la sfida è un vigliacco; chi non risponde
al colpo è una “femminuccia”. Nello stesso
identico modo, nel momento in cui uno di questi presupposti
viene a cadere, il rapporto decade e scompare nel nulla.
Una
scena infinitamente ripetuta
A ben vedere tutte le scene del film sono questa scena infinitamente
ripetuta: due maschi s’incontrano, ognuno ha qualcosa
che vuole dall’altro, e si instaura una lotta, senza
esclusione di colpi, per ottenere ciò che si vuole.
La scena più bella: quella in piscina. La scena più
rappresentativa: quella in camerino fra l’attore e il
travestito, scena in cui viene citato il titolo del film.
La
mamma
Ma la vera conferma che quanto dico potrebbe essere corretto
è l’analisi del personaggio della madre. Unica
donna che compare nel film, è anche l’unico personaggio
diverso a livello ontologico. E’ l’unico personaggio
che ama anche se nulla ha in cambio. E’ l’unica
che non controlla nessuno, e che ciò nonostante mantiene
il suo affetto. Un comportamento inconcepibile e, infatti,
in-concepito da tutti gli altri.
Il
ricatto
Non sottovalutiamo neanche il tema del ricatto e del riconoscimento.
I vari personaggi si caratterizzano per il continuo ricatto
e si riconoscono in misura dei loro ricatti, cioè della
loro capacità di imporre se stessi su gli altri.
Concludendo:
che cosa è “La Mala Educacion”?
E’ un film leggibile a più livelli, tutti comunque
riferibili a categorie generali.
E’ un film extra-narrativo; interessante se contrapposto
ai film iper-narrativi che sciacquettano nei cinema e nei
nostri videoregistratori.
E’ un film sugli uomini e sul loro modo di concepire
una qualsiasi forma d’interazione (spesso le scene di
sesso mi sono apparse puro simbolismo).
E’ un film sull’omosessualità, certo, ma
solo in parte. In questo senso ha due meriti, due grandi meriti.
Uno: indica come al di là dei ruoli il comportamento
di due uomini che vanno a letto insieme è sempre un
comportamento di uomini fra uomini, che abbiano o no le tette.
Due: mostra, omosessualità o non omosessualità,
l’altissimo grado sensuale che esiste fra gli uomini.
Gli uomini si seducono sempre: tra capo uffici e impiegati,
fra impiegati e facchini, questa seduzione, questa lotta continua,
estenuante, insensata, “MALEDUCATA”, non è
esente da richiami di carattere sessuale.
Almodovar
mette in scena l’uomo nella sua virilità intesa
come gabbia, eliminando ogni possibile sovrastruttura, ogni
possibile compromesso. Mette in scena l’uomo alla radice,
l’uomo tribale. E nel fare questo in realtà recupera
l’uomo come mito, restituendo anche una visione dell’omosessualità
mitica (e forse poco corrispondente al reale). Qualcuno in
questo ha voluto ravvisare l’amore maschile (ma le conseguenze
a pensarci bene sarebbero pesanti). Siamo dunque tutti Achille
che amano Patroclo e Patroclo che muore in battaglia per mano
di Ettore e Achille che uccide Ettore e trascina il suo cadavere
davanti a tutti, per trenta volte intorno alle mura di Troia,
per vendicarsi?
Forse…
Perdonateci, noi uomini siamo fatti così.
Commenti
al testo di voi soci |
| |
|
| |
 Ho
molto apprezzato l'analisi in oggetto, perché ci induce
a riflettere sui diversi punti di vista da cui si può
guardare a questo film inusuale, che sembra dire cose scontate
e ritrite mentre, in realtà, Antonino Pingue ne sottolinea
l'ansia di prevaricazione esistente fra gli uomini: male oscuro
da cui non sono esenti le donne, in un gran calderone di adrenalina
e slancio vitale. Ho
molto apprezzato l'analisi in oggetto, perché ci induce
a riflettere sui diversi punti di vista da cui si può
guardare a questo film inusuale, che sembra dire cose scontate
e ritrite mentre, in realtà, Antonino Pingue ne sottolinea
l'ansia di prevaricazione esistente fra gli uomini: male oscuro
da cui non sono esenti le donne, in un gran calderone di adrenalina
e slancio vitale.
Forse siamo stati costruiti per sopravvivere a tutti i costi,
anche con i mezzi più crudeli.
Franca Ayres
|
Torna
su
|
Quando abbiamo smesso di pensare?
di Irshad Manji
di Lorenzo L. Gallo
Personaggio
oggettivamente controverso, Irshad Manji ha una vita affascinante:
ugandese di origine indiana, fuggita in Canada con la famiglia
durante la dittatura di Idi Amin, è una scrittrice
omosessuale e musulmana. Da brava canadese, non si è
fatta scoraggiare da questa situazione difficile, volgendola
anzi a suo favore: proprio grazie al suo vissuto così
particolare, oggi è una giornalista e scrittrice nota
e apprezzata anche fuori dal suo Paese. |
Il
suo libro (un’opera prima) è una lettera aperta
ai musulmani del mondo che contiene un impietoso J’accuse;
secondo la studiosa, l’Islam sarebbe caduto nell’ultimo
secolo in una spirale integralista a causa del predominio
politico ed economico dell’Arabia saudita sugli altri
paesi musulmani non arabi, che pure contengono la stragrande
maggioranza della popolazione musulmana al mondo. L’Islam
saudita avrebbe imposto un modello integralista e repressivo
che non ha giustificazioni né storiche, né culturali
né tanto meno religiose, e che sarebbe basato su una
lettura del tutto parziale e arbitraria del Corano.
La Manji prende altre posizioni coraggiose difendendo Israele,
condannando il razzismo degli Arabi nei confronti di Ebrei
e Cristiani, e persino degli altri musulmani non arabi, e
criticando la gestione della causa palestinese da parte dell’attuale
leadership!
Si tratta dunque di un libro controverso, che infrange anche
i tabù di una parte della sinistra europea la quale,
in nome del multiculturalismo, rischia di accettare non solo
usi piuttosto innocui come il velo islamico ma anche la segregazione
e la sudditanza in cui vivono le donne musulmane anche in
occidente, tema di scottante attualità nelle grandi
comunità islamiche di paesi come Francia e Germania.
La Manji sostiene che l’Islam può essere riformato,
e anche se naturalmente tale riforma deve arrivare dall’interno,
gli occidentali possono aiutare i musulmani con una critica
costruttiva. Come questo messaggio possa essere recepito oggi
in Italia, nel mezzo delle nostre piccole guerre di religione,
rimane una questione aperta: per questo è sicuramente
un libro che vale la pena conoscere e dibattere.
Irshad
Manji: Quando abbiamo smesso di pensare?
Guanda, Parma 2004, 249 pp., € 12,50
|
|
Quattro
parole sul piacere di leggere
di Antonino Pingue
Per inaugurare il nostro Angolo, mi è
stato chiesto di scrivere una breve riflessione sul piacere
di leggere, e in particolare, visto che mi è capitato
di scrivere un libro per ragazzi pubblicato per Mursia, su
come invogliare i giovani alla lettura; annoso problema che
chi ha figli o nipotini conosce bene.
Cominciamo col dire che il libro per ragazzi è un settore
particolarmente vitale nel panorama editoriale italiano.
Secondo un'indagine commissionata dall'Associazione italiana
editori, nell'ultimo anno l'offerta è cresciuta ancora,
nonostante sia un periodo di crisi e di calo delle vendite.
Sono aumentati i seriali, i tascabili, e i libri per piccolissimi.
A cosa è dovuto questo successo?
Accade il fatto strano che i bambini italiani leggono più
dei loro genitori?
In parte sì, ma non solo.
Se infatti è vero che basta entrare in una libreria
e scoprire molti bambini spulciare, sfogliare, manomettere
libri (il segno specifico di un lettore in erba), è
anche vero che molti genitori comprano e leggono libri, ufficialmente
scritti per ragazzi. Harry Potter n'è
il caso più lampante ma non l'unico.
Dunque, al di là dell'età, la letteratura per
ragazzi funge da apri strada, da procacciatrice di nuovi lettori?
Probabilmente.
E infatti prolificano iniziative culturali per “educare
alla lettura”.
Ma siamo così sicuri che sia possibile educare alla
lettura?
Troppo spesso rannuvolati intellettuali pongono l'accento
sull'importanza di leggere, sull''importanza di farsi una
cultura (una cultura con la C maiuscola).
C'insegnano che per vivere meglio, per essere padroni della
situazione, per comprendere la vita, perfino per trovare in
futuro un buon posto di lavoro, bisogna leggere leggere leggere.
Insomma il romanzo viene accostato allo studio.
Leggere uguale studiare (con la S maiuscola). Non c'è
niente di più deleterio per scoraggiare un lettore
che inquadrare la narrativa all'interno di questo schema!
Dice Daniel Pennac in “Come un Romanzo”
(Feltrinelli): "Il verbo leggere non sopporta l'imperativo,
avversione che condivide con alcuni altri verbi: il verbo
“amare” e il verbo “sognare”".
A scuola, molto spesso, ci hanno fatto odiare questo strano
oggetto, colorato, odorante, rumoroso che è il libro.
Ci hanno spinto ad identificarlo con un qualcosa che assomiglia
al registro (quindi per default fuori dalla realtà).
Il libro, invece, è innanzi tutto un momento di divertimento.
Chi, come me, è un accanito lettore, sa benissimo che
la lettura è una specie di vizio, di febbriciattola
che qualcuno ti ha contagiato, esattamente come si contagia
il raffreddore. Per contatto, vicinanza, osmosi. Sappiamo
benissimo, inoltre, che come il raffreddore, o il morbillo
è difficilissimo riuscire a contagiarsi volontariamente.
Te lo becchi sempre quando meno te lo aspetti (proprio come
quando ci s'innamora...).
Un annetto fa su Rai tre in una trasmissione (“Parola
mia”, quella condotta da Rispoli), l'eminente (lo dico
con rispetto... con una punta d'ironia... ma con rispetto)
professor Gianluigi Beccaria, si è
lanciato in un discorso che cito più o meno alla lettera:
"Bisogna leggere, ma l'importante è leggere i
grandi classici, se dovete leggere questi nuovi romanzetti,
questa letteratura denominata fiction, è meglio che
lasciate perdere". Non vi nascondo che sono dovuto andare
a prendermi un bel bicchierone d'acqua (va beh, d'accordo…
era vino!) per riprendermi dallo scivolone che Beccaria in
quella circostanza (ancora una puntina d'ironia?) aveva preso
sparpagliandolo nell'etere televisivo.
Leggere, come correre o giocare a pallone, comporta un'infinità
di benefici, ma nessuno, dico nessuno, il venerdì sera
in procinto di uscire per una sana partita di calcetto si
sognerebbe mai di annunciare: "Mamma esco per andare
a stimolare i mie rapporti sociali, tonificare le gambe, e
affinare i riflessi", direbbe solamente (e giustamente):
"Vado a calcetto, forse torno tardi, non mi aspettare,
che dopo scatta una pizzettina post partita, bye bye!".
Quanto poi all'uso contrapposto di “classico”
e “fiction”, vorrei ricordare al prof. Beccaria
che un capolavoro (un classico prof.!) come “Il
circolo Pickwick” di Dickens
fu senz'altro anche un prodotto di fiction.
Uscì a dispense su un giornale a metà dell'ottocento,
e certo non fu scritto con impellenti bisogni d'erudizione
e di bellezza.
Racconta Dickens: "Ero un giovanotto di ventitre
anni quando gli editori Champman e Hall mi cercarono per propormi
di scrivere qualcosa da pubblicare a puntate al prezzo di
uno scellino per fascicolo. Accettai perché mi servivano
soldi per sposarmi e comprare casa". Dickens la
casa se la comprò, e come, e ciò nonostante
Pickwick rimane un capolavoro oltre ad essere fra i libri
più divertenti e mirabolanti che si può avere
occasione di leggere.
Bene, e con questo la finisco, con tante scuse a Beccaria,
e con l'augurio che chi non conosce il piacere del libro,
camminando per strada, o anche, perché no, in un'aula,
incontri accidentalmente un accanito lettore. I segni del
contagio sono rapidi e ineluttabili. … al primo libro
pensi sempre che sia un caso, al secondo ti senti solo un
pizzichino eccentrico. Il terzo? Non conta! Al quarto ti dici:
“ma sì, facciamo uno strappo”. Il quinto
è “una fase passeggera”. Poi scopri che
gli scaffali della tua stanza sono ormai pieni. Hai un attimo
di sbandamento, ma subito ti ripeti: “Posso smettere
quando voglio”. Ma due giorni dopo - non sai neanche
come – ti ritrovi dal ferramenta a comprarti quattro
scaffali, no, meglio cinque, da attaccare al muro, e 10 stop
da 8mm grazie, che devono reggere mucio peso, e allora
capisci che ci sei dentro, fino al collo ci sei dentro!
Non
mi resta che augurarci che da oggi in questo nostro Angolo,
dove appariranno recensioni scritte da tutti noi si contribuisca
a diffondere questa filosofia epidemiologica...
Ciao!
|
|
Recensione
de: "Scontrini: racconti in forma d’acquisto"
di Silvana Giancola
Curiosando
tra gli scaffali di una libreria di Via Cola di Rienzo mi
è capitato tra le mani un libercolo color arancione
dalla strana copertina e da un ancor più strano e imprevedibile
titolo: “Scontrini”: racconti in forma d’acquisto.
Una antologia di testimonianze autentiche curata da M.B. Bianchi
e V.Millefoglie sul mistero che unisce chi compra a chi ha
comprato.
I racconti che costituiscono la materia di questa raccolta
accostano narratori già noti a totali sconosciuti,
ad affermati pubblicitari, a ragazzi e bambini. Assolutamente
esilarante, forse perché conosco molti malati immaginari,
è quello di Alessandro Canale, autore teatrale e pubblicitario
che ha già pubblicato per Fernandel “Razza canina
e “Beoti gli ultimi”, stupidario esistenziale
in forma ritmica. Lo “scontrino” raccontato da
A. Canale è stato rilasciato da un ambulatorio dove
il pubblicitario si è recato con ansia indicibile per
farsi curare chissà quale male oscuro, sotto forma
di neo, che si è poi rivelato essere un volgare comedone…..uno
di quei grumi di grasso che le adolescenti si spremono quasi
giornalmente davanti allo specchio.
Lo stile dei racconti è fluido, colorito, discorsivo
per cui ne consiglio la lettura per un momento di piacevole
relax.
A
chi interessa si veda il sito www.scontrini.net
|
. |
|
HAIKU*
Roma invernale 2004
Nei capitelli
Stratificati a Roma
Grida l’inverno
Platani spogli
Puntano verso il cielo
Dita aperte
Sulle
cupole
Piega e distorce il vento
Ogni parola
L’ansia fa vela
Alle ‘nuove’ dal mondo
Acre di sangue
Come le stille
Vedo lacrime in croce
D’alberi a Roma
*
“genere poetico della letteratura giapponese, che consta
di soli tre versi di 5, 7 e 5 sillabe, e che ha trovato imitatori
nella poesia europea contemporanea, spec. in quella “pura”
francese e in quella italiana postdannunziana, miranti a una
essenzialità quasi epigrammatica” (definizione
dal “Vocabolario della lingua italiana (in 5 volumi)
- Treccani”
Ayres -che preferisce firmare con il suo pseudonimo che è
anche il suo secondo nome- aggiunge:
in Giappone
l'HAIKU proviene dal TANGA, composizione in versi 5-7-5-7-7,
i cui primi documenti risalgono al IV secolo. Nel XVII secolo
nasce l'HAIKU fissandone i versi in 5-7-5, espressione sintetica
e poco aggettivata delle sensazioni umane in rapporto al mondo
e viceversa. Praticamente è uno strumento che concentra
l'immagine nella nuda musicalità di poche parole, evitando
rime baciate, ampollosità, melodramma e quant'altro.
Nel Novecento è sorto l'HAIKU in stile libero e tutte
queste forme sono popolari non solo in Oriente ma anche negli
Stati Uniti e in altri paesi. [In Italia nel 1987 la Japan
Air Lines ha bandito il primo concorso di Haiku in italiano
e in latino].
Per uno scrittore è affascinante confrontarsi con una
metrica 5-7-5 di sole tre righe per esprimere un'emozione
e questi versi in forma di haiku di ROMA INVERNALE sono una
personale interpretazione di questa delicata e antica forma
d'arte.
Ayres
spera che altri soci WebTimeC proseguano “la catena
letteraria con i loro pensieri sugli stessi temi, formando
una ideale bacheca elettronica che non sia la solita chat
infarcita di messaggini spazzatura, ma un punto d'incontro
tra persone adulte e consapevoli, che si arricchiscono a vicenda
su argomenti specifici...”
|
|
| r |
|